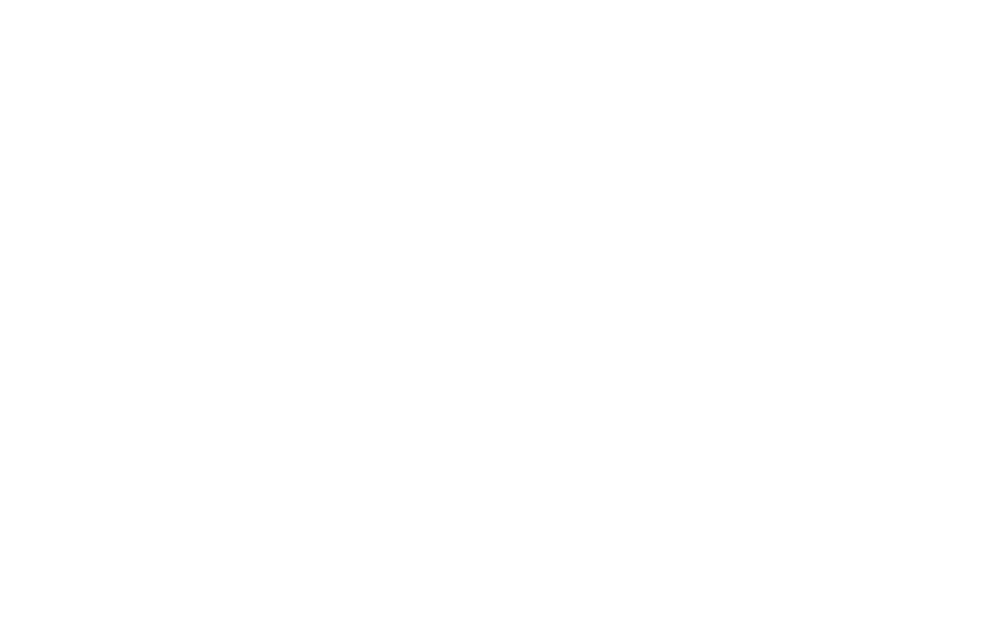Francesca Leotta e Federica Privitera, allieve dell’undicesima edizione del master “Il lavoro editoriale”, hanno intervistato Claudia Durastanti, finalista al Premio Strega 2019 con il libro La straniera (La nave di Teseo). Claudia Durastanti è stata ospite della Scuola del libro, insieme agli altri 11 candidati, in occasione della serata Effetto Strega, che si è svolta l’11 giugno 2019 presso WEGIL.
Scrivere di sé significa ripensare alla propria esistenza in termini narrativi e trovare delle metafore per raccontarla. Che tipo di operazione si deve fare quando si scrive un libro di impronta autobiografica?
La scrittrice Vivian Gornick, che oltre ad aver scritto alcuni dei libri autobiografici più rilevanti nella storia del genere è anche l’autrice che forse ha elaborato riflessioni più mature a riguardo, sostiene che quando si scrive di sé non bisogna mai dimenticare di essere un personaggio. Per me una dinamica narrativa va innescata e rispettata anche quando il sé è al centro di tutto, altrimenti, a meno che non si abbia la voce più seduttiva e incantatrice di sempre, il lettore si perde. Direi dunque che serve rispetto di sé come personaggio e capacità di fuoriuscire da sé, di diventare editor del proprio personaggio. In un saggio Gornick ha scritto che bisogna imparare a usare la quantità di «io» che è strettamente necessaria per far entrare il lettore in un testo (io direi una stanza) per richiamarlo, ma una volta entrato quell’«io» si può anche calmare, può venire meno o sparire. Nelle storie di sé che leggiamo questa proporzione di «io» non è mai la stessa, ed è il giusto dosaggio, che risponde a un’alchemica tutta personale dell’autore e irripetibile in un certo senso, a fare la differenza tra letteratura e narrativa confessionale. Poi aiuta avere una metafora, una mappa, un impianto: credo profondamente nella scrittura della propria vita che imita il romanzo e lo insegue e non viceversa. Si fatica di più con un romanzo che insegue la vita.
La struttura del romanzo non segue una cronologia precisa. Come hai calibrato la scrittura in funzione di questa idea di presentare i ricordi?
La decisione di scrivere La straniera è arrivata a 33 anni, gli anni che aveva mia madre quando si è trasferita in Basilicata con me e mio fratello e ha compiuto questa migrazione scellerata e al contrario che è stata il primo trauma della mia vita. È stato un momento intriso di simbolismi e di significati reconditi che volevo portare in superficie, da qui l’idea di affidarmi più all’oroscopo per la struttura del libro che al tempo. Anche perché il rapporto tra tempo, memoria e storia di sé non è mai lineare. Se descriviamo lo stesso episodio della nostra infanzia a vent’anni, a quaranta e a ottanta lo faremo con un lessico diverso, con una capacità di affondare in noi stessi molto più superficiale o approfondita in base alle circostanze del momento; si dice the future is not written ma the past is overwritten, Lo sovrascriviamo in continuazione, siamo cache temporanee, custodi di una memoria che è fragile e fallata e per questo assecondare la memoria in base a un criterio cronologico mi pare molto debole come scelta narrativa, che ha una sua consuetudine letteraria ma non mi persuade.
La formazione culturale della protagonista ha avuto una storia tutta particolare, distante dal rigore scolastico e immersa invece in momenti di lettura onnivori nella soffitta della casa in Basilicata. In che modo la non convenzionalità di questa formazione ha determinato la donna che poi è diventata?
Sono molto restia ancora oggi a dire «bisogna leggere questo», «è importante che un lettore si affidi a tale libro», pur sapendo che probabilmente la bellezza di una certa lettura gli cambierà la vita, perché per me leggere è stata l’attività più maleducata sperimentata nell’infanzia e anche nell’adolescenza, spesso marinando la scuola. Prima di diventare una pratica ordinata, anche di lavoro, molto meno selvatica e imprevedibile, c’è stato un momento in cui certi libri mi arrivavano quasi di contrabbando, dovevo inseguirli, andarmeli letteralmente a cacciare e rubare, e questo ha avuto un’influenza profonda su di me, nel senso che le esperienze più forti da lettrice e da scrittrice si sono consumate in uno spazio simile. Di profonda fame direi. Diventa più complesso continuare a fare e veicolare cultura in un contesto in cui questo istinto è venuto meno, ne sento ancora delle tracce nel mio modo di scrivere, ma sono vaghe, fantasmagoriche. Ma mi dispiacerebbe perdere del tutto l’idea di lettura come gesto di sfida personale, di emancipazione da un contesto ristretto e limitato, che poi secondo me è alla base di un’istintiva pedagogia. Chi si mette a leggere e scrivere lo fa perché ne ha bisogno e desiderio, infischiandosene di quel che è raccomandato, o va fatto.
Che ruolo hanno all’interno del libro i passaggi saggistici in cui rifletti di politica e classe? Facevano parte dell’idea originale o sono nati spontaneamente scrivendo?
Trattandosi di un libro su varie forme di silenzio e isolamento, mentre lo strutturavo era chiara in me la volontà di parlare del silenzio di mia madre, di una ragazza adolescente in una società meridionale, di una famiglia economicamente subalterna, e di intersecare tutte queste forme di margine. Sono stata spesso sollecitata sul rapporto tra scrittura e genere, o sul rapporto tra scrittura e lingua madre, ma meno sul rapporto tra scrittura e classe sociale, anche per via di una mia consapevole rimozione, ma era un altro elemento che volevo portare in superficie. Ho una serie di appartenenze, fluttuanti e contraddittorie, ma non posso parlare della mia educazione femminista senza parlare della mia educazione politica o di classe. Sarebbe una mutilazione, un lasciare la sagoma di me ben delineata nei contorni ma parzialmente vuota. E dunque affinché il libro fosse pieno dovevano esserci anche questi aspetti di esplicita auto-indagine, di recupero del rimosso. Non sono aspetti del tutto risolti, i capitoli Denaro e Amore sono ancora in fieri. Ci sono misteri che penso di aver risolto con la Straniera, e altri meno, ma mi piacciono anche i libri incompleti, dove qualcosa non torna. Definire a che classe sociale appartengo oggi che sono uscita dalla casa di mia madre è qualcosa che non torna.
Puoi indicarci un film o una canzone che riassumono il significato di ognuna delle voci dell’oroscopo – famiglia, viaggi, salute, lavoro & denaro e amore – in cui strutturi il tuo romanzo?
Famiglia: Guida per riconoscere i tuoi santi di Dito Montiel
Viaggi: Automatic for the people dei R.E.M
Salute: Marked di EMA; Stella was a diver degli Interpol
Denaro: Supreme di Angel Haze («triumph is nothing if it doesn’t come from tragedy»)
Amore: The Panic in Needle Park di Jerry Schatzberg
Qual è il tuo rapporto con la traduzione? In che modo vedi il duplice “spazio” linguistico che ti caratterizza e che è così fortemente presente nella tua scrittura?
Quando penso al mio lessico familiare, alla lingua che scambio con mia madre, oggi penso sempre alla lingua invisibile e sottostante che ci lega, quella non espressa o che va ricomposta perché troppo disordinata. La scrittura di romanzi e non-fiction è un modo per portarla in superficie, ma è comunque un’operazione limitata, che riguarda sempre me, sempre noi. Invece la traduzione mi permette di portare in superficie la lingua invisibile che appartiene a un altro autore, a un’altra storia, a un altro mondo. Si tratta sempre di essere una palombara in un certo senso, ma una palombara in un oceano alieno. E questo è un privilegio, ogni volta riemergo con una visione più ampia e meravigliata del mondo. Che è quello che fa un buon libro. Tradurre in un certo senso è un atto di lettura amplificata, sotto una specie di LSD, in cui entriamo in contatto con zone misteriose e ancora inesplorate della lingua, in cui monitoriamo cosa ci succede quando una frase ci trasforma. Non saprei più scrivere senza questo tipo di lettura ed esperienza, senza una lingua invisibile sottostante che ribolle e senza creare le crepe per farla affiorare.