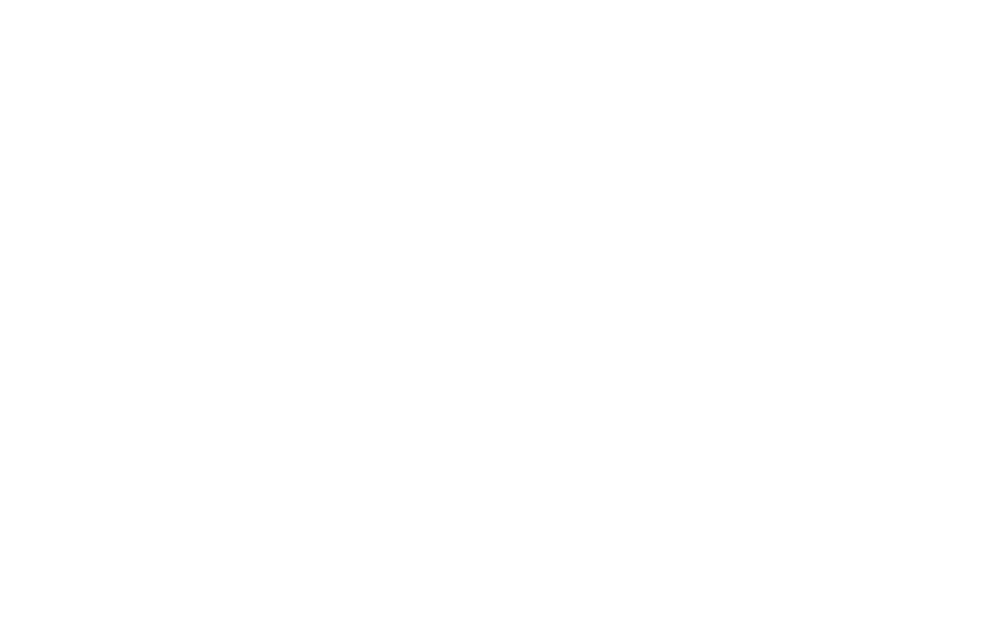«Una delle mie più grandi gioie è riuscire a migliorare i racconti dei miei corsisti».
Abbiamo fatto una chiacchierata con i docenti dei corsi di scrittura e di editoria per scoprire qualcosa di più sui loro mestieri, le abitudini e i maestri che li hanno ispirati. E per sapere da loro perché frequentare un corso può essere davvero utile.
Come ti prepari alla stesura di un libro? Hai dei rituali, delle abitudini?
Essendo il lavoro dello scrittore essenzialmente cerebrale, in mancanza di un rapporto materico con la propria arte che è impalpabile (si pensi invece alla corporeità di discipline come la pittura o il ballo), allora si tenta di porre l’accento su tutto quello che è di contorno, lo studio, il tavolo, le penne, i blocchi, in molti casi nevrotizzandolo. È un meccanismo che capisco ma di cui non sono vittima: scrivo dappertutto, mi basta avere con me testa e viscere, ed è molto improbabile che non mi seguano ovunque io vada.
Dove trovi ispirazione per le tue storie?
Vorrei sfatare alcuni luoghi comuni. Innanzitutto l’espressione: “Le storie sono intorno a noi”. No, le uniche storie che vale la pena di raccontare sono dentro di noi, e trovare una storia non è come trovare, chessò, un portafoglio sul marciapiede, che lo raccatti, te lo metti in tasca e via. Le storie scaturiscono dalle ossessioni – intendo pure le cose comunemente ritenute volgari, come la trama – e hanno bisogno di cura per essere estratte da là dentro. Uno dei veri problemi legati alla scrittura è proprio questo: qual è una storia veramente importante per me, che ho la necessità di esprimere, prima ancora di raccontare? Questo è anche il motivo per cui non ha senso quantificare il tempo di stesura di un libro, le varie dichiarazioni che leggo “Questo libro mi ha impegnato per tre, quattro, cinque anni…”, perché la scrittura effettiva è solo una parte del lavoro, e non la più lunga né la più faticosa.

Quando hai pubblicato il primo libro? È stato difficile?
Il primissimo libro di racconti era un calco da Bukowski ed è rimasto inedito. È una lezione importante: all’inizio imitare gli autori che ci piacciono può essere un modo per vincere il terrore della pagina bianca e capire se siamo portati, fondamentale però è saperli uccidere, superarli, approdare a una voce nostra. Dopo questo tentativo ho cominciato a pubblicare su rivista – alla fine degli anni novanta del secolo scorso c’erano ancora le riviste di carta, le librerie avevano degli spazi appositi per le riviste -, soprattutto su Addictions, una rivista milanese. C’erano Leonardo Pelo e Raul Montanari. Sandro Ossola. Andrea Pinketts sempre ubriaco al bar Le Trottoir. La rivista cominciò a pubblicare i suoi primi libri, e così nel 2000 uscirono in volume anche i miei racconti, quello che per me è equivalso a una specie di demo, che girò un po’ tra gli addetti ai lavori. Ho continuato a lavorare sottotraccia per diversi anni, finché nel 2006 Einaudi non pubblico L’amore e altre forme d’odio. Avvenne tutto rapidamente, l’estate di un anno prima: Guido Davico Bonino lesse i miei racconti e chiamò Lietta Manganelli, la quale chiamò me. Una settimana dopo ero a Torino. Ma non ci sarebbe stato niente se io non avessi scritto – imparato a scrivere – in solitaria per quattro o cinque anni. L’ostinazione è un valore letterario. Mi sono fatto la gavetta, e la ritengo una fortuna: ti tempra, è una gran maestra.
Hai iniziato la tua carriera pubblicando raccolte di racconti. Consiglieresti agli aspiranti scrittori il tuo stesso percorso? Quanto consenso trovano i racconti nel panorama editoriale italiano?

Sono un tipo strano, forse un po’ masochista. Nel 2006 infatti Einaudi mi fece il contratto per due libri. Uno per i racconti e uno per un romanzo breve (La persecuzione del rigorista: in realtà un racconto lungo, ma sicuramente di più facile collocazione e smerciabilità). Mi dissero che avrei potuto scegliere io con quale partire: e io, appunto, scelsi i racconti, perché mi sembravano più rappresentativi della mia voce, perché li preferivo. Chiunque direbbe che ho sbagliato, che l’esordio me lo sarei dovuto giocare con il testo più lungo, proprio perché la considerazione dei racconti in Italia è scarsa. Basta vedere come vengono trattati i libri di racconti dai premi letterari. Manca la legittimazione mainstream, quella appunto in grado di dire al grande pubblico: i racconti sono belli, leggeteli. Invece oggi il libro di racconti viene percepito come un prodotto elitario, per palati fini, che parla una lingua diversa da quella del romanzo. Ma ogni scrittore fa storia a sé ed è giusto che segua la propria indole, anche a costo di commettere un errore strategico. Tradire la tua propensione sarebbe molto peggio.
Quali sono i tuoi maestri di scrittura, i tuoi punti di riferimento?
In principio ci fu Maupassant. Me ne andavo sempre a zonzo con una copia Oscar Mondadori dei suoi contes fantastique. Ascoltavo parecchio punk e heavy-metal all’epoca, e ricordo che mentre leggevo pensavo: “Finalmente ho trovato qualcosa che si avvicina al piacere che mi dà la musica”. Diciamo che sono abbastanza vecchio per essere riuscito ad ammazzare tutti i miei padri letterari: Thomas Bernhard, Dino Buzzati, Raymond Carver. Ma certo resto influenzabile da qualsiasi cosa, per fortuna. Mettere a fuoco la propria voce non significa chiudersi al mondo, sigillarsi dentro una poetica come se fosse una bara. Proprio perché so che tipo di scrittore sono (un tipaccio…) non ho nessuna paura a restare con le antenne ben dritte, a leggere, guardare, ascoltare. È un segno di forza, e non di debolezza. Essere un fruitore d’arte nel senso più ampio e trasversale possibile mi servirà a scrivere. Scrivere a modo mio.
Quanto di autobiografico finisce nelle tue storie? E perché?
La letteratura non può mai non parlare di chi la scrive, ma non in un senso meramente autobiografico. I miei libri parlano di me anche se non raccontano episodi della mia vita. Non so perché ci sia questa voglia di realtà nei libri di letteratura. Forse perché ormai sappiamo che chiunque mente nella vita, e allora come bilanciamento ci obblighiamo alla sincerità nell’arte. Che poi essere sinceri non vuol dire occuparsi della realtà che, a sua volta, non vuol dire occuparsi della verità: ma tutti tendono a pensarlo. In ogni caso la vedo come una deriva: uno degli elementi costitutivi della letteratura è la menzogna, intesa come invenzione arbitraria, capacità immaginativa e campo dell’ipotetico. D’altronde anche ogni scrittura autobiografica degna di questo nome, per essere minimamente congrua sul piano letterario, deve essere inventata. Ho mentito, quindi ho parlato di me.
Perché pensi sia utile frequentare un corso di scrittura? E perché proprio il tuo?
Una delle mie più grandi gioie – intendo proprio una soddisfazione piena e squillante che perdura nel tempo – è riuscire a migliorare i racconti dei miei corsisti. La maggior parte della roba che mi capita di leggere infatti può essere sensibilmente migliorata, basta che il mio sguardo esterno dia un piccolo cambio di prospettiva. A volte si tratta di anticipare o posticipare alcune scene, rimodulando l’intero sviluppo drammatico, altre volte i personaggi non sono messi bene a fuoco, mentre in altri casi ancora a zoppicare è il rapporto che la storia dovrebbe intrattenere con lo spazio o il tempo. Uno dei difetti che continuano a sorprendermi quando leggo gli elaborati degli allievi in classe è la mancanza del senso del racconto. Leggo pagine che suonano anche bene, ma completamente inerti. Il motivo? Non c’è nessuna dinamica narrativa in atto, nessun buono contro nessun cattivo, nessun conflitto, nessuna minaccia, nessun enigma. Saper scrivere non significa soltanto scrivere bene… Insomma è una vera gioia migliorare un racconto fino a vederlo funzionare, è una cosa tangibile, è il motivo che ogni volta mi fa dire: “Insegnare a scrivere non si può, ma frequentare un corso di scrittura può essere estremamente utile”.