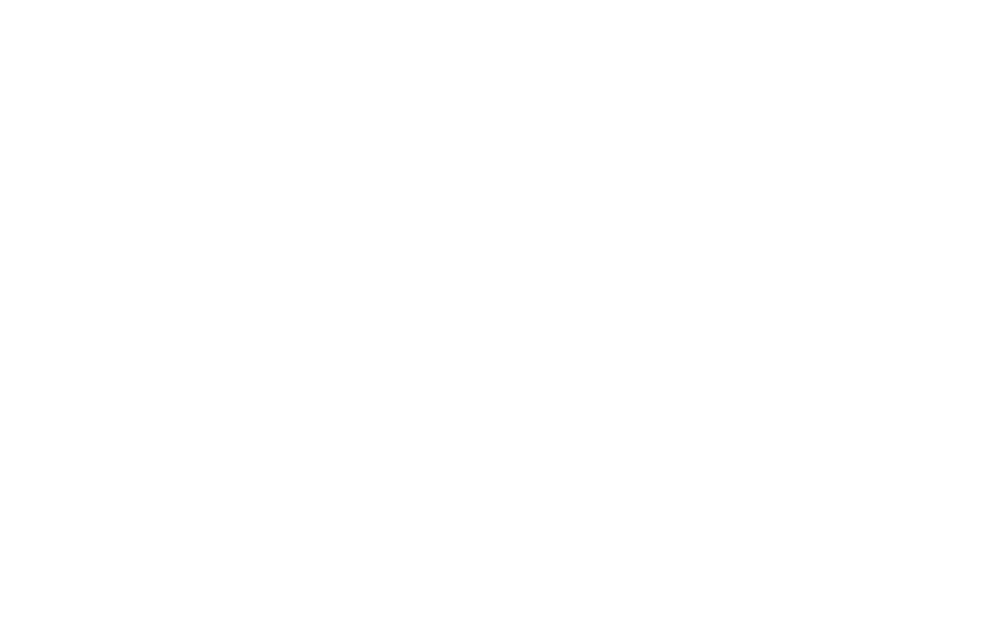Andrea Cappuccini e Chiara Mogetti, allievi dell’undicesima edizione del master «Il lavoro editoriale», hanno intervistato Paola Cereda, candidata al Premio Strega 2019 con il libro «Quella metà di noi» (Giulio Perrone editore). Paola Cereda è stata ospite della Scuola del libro, insieme agli altri 11 candidati, in occasione della serata Effetto Strega, che si è svolta l’11 giugno 2019 presso WE GIL.
“Quella metà di noi” ci sembra rappresentare quella parte dei nostri vissuti che teniamo segreta, che non raccontiamo a nessuno o, forse, soltanto a noi stessi. Qual è, per te, il rapporto tra questi vissuti e la narrazione?
I segreti sono verità parziali oppure omissioni che lasciano dei vuoti nella comunicazione, immediatamente sostituiti da storie che ognuno di noi si racconta per colmare gli spazi bianchi. Nella parzialità, nell’omissione e nei nostri (spesso goffi) tentativi di colmare i non detti con delle narrazioni personali, c’è un interessante mondo di fughe, incomprensioni e versioni non coincidenti. Ed è in questa terra di mezzo che ho voluto lavorare, indossando le lenti della complessità sia nell’osservare le relazioni sia nel raccontarle. Siamo molto di più della somma di fattori semplici.
Barriera di Milano è un quartiere centrale della storia. È un quartiere che trova collocazione all’interno di una geografia umana, economica, sociale. Cosa significa per i tuoi personaggi viverci? Cosa ci dice del loro e, soprattutto, del nostro mondo?
Quando scrivo, parto sempre dal paesaggio, cioè dai luoghi, dalle persone e dalle relazioni. Il paesaggio mi permette di lavorare sulle caratteristiche, sui caratteri e sui linguaggi dei personaggi, per analogia o per rottura con il contesto che, sempre, forma e deforma. Lo studio del paesaggio mi prende sei/otto mesi di lavoro. Si tratta di studiarlo da un punto di vista storico, geografico, antropologico, e poi di andare nei luoghi per osservare colori e spazi, respirare atmosfere e odori e chiedere alle persone: “Mi racconti il tuo paesaggio? Ciò che è significativo per te, in base alla tua storia”. La costruzione di mappe geografiche, affettive e relazionali è una parte meravigliosa del lavoro di scrittura. È aprirsi all’ignoto mano nella mano con soggetti competenti che mi accompagnano dentro uno spazio, per poi lasciarmi andare nel mondo più incerto della creazione letteraria.
I personaggi del tuo romanzo o hanno difficoltà a raccontarsi o scelgono di non farlo. Cosa sono per te questi silenzi, queste aree di riserbo, e, talvolta, questa incomunicabilità, che sembrano essere tanto più inviolabili quanto più siamo vicini a qualcuno?
In questo romanzo avevo alcuni obiettivi, tra gli altri raccontare la parte di noi che di solito non postiamo sui social. Sui social mostriamo i momenti di felicità assoluta o i grandi dolori, ma mai le terre di mezzo che, però, sono la parte più grande dell’iceberg. Una delle funzioni possibili della letteratura è quella di consolare: in “Quella metà di noi” ho volutamente accantonato questa possibilità per concentrarmi sulle relazioni umane che ci legano al di là o nonostante l’amore. Non è stato semplice: io stessa avrei voluto spingere i personaggi ad aprirsi, a liberarsi, però ho provato a prestare loro la voce e non le intenzioni. Li ho lasciati liberi di essere e di non essere. A volte sarebbe utile farlo anche nella vita di tutti i giorni eppure è proprio lì che spesso inciampiamo.
Matilde si prende cura: del vicino di casa, dei sogni di Amedeo; soprattutto, il suo è un lavoro di cura. Ci puoi raccontare cos’è per te la cura, in particolare nel suo legame con il lavoro, da una parte, e con la cura di sé, dei propri bisogni e dei propri desideri dall’altra?
La cura, per me, è “il tempo dedicato alla tua rosa”, proprio come dice Antoine de Saint-Exupéry. Il lavoro di cura richiede un grande investimento fisico, emotivo e temporale: ci svuotiamo quando diamo senza tenere in considerazione la necessità di prenderci cura di noi, per “ricaricare il sistema”. Nel sociale si parla di burnout quando la cura dell’altro travolge la persona, svuotandola. Quindi la cura è tempo dedicato alla tua rosa, certo, ma anche tempo di silenzio, lontananza, pensiero e ritorno. Il romanzo, tra le altre cose, punta l’attenzione sui cambiamenti sociali del nostro tempo: una volta si ereditavano un cognome e una casa “in cambio” del dovere della cura. Oggi si eredita un cognome, a volte si eredita una casa, ma la cura non è più un dovere: è un bene che si compra e si vende. Viviamo in mezzo a relazioni a contratto: lo sono quelle tra badante e badato, certo, ma lo sono anche quelle familiari e affettive. Esiste un’economia degli affetti e ho provato a raccontarla scavando nel concetto di cura.
Il tuo romanzo nasce da storie vere, da relazioni intessute realmente. Che effetto ha avuto questo aspetto della tua riflessione sul tuo lavoro e, in particolare, su un’altra relazione importante per la nascita di un romanzo: quella con il/la tuo/a editor? Che ruolo hanno avuto il/la tuo/a editor e il tuo rapporto con lui/lei nella costruzione del romanzo?
Siamo tutti portatori sani di storie: alcune personali e altre che costruiamo nell’incontro con gli altri. Io lavoro sulla verità narrativa, cioè su come la gente si racconta la sua propria storia. Non mi importa che la versione sia vera o falsa, mi importa capire perché è utile a chi la racconta. Raccolgo molte storie e poi le trasformo, in parte per tutelare chi me le ha regalate, in parte perché il mio è un lavoro creativo e di immaginazione, proprio come quello dello chef che dosa gli ingredienti per farne un piatto ricco di sapore.
Per quanto riguarda il romanzo, sono alla quinta pubblicazione: tre romanzi su cinque sono stati pubblicati da case editrici molto più grandi di Giulio Perrone Editore (Piemme, Baldini + Castoldi). Nel lavoro con Mariacarmela Leto, editor di Perrone, ho trovato alcuni stimoli nuovi. Mariacarmela mi ha incoraggiata a liberarmi dalla necessità di un lieto fine, per esempio, o dal dovere di accompagnare il lettore: “Vogliamo lettori che abbiamo voglia di fare fatica”, mi ha detto. Desiderosi cioè di lavorare in maniera autonoma tra le righe dei non detti e di gestire da sé la relazione con personaggi spinosi, che non tendono la mano. È un rischio: puoi amare o detestare la mia scrittura e la mia storia. È successo e succederà, e lo accetto. Quando scrivo voglio provare meraviglia. Voglio fare anche io, proprio come il lettore, la fatica di andare verso la possibilità di scoprire, riuscire o fallire.