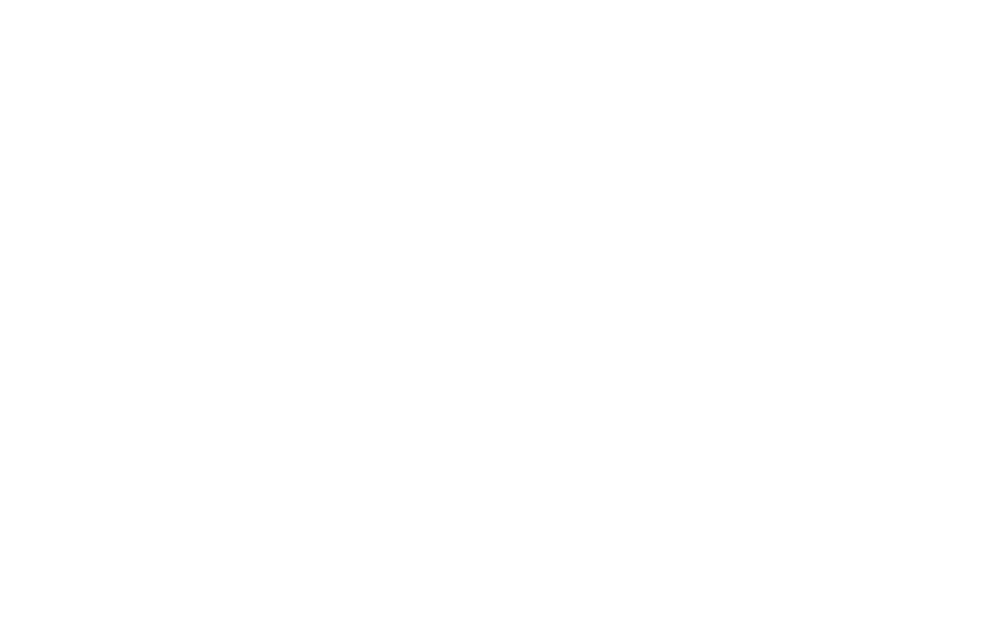Ilaria Barazzuol ed Eleonora Daniel, allieve dell’undicesima edizione del master «Il lavoro editoriale», hanno intervistato Marina Mander, candidata al Premio Strega 2019 con il libro L’età straniera (Marsilio Editori). Marina Mander è stata ospite della Scuola del libro, insieme agli altri 11 candidati, in occasione della serata Effetto Strega, che si è svolta l’11 giugno 2019 presso WE GIL.
L’età straniera è un romanzo che parla dell’estraneità come irriducibilità e impossibilità di appiattimento. Riconoscere ciò che rende l’altro diverso da sé è l’unico modo per conoscersi, fare e farsi del bene, crescere, abitarsi. Ha detto che tutti i suoi libri nascono da una domanda. Può spiegarci da quale domanda questo libro prende le mosse?
La domanda è: «Chi fa bene a chi?». Quando ci si trova di fronte a una persona in difficoltà è cosa umana e buona e giusta cercare di aiutarla, ma, affinché i moti dell’anima si trasformino in un fare consapevole, è necessario interrogarsi anche sui propri bisogni: riconoscere i propri bisogni è il primo passo per confrontarsi con i bisogni dell’altro in modo non spontaneistico. Questo, a dire il vero, vale per tutte le relazioni.
Il linguaggio del protagonista è provocatorio, ironico e a tratti politicamente scorretto. Quanto crede sia necessario che la letteratura restituisca voci tanto irriverenti e qual è l’effetto che, con le stesse voci, vuole ottenere nel lettore?
Perbenismo linguistico e conformismo morale vanno a braccetto. Leo è un diciassettenne arrabbiato e complicato che si domanda se i valori che il mondo adulto gli propone siano valori onestamente perseguibili, quanto siano necessari i compromessi per diventare “grande”; è naturalmente dissacrante perché ha ancora un senso utopico del bene e del male: l’ironia è anche un modo per proteggersi. E poi il come, in narrativa, deve essere analogo al cosa, la voce di Leo non poteva essere diversa, fragile e spavalda al tempo stesso. Non è una questione di quanto sia necessario che la letteratura restituisca voci irriverenti, quando che la voce deve rispondere a una coerenza interna al romanzo. Nessuna intenzione di épater la bourgeoisie, ma la parola deve essere incarnata nel personaggio. Umberto Eco, in una esilarante satira delle parafrasi educate apparsa in una Bustina di Minerva del 2000, proponeva un esperimento: «La invito a recarsi colà dove potrebbe qualificarsi come partner passivo di un rapporto tra maschi adulti consenzienti». Avrebbe potuto Leo, esprimersi così?
Il sonniloquismo è una parasonnia, uno dei vari stratagemmi che il cervello escogita per non darsi pace nemmeno di notte. Leo, nel sonno, si sottopone costantemente al processo di un tribunale immaginifico e spietato che lo accusa di non aver fatto nulla per salvare suo padre. Quando è stato concepito il livello onirico del romanzo? Ne è stato parte integrante fin dalla prima stesura o è stato sviluppato a posteriori?
L’idea del tribunale della coscienza è nata insieme al personaggio di Leo, un ragazzo che, mentre sul piano del reale fa fatica a collocarsi e ciondola da un divano all’altro, sul piano dell’immaginario è costantemente impegnato a mettere in crisi se stesso e il mondo. La dimensione onirica mi ha permesso di raccontare, con il linguaggio surreale dei sogni, i conflitti tra istanze superegoiche e tentativi di individuazione.
In passato è stata counselor per la prostituzione maschile minorile a Milano. Quanto è stato necessario condividere questa esperienza nel lavoro svolto con il suo editor? Qual è il processo che l’ha portata alla costruzione e allo sviluppo di Florin?
La mia esperienza con la prostituzione minorile di strada è stata fondamentale non solo nella costruzione del personaggio di Florin, che in qualche modo rappresenta la summa di tanti racconti e incontri, ma alla nascita del romanzo stesso. Se non avessi visto e parlato con i ragazzi, non avrei mai saputo scrivere di un argomento così poco conosciuto. Dall’esperienza poi, nel tempo, è nato il romanzo, e non c’è stato bisogno di condividere con l’editor particolari dati di realtà perché quando l’editor ha letto il romanzo, entrambe le esperienze, di vita e di scrittura, erano già concluse.
Nominare è un modo di tenere sotto controllo un mondo che sfugge, un modo per scavarsi un solco al suo interno e cercare di sfuggire alle onde. È questo la scrittura? Ha anche lei, come Leo, parole preferite e parole da lista nera?
Scrivere è un tentativo di mettere un po’ di ordine nel caos del mondo immergendosi nel caos; le parole, quando si trovano parole che sembrano significative, sono piccole boe alle quali aggrapparsi. Naturalmente, le parole preferite e odiate di Leo sono le mie, a cui aggiungerei in lista nera: empatia, resilienza, quoziente emotivo, narrazione… parole che vanno molto di moda e che spesso nascondono una fregatura. Amo invece le parole con la elle, libellula, allodola, lillipuziano… parole fragili che mi riportano alla lallazione, all’enfant caché che c’è in me.