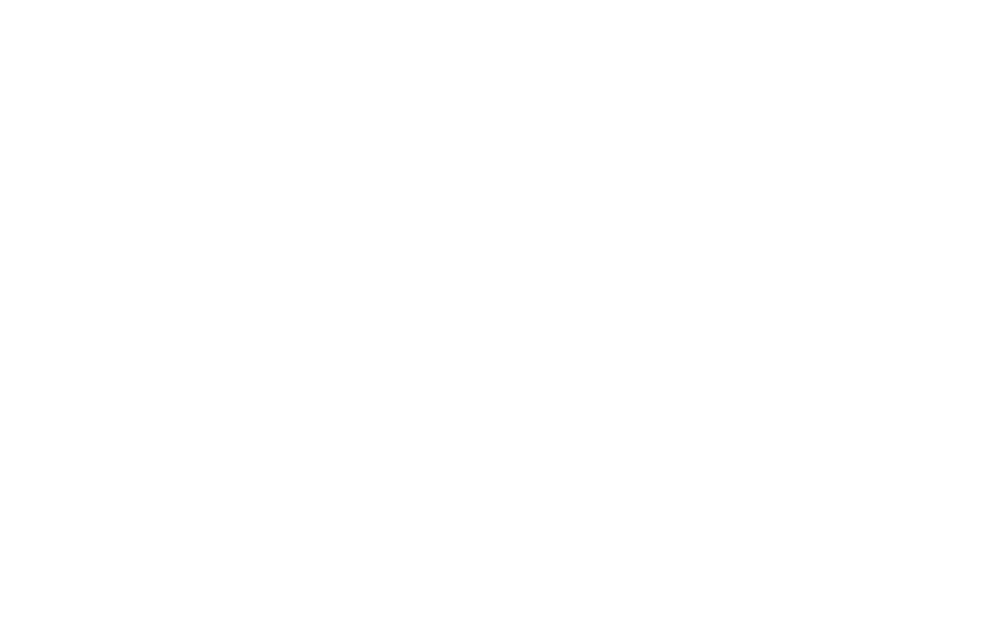A cura di: Serena Savatonio, Maria Chiara Truttero, Bianca Martino (Scuola del libro), Filippo Zannoni, Dafne Valerii, Aurora Fantone, Giulia Guidarelli
Una tartaruga non deve traslocare, non deve mai cambiare casa: la casa se la costruisce addosso e addosso se la porta, piano piano, ovunque vada.
Lo stesso non vale per Io, che deve portare il suo nudo corpo umano di casa in casa, dall’infanzia all’età adulta, condividendo affitti temporanei con i suoi simili – spesso così diversi da lui –, costruendo convivenze e teatri dove le scenografie sono fatte di mobili, ante ed elettrodomestici, e i copioni sono tutti improvvisati sempre sugli stessi logori canovacci.
Grazie a una scrittura poetica e al contempo catastale, attraversiamo luoghi fisici come «la casa sopra i tetti» e metaforici come «la casa del persempre». Questi luoghi sono interconnessi tra loro in una prospettiva dentro/fuori continua, che dà una dimensione corale e insieme solitaria.
Io cambia quartiere, cambia città, cambia strato sociale, ma il suo unico e vero rifugio restano le pareti di parole che instancabilmente erige sulle schermate bianche del suo portatile, giorno dopo giorno, a passo di tartaruga, costruendo una corazza paradossale fatta di spaziature e caratteri.
Bajani: Posso dire wow?
Mari: Ci piace questa risposta, eravamo un po’ preoccupate che sparisse l’atmosfera creata dal libro.
Bajani: No, è una risposta di pura ammirazione perché è un libro così destrutturato, che va così tanto a salti nel tempo e nello spazio, che poi è quasi più facile da leggere che da raccontare. E poi siete riuscite ad andare al punto di questa storia, sia della scrittura che di quello che conta: il nudo corpo (anche se poi è vestito), che Io si porta dietro a mo’ di tartaruga, anche se il carapace è ogni volta differente. Complimenti perché è una perfetta bandella editoriale.
Bianca: Buonasera, Andrea. Questa prima domanda è stata principalmente pensata da me, Serena e Mari, però poi, in seguito all’incontro con le scuole, ci siamo rese conto che era molto in sintonia anche con un’altra domanda di Filippo, che prenderà la parola alla fine per fare una precisazione. Il percorso di ricostruzione degli ambienti e del vissuto di Io ricorda una ricerca catastale e possiamo definirlo quasi uno scavo archeologico. Sappiamo che l’idea è nata da una semplice lista fatta un po’ di getto delle case in cui ha vissuto. Volevamo sapere se si è basato solo sulla sua memoria o se ha utilizzato altri supporti, come fotografie, appunti, video, oggetti conservati o anche ritrovati.
Filippo: Io aggiungerò la seconda parte della domanda, sorta durante la lettura, a proposito delle numerose case descritte. Vorremmo sapere se queste case siano effettivamente concrete, reali, o se siano piuttosto immaginate dalla memoria, frutto di frammenti, di ricordi o di sensazioni di una vita passata. Quasi invisibili ma costruite dalla memoria e quindi non concrete, reali in un tempo e in uno spazio.
Bajani: Grazie per averci speso del tempo e per essere entrati in questa specie di labirinto che ho costruito insieme a me. Alla fine, ci si rende conto dei libri anche quando sono labirinti dai quale non necessariamente uno vuole uscire, basta abitarli bene. Mi è piaciuto molto il riferimento all’archeologia, e credo che poi l’archeologia serva anche per provare un po’ a rispondere alla domanda che mi fate, ammesso che io sappia rispondere, nel senso che gli scrittori non sempre sanno tutto delle cose che hanno scritto. Questo è un libro in qualche modo archeologico. Il grande fascino dell’archeologia, che viene un po’ considerata o noiosa o una faccenda dell’antichità, è proprio questo, che gli archeologi si mettono lì e, a partire da un pezzo di muro, da un reperto che trovano, il frammento di un’anfora, devono ricostruire delle vite intere –che detta così bene, la storia dell’archeologia. Quando però provi a pensare a che cosa significa ricostruire una vita intera a partire da un pezzo di muro, se provi non a dire la frase «costruire delle vite intere», ma provi a ricostruire cosa succedeva a cena, dove andavano a dormire, come si svegliavano alla mattina, come stavano insieme, allora l’archeologia diventa immediatamente qualcosa di estremamente caldo; diventa la base in fondo di quello che facciamo tutti i giorni senza rendercene conto, quando entriamo a casa di qualcuno, quando andiamo in un posto, non necessariamente al chiuso ma anche all’aperto, vediamo un posto e proviamo a immaginare che cosa c’è.
Io in questo momento vi parlo da Houston e ho davanti a me una scuola e immagino, non so cosa succeda dentro, ma sto facendo dell’archeologia del super-contemporaneo, di ciò che sta lì fuori. Però da lì posso immaginare, sentire le voci dei bambini, posso immaginare che siano quasi tutti senza mascherina perché sono ancora bambini tranne le maestre che hanno la mascherina, ecc. Allora ti rendi conto che dentro questa prospettiva archeologica c’è al tempo stesso qualcosa di intimissimo e qualcosa di più epocale, di più architettonico, sociale, di una comunità, ecc. Quello che ho fatto io, in realtà, è stato andare a fare un piccolo scavetto archeologico. Ora, le case sono reali o no? Questa è una bella domanda a cui faccio fatica a rispondere – non per reticenza. Sì, naturalmente tutto è partito dalle case reali, è partito dalle mie case. Addirittura, è partito dal tentativo di andare a rivedere la casa in cui ho passato i miei primi anni. Un tentativo riuscito e fallito perché mi fecero entrare, la visitai, fu una specie di disastro emotivo perché le persone che ci vivevano dentro avevano una specie di imbarazzo ad abitare nel posto in cui c’era un così grosso, quasi patetico, attaccamento. Quando poi andai a vederla, a visitare questa casa, cominciai a prendere i primi appunti. Il momento in cui cominciò davvero il libro fu quando, come avete notato, cominciai ad appuntarmi la lista di queste case, le case in cui avevo effettivamente vissuto. Quindi sì, le case sono reali, molte di loro lo sono, e da lì comincia a complicarsi la cosa. Nel momento in cui la casa in cui ho abitato, e quindi una casa reale, emotiva, biografica, viene chiamata «casa del sottosuolo», quella casa lì, la casa reale, diventa immediatamente un personaggio, diventa immediatamente qualcos’altro. Evidentemente era la mia casa ed evidentemente era il tentativo di raccoglierne alcuni frammenti. Inizialmente è nato così: raccogliere alcuni frammenti delle case in cui avevo vissuto e provare a ricostruirli in un puzzle. Però poi sono venuti fuori i nomi delle case, le case erano diverse e «la casa del sottosuolo», «la casa sopra i tetti», che già diventano una favola. Non dico: «sono entrato a casa mia» no, dico: «Io entra nella casa del sottosuolo». Lì poi succede che si mette di mezzo quella specie di miracolo che è la scrittura, perché poi la scrittura ti porta in territori inesplorati nel momento in cui provi a dire che quella casa lì è «la casa del sottosuolo» e che Io entra lì dentro. Lì scrivendo cominci a vedere non nella memoria, che è puramente conservativa. Parti dalla memoria per dire: «ok, c’è questa casa qua che stava in quel posto, ho questa memoria, posso addirittura tracciarne una maldestra piantina, a penna prima ancora che nel catasto», ma poi quando si scrive si va avanti, non si va indietro, non si dà soltanto parola a quello che si è già vissuto. La scrittura va, e se io metto Io, che è un bambino, lo deposito in uno spazio memoriale, a depositarlo in una casa, e poi comincia a girare e vede la scrittura, vede delle cose che succedono lì – succedono nella scrittura –, e quindi automaticamente questo fatto tra cosa è reale e cosa non lo è si moltiplica. Quindi sì, prendo degli elementi reali della mia vita, sia immobiliare sia biografica, e ne costruisco poi qualcosa che mi farebbe dire «forse (per finire di rispondere alla domanda sul reale) sono vere ma non necessariamente sono reali». C’è una grande differenza tra ciò che è reale e ciò che è vero. Un dato reale è un dato che hai vissuto, concretamente, e però tu puoi raccontare (questa è la grande sfida di molti scrittori). Puoi provare a raccontare un dato di realtà, un episodio che hai vissuto realmente e però non riuscire a estrarne quell’elemento di verità che fa arrivare al cuore del lettore quello che dici.
Per cui, paradossalmente, quella potrebbe essere una casa reale, ma non vera, nel senso che tu, scrittore, sei in grado di leggerla solo perché l’hai vissuta, ma l’altro non ci può entrare. E invece ci sono le case vere; queste sono tutte case vere.
Serena: Ricollegandoci ai luoghi e al rapporto che hanno i luoghi con le persone, leggendo il romanzo abbiamo capito che l’importanza dei luoghi e degli oggetti, più che dei personaggi, è piuttosto evidente, come se questi ultimi fossero meno in grado di enunciare una verità rispetto agli altri, come se avessero più valore i luoghi fisici rispetto alle persone. Ci chiedevamo quanto il fatto di “togliere valore” alle persone sia funzionale al dare risalto ai luoghi, e se sia una scelta che si è imposta nel corso della scrittura, soprattutto considerando questo processo di spersonalizzazione che avviene durante la narrazione. A completamento di questa domanda, do la parola a Dafne che ha una domanda complementare da chiederle.
Dafne (Premio Strega Giovani): Nel mio gruppo di lettura la maggior parte dei giovani ha lasciato il suo libro perché ha sentito un senso di alienazione rispetto alle vicende narrate. Hanno giustificato questa sensazione con l’uso dei pronomi. Sembrava come se fossero in una casa di manichini, o almeno loro l’hanno pensata così. Volevo chiederle: se possono essere i nomi comuni e i pronomi che hanno provocato quest’alienazione, perché questa scelta di utilizzare Io al posto di un nome proprio? Volevo anche chiederle la chiave di lettura del suo testo, perché forse l’approccio di base tra il lettore e il libro è stato mal interpretato e per questo si è sentita quest’alienazione.
Bajani: Parliamo di distanza, quindi, mi sembra che il tema sia questo, sia della prima domanda, sia del completamento. In realtà non so se mi interessavano più gli oggetti delle persone, se mi interessavano più i muri delle persone. Quello che mi attira sono le relazioni, e quindi quanto di una persona c’è in uno spazio, quanto di una persona c’è in un oggetto. Quindi questa che è la storia tra le tante storie di un matrimonio che nasce e finisce, è la storia di una famiglia disfunzionale, in fondo, di un abuso domestico, di una specie di regime di paura in casa e allo stesso tempo è il tentativo di chi racconta, di Io, di riuscire in qualche modo a sopravviversi, ad avere una nuova vita, ad avere ogni volta una nuova vita. Tutto questo succede in una casa, e quindi quello che mi interessa è raccontare cosa succede quando in una casa si soffre, quando in una casa si ride, quando in una casa si piange. I muri questo lo contengono però ovviamente la distanza è reale, per cui in fondo i muri da un lato contengono e raccolgono quello che noi gli raccontiamo e dall’altro però un po’ se la ridono, quindi questa distanza per me era allo stesso tempo una distanza da qualcosa che era molto incandescente, doloroso o prendere un po’ la distanza, come si dice, guardarsi da fuori.
Perché non l’ho raccontato in prima persona ma ho scritto Io? Perché solo guardandoti da fuori riesci a vederti, però nel momento stesso in cui ti guardi non sei veramente più tu, perché ciò che sta nello specchio ti riflette ma non sei tu; la parte destra sta al posto della parte sinistra, eccetera eccetera. Quindi quella distanza lì è la stessa distanza che per me c’è tra i muri e le persone. I muri fanno la parte degli osservatori discreti e quindi raccontano con minore partecipazione, con ironia – da un certo punto di vista – quello che si vive. La distanza maggiore per me, il personaggio che misura la distanza in assoluto è la tartaruga. La tartaruga è quella che ha una distanza temporale, più che spaziale, una specie di preistoria che ti cammina per casa e che ti guarda come per dire: «guardali questi qua che sono ancora lì a menarsela con tutte le faccende: amore, non amore, il padre, la madre, eccetera eccetera. No, robetta, per una che arriva dalla preistoria». Quindi, da un lato credo che questa distanza sia una distanza proprio connaturata a questo gesto, al racconto di questa storia, che al di là di quello che volevo o non volevo è venuta scrivendo. Non volevo che fosse lacrimevole, non volevo né far compatire né compatire nessuno.
Volevo che tutti fossero in grado di vederla anche un po’ da fuori, come la storia di un altro e non necessariamente attraverso un processo d’immedesimazione totale. Mi interessava questo sguardo un po’ da fuori su qualcosa che in realtà era molto intimo.
Al di là delle due case “politiche” che sono quelle di Poeta e Prigioniero, cioè quelle di Pasolini e Moro, è un libro che è il rovescio dell’intimità, guarda dal di fuori qualcosa che è molto intimo. Perché succedesse questo dovevo dare e misurare questa distanza. La distanza la davo semplicemente dando questi nomi, probabilmente era il modo in cui potevo creare la distanza, chiamare io Io e non Andrea, Pietro o Giacomo, e così via gli altri personaggi: madre, bambina, moglie, nonna, eccetera.
Io credo che ogni lettura sia legittima, e perciò credo che sia legittimo abbandonare i libri, sentirsi accolti o no, e quindi non c’è lettura, non c’è calzascarpe che l’autore possa fornire a un lettore perché il piede scivoli meglio nella scarpa. Certo è, e quello lo posso dire da lettore, non da autore di questo libro, che ci sono delle esperienze e dei libri che chiedono quella specie di sforzo di attraversamento che poi può ripagare. Questo non lo dico per dire «dai, andate fino alla fine che sarete contenti», non è quello il punto. Ma se io comincio a camminare e salgo in montagna all’inizio devo rompere il fiato e non riesco nemmeno a vedere la cima e allo stesso modo camminare, tantissime azioni, persino l’amicizia è così. Incontro uno che rappresenta veramente qualcosa di molto diverso da me e magari sarei tentato di, non so, andare lontano, chiedermi come parla, pensare che ha esperienze totalmente diverse dalle mie eccetera eccetera. In qualche caso questo corrisponde alla verità e non ci sarà amicizia, ma in tanti casi la maggior parte delle esperienze importanti che io ho fatto passano attraverso questo sforzo iniziale. E la lettura è una relazione e come tutte le relazioni comporta questo conoscersi all’inizio, questo sforzarsi e questo capire se si andrà da qualche parte insieme oppure no. Questo in generale, poi ripeto, anche io abbandono tantissimi libri e quindi non sono quello che dirà: «non abbandonare». Ma il tentativo di entrare in relazione e farlo con un dispendio di energie credo che quello sì, ripaga sempre.
Aurora (Premio Strega Giovani): I ragazzi della mia scuola sono stati colpiti dal genere da lei scelto, l’auto-fiction. Ci siamo chiesti cosa l’ha spinta verso questa direzione e vorremmo spezzasse una lancia a favore di un genere che la critica odierna tende a non apprezzare particolarmente.
Bajani: I nomi che vengono dati ai generi lasciano il tempo che trovano; la storia del romanzo, della forma-romanzo, è la storia di un genere totalmente inquieto: non c’è un romanzo uguale all’altro. La bellezza e la difficoltà del romanzo stanno proprio in questo: continuamente il romanziere deve trovare la sua forma.
Se pensate a romanzi come Gita al faro, Il gattopardo, o L’ermellino, ognuno è assai diverso dall’altro, ma tutti vengono chiamati “romanzo”. Gli scrittori che apprezzo di più trovano una loro strada che va al di là del genere. La scrittura è un attraversamento, è come attraversare una montagna: puoi andare su a piedi, magari perdendoti, senza mappe; oppure puoi prendere la galleria, che la attraversa sotto. Ci sono scrittori che prendono la galleria, che usano generi ed espedienti che già esistono; e poi ci sono invece altri scrittori che prendono la propria strada, magari falliscono addirittura di più, magari il loro romanzo è più imperfetto, noioso, irrisolto, però hanno provato una loro strada, si sono persi. Ecco, io cerco di non prendere gallerie. C’è una differenza che può sembrare banale: a me non interessa l’auto-fiction, interessa la fiction dell’io. Ho voluto mettere l’io davanti a uno specchio straniante, studiando lo scarto che si creava. Ho dato una possibilità alla scrittura: le mie parole non dovevano solo portare una storia dall’altra parte, come dei gregari, ma sono stato io a chiedere a loro d’inventare, di farmi vedere e sentire. L’io si può vedere da fuori, di lato. Nei miei corsi di scrittura noto che quando le persone spostano la narrazione alla terza o alla seconda persona si liberano delle loro reticenze e paure e riescono a toccare il cuore di ciò che è vero, non solo reale. Il mio libro è proprio nato dal tentativo di mettere insieme ciò che era reale e personale all’invenzione delle parole, guidata dalle parole stesse.
Tabucchi diceva che la vita non basta, ti metti a scrivere perché vuoi di più dalla tua vita, vuoi quel surplus di visione e immaginazione. Se la vita fosse sufficiente non ci sarebbe bisogno di scrivere. Quando scrivi vivi due volte, vivi anche quella vita che pensavi di aver vissuto.
Bianca: La sua opera si potrebbe inscrivere nella cosiddetta letteratura della trascrizione, filone sviluppatosi in particolare nella letteratura francese, che si nutre di esperienza diretta e indiretta e la rende a sua volta personale e collettiva. Man mano che si procede nella lettura si ha l’impressione che lei voglia dare testimonianza di un’assenza, di un vuoto, come alcuni scrittori francesi fanno e hanno fatto (Ernaux, Perec, Modiano). Anche lei ha sentito la necessità di collezionare delle tracce per costruire una memoria presente del passato?
Bajani: La domanda è molto interessante; io ho tenuto delle lezioni proprio su Ernaux, su Gli anni, romanzo in cui l’autrice, oltre a fare un catalogo per frammenti, usa la massima distanza dalla narrazione: i pronomi che usa sono noi e lei, eppure è un memoir, un racconto di sé, di un io. A me è interessato il rapporto tra ciò che è reale e quello che poi diventa storia. Il punto è l’inventario. Un tempo mi ero fissato a voler scrivere un romanzo sulle fabbriche fallite, ma non era tanto un romanzo sociale; avevo iniziato a lavorare insieme a dei curatori fallimentari e quando un’azienda fallisce succede che rimane completamente cristallizzata, le persone devono lasciare la propria scrivania esattamente com’era, con la foto dei bambini, la penna, il quaderno sul tavolo, il computer eccetera eccetera, perché poi il curatore fallimentare darà un prezzo a tutto questo. Quello che si fa è di fatto un inventario, che è però al tempo stesso un’archeologia di senso di una civiltà finita, e per questo commovente. Le foto dei bambini con le pinne al mare in un edificio sigillato ti toccano il cuore perché si tratta di una visione sia triste, sia allegra: le due cose stanno sempre insieme. Nella parola inventario c’è la radice latina comune al verbo inventare: quello che ho fatto io è stato proprio in primo luogo raccogliere e poi inventare; dall’inventario all’invenzione.
Anche Ernaux parte dalle cose morte e le trasforma in qualcosa di vivo. Perec ha fatto una cosa simile, peraltro con grande umorismo, in Tentativo di esaurimento di un luogo parigino.
Mari: Il libro delle case è un susseguirsi di brevi capitoli che racchiudono i correlativi oggettivi che hanno fatto la storia di una vita: ogni capitolo ci dà un’immagine a sé stante, che poi assumerà ancor più significato insieme a tutte le altre. L’opera avrebbe potuto essere una raccolta di poesie? E se questo è il caso, cosa invece l’ha fatta decidere per la prosa in questa narrazione? Lei ha dichiarato in qualche occasione che prima di pubblicare le sue poesie le hanno chiesto di scrivere un romanzo: ha mai pensato a questo libro come a una vendetta finale della poesia sulla prosa?
Bajani: Mi piace molto «la vendetta della poesia». Certo, la poesia sopravvive, la prosa no, c’è poco da fare. La partita dalla prosa è sempre solo vinta nelle classifiche della domenica, nella vendita del momento, ma non ce n’è: la partita la vince la poesia, l’ultimo eco che rimane è poetica, finirà il mondo è resterà l’eco di un verso, non resterà certo un romanzo, del romanzo resterà un titolo se era bello, ovvero se somiglia a un verso. La domanda mi piace molto perché per me la poesia è ciò che di più importante c’è al mondo. Non conosco nient’altro che abbia l’importanza della poesia: la poesia è musica, fa sentire la lingua organizzandola in una maniera diversa, è un continuo attentato al linguaggio, con la capacità di toccare e raggiungere il cuore del lettore e del senso. Ho iniziato questo libro senza sapere cosa sarebbe diventato, ma non volevo contratti editoriali in anticipo, cosa che ero abituato a fare e che diventa una prassi, non volevo finirlo mai, prendendo la forma che preferiva, anche mostruosa. Non volevo che gravasse su di lui l’istinto della pubblicazione, l’istinto seduttivo della pubblicazione. Volevo concentrarmi sulla ricerca più che sul punto di arrivo e soprattutto che la scrittura si prendesse il tempo che doveva durare. Volevo tornare a una fase di necessità che per me precede l’esordio, ovvero quel momento in cui arrivi dal più lungo silenzio che avrai mai tra un libro e un altro. Mi sono detto che o un libro avrebbe avuto la capacità perentoria di chiamarmi a sé che ha la poesia o non mi sarebbe interessato. Il libro è nato come una poesia che si doveva scrivere e della pubblicazione davvero non mi preoccupavo. Questo romanzo non sarebbe potuto nascere senza prima aver scritto le mie raccolte di poesie, Dimora naturale e Promemoria.
Quest’opera ha della poesia la perentorietà e la musica: è un libro in versi camuffati. Non poteva essere in versi perché la sua struttura era un costruirsi anche nella mole, nella massa del tutto; ma la frase è totalmente ritmica, molti sono endecasillabi mascherati. Non che io mi metta a scrivere contando, ma sicuramente sono debitore alla poesia.
Mi piace l’idea di una «vendetta della poesia», ma come dicevo prima è il romanzo a essere un genere inquieto, che accoglie ora la poesia, ora, se vuole, la fisica quantistica: tutto servirà a tentare di raccontare una storia cercando una forma nuova.
La poesia quando arriva in soccorso è il migliore soccorso che ti possa capitare, non fosse altro perché ti fa stare bene.