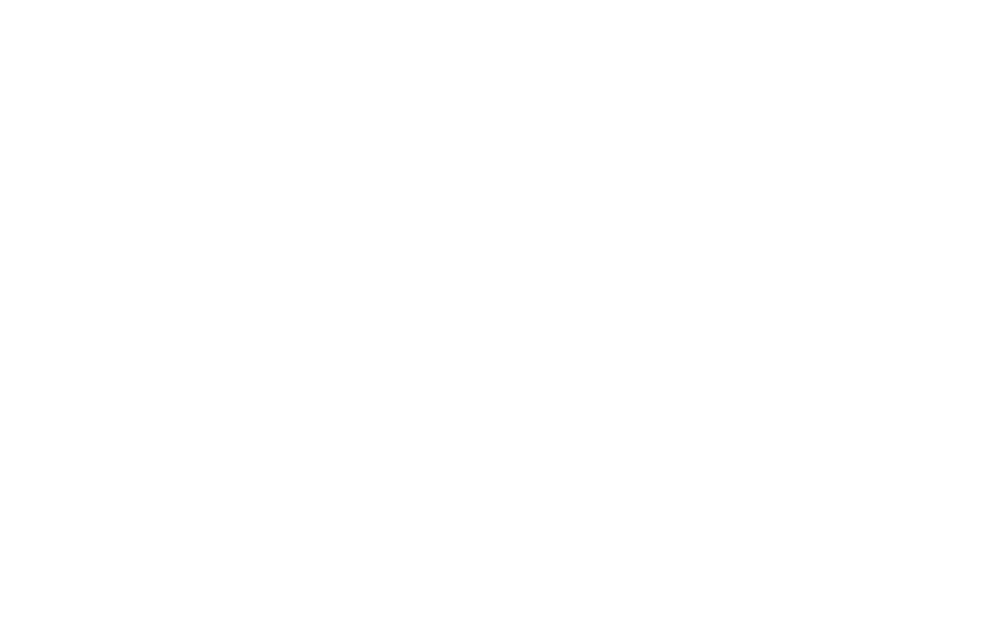A cura di Claudia Caldarola e Marika Lauria (Scuola del libro), Laura Terracciano (Liceo classico G. Carducci di Nola), Eleonora Zorzi e Lucia Traccaroli (Liceo scientifico A. Messadaglie di Verona).
Ernesto ed Elia sono gemelli, ma non potrebbero essere più diversi. Il primo chiuso, introverso, difettivo, dipendente dalle sostanze e dall’affetto altrui; il secondo socievole, brillante, sano, capace di trovare il proprio posto nel mondo.
Altrettanto diverse le case che abitano e che li vedono prima bambini, contornati da una famiglia allargata e allegramente disfunzionale, e poi adulti, in una solitudine spesso ricercata ma mai definitiva. Le loro differenze si riversano, e in parte dipendono, dagli altri personaggi: Sarabanda, mamma moderna ma anche soffocante, e Speedy, padre fallace e sfuggente ma non fino in fondo; e le nonne: Nina, tenera e materna, traduttrice ante litteram, e Ilide, rigida e conservatrice.
Da adulti, i gemelli, ormai due rette parallele, si rendono conto, a un prezzo più o meno alto, che il legame che li unisce l’uno all’altro, alle case e alla famiglia rimane indissolubile, nonostante la lontananza fisica e mentale che tanto si sono autoimposti durante la crescita.
Se si parla di famiglie disfunzionali, come quella descritta in La casa delle madri, è impossibile non pensare all’incipit di Anna Karenina: «Tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice è invece infelice a modo suo». E nella storia della letteratura, soprattutto moderna e contemporanea, gli esempi di crisi della famiglia borghese sono numerosi. Quali sono stati, se ce ne sono stati, i suoi modelli letterari in tal senso?
Rispondo come avrebbe fatto Woody Allen: «Se devo scegliere un modello, vado verso Gesù Cristo». Ovviamente, come tutti, ho una serie di modelli del cuore ma devo dire che, tranne forse Thomas Mann per la tematica della malattia, non sono legati tanto al tipo di trama, di racconto, o di tematica, quanto al tipo di linguaggio. Sicuramente la mia è un’operazione che andava di moda un secolo fa, e gli autori in cui più mi riconosco sono i modernisti europei che usano il linguaggio in una maniera, se mi consentite il neologismo, «superfetante». Avevo in mente più delle musiche, più Bruckner che Joyce, ma non pensavo esattamente a un grande narratore di storie familiari, perché la famiglia mi serviva come luogo di rottura e, appunto, già ne hanno parlato giganti sulle cui spalle nemmeno azzardo ad affacciarmi, tanto per citarne una Claudia Zonghetti, l’ultima traduttrice di Anna Karenina.
Nel suo romanzo, le figure femminili rivestono un ruolo centrale e, a eccezione di Speedy e dei gemelli, solo le donne hanno un nome proprio, potremmo quasi dire che siano loro le vere protagoniste e motore primo degli eventi. Questo aspetto riporta alle atmosfere di Casa di bambola: il personaggio di Sarabanda, proprio come la Nora di Ibsen, rifiuta di diventare una marionetta in balìa degli eventi e delle aspettative altrui.
Citare Ibsen mi fa rabbrividire. In realtà, secondo me, Sarabanda è abbastanza diversa da Nora, anche solo per un fattore storico. Nora non era immersa in una società in cui il femminismo era radicato, mentre Sarabanda si chiama così proprio in omaggio al famoso slogan del femminismo italiano. C’è anche da dire che io in quanto uomo, come dicevano le femministe, posso raccontare un aspetto soltanto, quindi non mi permetterei mai di prendere la parola al posto delle donne, che sono le protagoniste, perché sono loro ad avermi insegnato questo linguaggio. I collettivi femministi, sia quelli dei primi anni ‘70, quando ero ancora un bambino, sia della seconda metà degli anni ‘80, quando frequentavo il liceo, mi hanno trasmesso l’importanza della sperimentazione linguistica. Penso anche che la mia generazione sia quella in cui per la prima volta i maschi si sono ritrovati a crescere in una società dove il linguaggio era gestito dalle donne, superando quel: «ah, quanto chiacchierano queste femmine», che era stato in qualche modo il mantra di chi voleva detenere un certo potere linguistico, se posso permettermi un’allusione a Foucault. Prima mi chiedevate degli autori di riferimento, forse sono di questo tipo più che letterari. Foucault sicuramente l’ho avuto in testa fin dall’inizio perché usa il linguaggio in una maniera apparentemente ambivalente, a volte masochista, ma cerca sempre di non fermarsi a un solo lato della questione. Perciò la vera donna protagonista, per me, è la lingua. È lei la casa delle madri, e la chiamo «delle madri» semplicemente perché, di nuovo, in quanto uomo, la madre è la prima femmina, nel senso proprio di animale di sesso femminile, parlante in questo caso perché umana, con la quale un maschio si trova in contatto.
Avrei potuto intitolare il libro «La casa delle donne», ma esiste già, a Roma, e non mi sembrava rispettoso usare una sigla che per me ha tutta un’altra importanza; è un centro culturale, oltre che femminista, che frequento da sempre, prima da ragazzo poi da uomo, poi da padre con i miei figli, e quindi non me la sarei sentita. Quindi sì, la risposta è sì, ma in maniera simbolica, del resto ci sono nel libro dei nomi un po’ bizzarri, come Speedy e Sarabanda, che non sono propriamente personaggi. Nemmeno Ernesto ed Elia sono due personaggi, ma due lati dello stesso personaggio; la protagonista, più che la casa secondo me (o almeno nelle mie intenzioni, poi non so quanto ci sono riuscito, questo sono i lettori e le lettrici a doverlo dire), è la lingua. È un tentativo di riprodurre, da uomo, l’insegnamento delle donne sul modo di usare la lingua.
A proposito di contrapposizioni, nel romanzo le principali sono due: una è più implicita, quella tra Sarabanda – femminista, agnostica, emancipata –, e sua nonna Ilide – matriarca chiusa nella struttura del patriarcato, estremamente religiosa –, l’altra più evidente, è tra Ernesto ed Elia. Che funzione hanno nell’evoluzione dei personaggi stessi e del romanzo in generale?
Questo romanzo è costruito per coppie oppositive. Ovviamente quella per antonomasia sono i gemelli, i doppelgänger, lo specchio, da Eteocle e Polinice, passando per Romolo e Remo, spesso si uccidono tra loro, sono una coppia oppositiva che funziona anche perché violenta. È questo eccesso di identità a scatenare la violenza, e oltre a essere un tema che mi affascina, in questo caso era anche funzionale, perché il linguaggio opera per continui andirivieni e opposizioni, si avvita su sé stesso nel dire e ridire il contrario di quello che è stato detto: avere personaggi che funzionano in questo modo era fondamentale per non perdermi. In realtà le coppie oppositive sono continuamente incrociate: Ernesto ed Elia non si possono staccare e infatti sono in tutto e per tutto rette parallele come ripeto nel romanzo. Sarabanda fa coppia con Ilide, ma anche con Speedy, e fa coppia oppositiva con sua madre Nina. Ritornando a Ibsen, Nora sarebbe stata una sorella maggiore, se non una madre per Nina, ma forse anche una contemporanea, perché Ilide e Nina appartengono all’inizio del ‘900. Sono due modi, appunto oppositivi, di reagire a quella cosa che ci schiaccia tutti e che potremmo chiamare convenzionalmente patriarcato.
Tornando ai personaggi, io non li ho intesi, né vissuti, con una connotazione oppressiva per l’uno e più libera per l’altro. Per me sono solo persone che hanno modi diversi di uscire da una certa situazione scomoda. Se il lettore li percepisce come tali, evidentemente lo saranno, però la mia idea era che ognuno di essi rappresentasse la faccia di una disperazione precisa: sentirsi oppressi dentro una «casa di bambola», troppo piccola, troppo stretta.
Soffermiamoci su Ernesto. In un primo momento la sua malattia viene attribuita a un errore medico, e solo dopo tempo si rivela congenita. Se la famiglia l’avesse saputo sin da subito sarebbe stato più semplice affrontarla? Leggendo il romanzo non si può fare a meno di chiedersi se il legame familiare ne avrebbe giovato, o se la compassione e il senso del dovere avrebbero comunque portato a un allontanamento tra i gemelli.
In realtà, non me lo sono posto come problema, perché quello che mi interessava, e ritorno a quanto dicevo prima su Thomas Mann, era cercare di uscire da una mitografia della malattia che, da Baudelaire in poi, passando per Mann, arrivando almeno fino alla fine del secolo, è stata funzionale come metafora del genio e dell’arte. Nel libro ci sono tante parole politicamente scorrette, come «handicap», termine utilizzato nelle certificazioni di disabilità dove non c’è mai la formula «persone speciali». Io trovo che sia estremamente ipocrita che nei licei, ad esempio, ci siano dei cartelli con le «H». Ma cosa vuol dire «H»? Sta per «handicap» naturalmente, però la denominazione usata è «ragazzi speciali». Questa cosa non è realistica, e non è una polemica sul politicamente corretto. Il problema è che la malattia è uno schifo, sia per chi è malato sia per chi assiste il malato, e questo schifo, questa fatica, questo odio che arriva, sia quello di chi sta sulla sedia a rotelle sia quella di chi la sedia a rotelle la spinge, deve poter trovare un proprio spazio di espressione del malessere, come quando c’è una barriera architettonica o un SUV parcheggiato male: non dobbiamo far finta che vada tutto bene. Io volevo far andare tutto male, e ho fatto in modo che ci fossero delle condizioni sfavorevoli. Quello che volevo raccontare non era tanto la reazione di questa famiglia a quella malattia, quanto mettere in scena una reazione affranta, affaticata, sbagliata, anche violenta e aggressiva, che la malattia in generale giocoforza scatena.
Parliamo ora di quella che ha definito vera protagonista del romanzo: la lingua. La casa delle madri fa parte della collana «Sperimentali» di TerraRossa Edizioni, che, come si legge sul sito della casa editrice, «è pensata per quegli autori che considerano fondamentale la ricerca di uno stile inedito e di una scrittura originale». L’aspetto che affascina del romanzo è infatti la struttura della frase, quasi centripeta, con un’abbondanza di subordinate, di incisi, di parentesi che imprimono un ritmo circolare. Com’è nato l’incontro con la casa editrice e come, insieme all’editor, avete lavorato sul romanzo?
Sono felice di poter parlare di TerraRossa, un piccolissimo editore ma di grande qualità. Lo conoscevo già prima della pubblicazione con loro, avevo letto alcuni suoi libri; sono un grande amante di Ezio Sinigaglia, altro autore della casa editrice, oltre che di Cristò. Io ci sono finito per caso. La storia è questa: raramente quando scrivo penso a pubblicare; questo non è né il primo né l’ultimo romanzo che ho scritto, ed era quello che consideravo più impubblicabile in assoluto, perché scrivendo con questa lingua in accumulo non credevo potesse finire in stampa. Di solito però le cose che scrivo le faccio leggere a delle persone mirate. La casa delle madri l’ho dato a un amico poeta e a un’amica musicista. Per un parere tecnico, invece, la faccenda è stata più complicata. Io faccio anche il traduttore e conosco molte persone che lavorano in editoria a cui avrei potuto chiedere, ma non volevo che sembrasse una richiesta di aiuto per la pubblicazione, però avevo bisogno di sapere se il libro era leggibile, perché non ne ero sicuro. Poi l’ho dato a un collega traduttore, Giuseppe Girimonti Greco, francesista raffinatissimo che ha tradotto Simenon per Adelphi. Tra l’altro si trattava di una stesura molto vecchia, la prima versione di questo libro contava più di 600 pagine. Lui è molto attivo nelle riviste fiorentine e conosce tantissime persone nell’ambito, e così ha fatto girare un po’ il testo che ha avuto improvvisamente, e per me del tutto inopinatamente, una serie di riscontri molto positivi.
Ero in contatto con il direttore di una casa editrice più grossa di TerraRossa, e stavo quindi già lavorando sul testo. Era ovvio che il romanzo non potesse uscire così com’era, e nel momento in cui si è pensato di pubblicare ho subito deciso di non tagliare parti a caso, ma intere linee narrative. Eravamo in una fase di stasi, quando mi è arrivata un’e-mail di Giovanni Turi, in cui mi diceva che aveva letto una versione già ridotta del romanzo, di 350 pagine circa, che Girimonti Greco gli aveva mandato. Lui sapeva che probabilmente la pubblicazione non sarebbe andata a buon fine perché con l’editor non c’era grande intesa. Così l’ha dato a Turi, che mi ha scritto: «mi sembra una cosa bellissima e lo voglio assolutamente pubblicare, ti mando un contratto», e in allegato c’era un contratto di edizione, che di solito arriva dopo, e ne sono stato molto colpito. Io non ero contento di quella versione del testo, così gli ho chiesto di darmi tre mesi; volevo cambiare alcune cose e una volta concluso il lavoro se Turi fosse stato ancora convinto voleva dire che la direzione era quella giusta. Gliel’ho rimandato e lui mi ha riscritto subito, dicendomi che andava molto meglio. A quel punto abbiamo iniziato insieme un lavoro di strafino: TerraRossa ha una redazione pazzesca. Giovanni Turi ha fatto l’editing su un testo la cui prima versione è stata scritta in 6 mesi, ma quasi 10 anni fa, poi ci avevo lavorato un altro annetto a intervalli irregolari; sulla versione che avevo maneggiato durante l’estate ci abbiamo lavorato almeno altri 3/4 mesi insieme. Lui mi mandava commenti, consigli, ma soprattutto questa sorta di tabulati dove appuntava scene e punti che non lo convincevano del tutto; così io riscrivevo, e lavoravamo di nuovo su quei punti. Alla fine, è venuto fuori un libro di circa 290 pagine. Il lavoro con Turi è stato estremamente arricchente, per il testo e per me.
Ovviamente facendo il traduttore, ero abituato alla revisione, alle diverse letture, e alle correzioni di bozze. Ho lavorato sul testo fino in fondo anche con la correttrice di bozze, che era scrupolosissima e non mi faceva notare soltanto una parentesi chiusa male, ma mi segnalava anche quelle parti in cui il senso non era del tutto chiaro. Mi costringeva a spiegarle bene, a farle capire che sapevo quello che stavo facendo, oppure a scrivere di nuovo. Io sono convito che alla dozzina ci sono andato con tutta la redazione, in qualche modo. Lo Strega ha un’attenzione, soprattutto recentemente, verso gli editori piccoli e in gamba e quando Elena Stancanelli ha proposto il libro dopo che è uscito, mi ha detto che era solo un tentativo perché l’editore era davvero piccolo. In ogni caso era un buon modo per raggiungere nuovi lettori. Tutti ci siamo detti: «Vabbè, in dozzina è impossibile che ci arriviamo».
Qual è stata l’idea da cui è partito per il suo romanzo, e soprattutto quanto c’è di autobiografico nel testo? Siamo anche curiosi di sapere qual è stata la reazione alla proclamazione della dozzina del Premio Strega: TerraRossa è una casa editrice piccola ma anche abbastanza giovane, e il suo è un romanzo d’esordio.
Partiamo dalla fine. La reazione è stata: «Qua andiamo tutti in rovina!» Una casa editrice come TerraRossa fa tirature che non superano le 1000 copie, a volte anche una iniziale di 500 per poi vedere come va. Partecipare allo Strega significa, per cominciare, dover spedire il libro a tutti gli Amici della domenica, gli aventi diritto sono 660, quindi una tiratura è solo per loro. Però è stato bellissimo perché, al contempo, tutte le librerie hanno cominciato a ordinare molte copie. Giovanni Turi ha un’idea ben precisa dell’editoria, come molti editori medio-piccoli, e non ha un distributore, così è stato difficile far arrivare il libro nei tempi necessari. Usa una carta di un certo tipo, il più ecologica possibile, e con una grana particolare. Purtroppo con una delle edizioni, la seconda, quella di fine marzo, quando ci hanno detto che eravamo in dozzina e bisognava spedire immediatamente, si è dovuto sbrigare e ha dovuto usare una carta diversa, altrimenti il libro non sarebbe arrivato in tempo a chi di dovere. Comunque è stata una reazione di assoluto stupore e grande gioia, perché, a prescindere da tutto, si trattava di un modo per la casa editrice di farsi conoscere. Io poi ho una concezione collettiva dell’arte, forse perché vengo dal teatro. Credo che le cose si facciano meglio insieme. Sarà anche perché sono un traduttore e quindi sono abituato a lavorare sui testi degli altri, e che gli altri lavorino sui miei.
Come ci sono arrivato allo Strega? Ho fatto teatro per quasi trent’anni, dopo il liceo ho vinto il concorso per entrare all’Accademia Silvio D’Amico, ed ero in classe con Elena Stancanelli. Nel frattempo, Elena è diventata una scrittrice molto importante, da molto prima di me, il suo primo libro risale a diversi anni fa, e con La femmina nuda (La nave di Teseo) è arrivata in cinquina nel 2016. Quando il libro è uscito gliel’ho spedito senza dire niente. Dopo pochissimo, mi ha telefonato e mi ha dato dell’idiota, dicendomi che La casa delle madri era un libro bellissimo. Però, conoscendo molto bene l’ambiente, sapeva anche che si trattava di un romanzo difficile da proporre ai lettori. Elena mi ha confessato di non aver mai proposto nessun libro da quando è entrata a far parte degli Amici della domenica, ma per il mio romanzo avrebbe fatto un’eccezione perché, come ha scritto nella motivazione alla candidatura, voleva «aiutarlo ad avere dei lettori».
Passando alla prima parte della domanda: sì, è un romanzo molto autobiografico, perché ho avuto un fratello gemello disabile, ed è morto. Quelli che mi conoscono sin da ragazzino mi hanno telefonato per dirmi che la storia non era esatta, che molto di quello che avevo scritto era sbagliato. Ma La casa delle madri non è auto-finzione, anzi, il contrario, ho usato un nucleo fondamentale della mia vita che è la malattia e la gemellarità, ho usato una serie di situazioni, di personaggi, che conoscevo. Però li ho mescolati, li ho cambiati: non ho mai avuto una nonna traduttrice, nessuna delle mie nonne è morta di Alzheimer, non ho nonne particolarmente dotte, quindi tutto il resto, anche il rapporto con mio fratello gemello, per quanto a volte molto conflittuale, non era di quel tipo.
Lei ha già accennato alla sua carriera di traduttore dal portoghese. Pensa che ci possa essere un parallelismo tra il suo modo di essere scrittore e la sua vita da traduttore? E in particolare, tornando alla peculiare costruzione della frase all’interno del romanzo, pensa che possa essere stata influenzata in qualche modo dalla lingua portoghese?
In realtà, traduco anche dall’inglese e dal francese; sì, sono laureato in portoghese, ma se dovessi fare la mia parte per mantenere la famiglia solo con le traduzioni dal portoghese temo che non ce la farei, il mercato italiano traduce solo per il 60% e la metà delle traduzioni sono dall’inglese, poi vengono spagnolo e francese (intorno al 15-17%), il portoghese sta nel resto, che va dall’1,5 al 3%. Ho la fortuna di conoscere l’inglese e il francese meglio del portoghese, perché sono le mie lingue «bambine», come amo chiamarle. Sono cresciuto con due cugini della mia età che hanno la mamma francese e quindi ho imparato tanto ascoltando loro. Ovviamente, poi le ho studiate e quando ero ragazzo ho vissuto per diverso tempo nei paesi europei in cui si parlano queste lingue; proprio per questo motivo all’università ho scelto il portoghese, per evitare di «barare».
Comunque tradurre è il mio mestiere, non faccio lo scrittore, c’è una grande differenza, io scrivo quando non traduco, quindi o prima dell’alba o dopo mezzanotte. Ciò non toglie che si possa scrivere tanto, lo so per esperienza personale, anche se non lo si fa per mestiere. Che differenza c’è? È difficile. Quando mi chiedono di parlare della traduzione insisto tantissimo sull’aspetto creativo, sul fatto che un traduttore non è una macchina ma un interprete, un critico, e non ha niente da invidiare allo scrittore. Io sono un uomo che ha scritto un libro, e non mi azzardo a chiamarmi scrittore. Mettere l’artista – che sia scrittore, musicista, poeta, pittore -, su un piedistallo, come in una vulgata romantica, è sbagliato, è una visione che andrebbe superata. Forse la creatività è una corrente tipicamente umana che si esprime in tanti modi, alcuni più vicini a quelle che chiamiamo «forme d’arte», altri che si esplicitano diversamente. Mi è molto chiara la differenza tra un compositore che scrive il Concerto in Sol e Marta Argerich che lo suona, da un punto di vista semiologico.
Per quanto riguarda la costruzione della frase: come fai a non mettere dentro quello che fai tutto il giorno, tutti i giorni? Tra l’altro molti traduttori scrivono anche per allenarsi a usare lo stile dell’autrice o dell’autore che stanno traducendo. È ovvio che questa cosa ha bagnato il mio stile, scusate se uso questa parola, iper-umilmente spogliata da qualsiasi orpello romantico. Però non avevo in mente quello. Avevo in mente, appunto, la parola delle donne, ma anche la parola tarda, dell’ultima mezza bottiglia di vino dopo le tre del mattino, a vent’anni quando sei con delle persone con cui hai un’estrema confidenza, dopo aver fatto un’azione politica molto forte, dopo aver fatto l’amore, aver fatto le prove a teatro, dove c’è un contatto fisico estremamente elettrico e dove comincia in qualche modo a crearsi una specie di unico io che si nutre di tante personalità diverse e che soprattutto ha una sua sonorità, un suo sound. Volevo cercare quel sound. Ed è lì che sono andato a lavorare, poi, è ovvio, inconsciamente resto sempre un traduttore.
Infatti lei è professore, traduttore, attore, non solo teatrale ma anche televisivo: all’interno di La casa delle madri, si può in qualche modo ritrovare la tecnica del montaggio, per i diversi piani spaziali e temporali, che spesso vanno a caratterizzare la narrazione, intersecandosi. Ci si rivede?
No. Ho smesso di fare l’attore perché non mi piace la televisione e volevo essere solo attore di teatro, ma non guadagnavo abbastanza. Ho cominciato a tradurre proprio per provare a emanciparmi, e traducevo testi teatrali per le compagnie con cui lavoravo. Tutto questo è per dire che non ho grande dimestichezza con il cinema e con la tecnica cinematografica, me la cavo di più con le tecniche teatrali, forse quello che ci sento dentro è proprio la parola parlata, ma non quella tra i personaggi. È un libro senza dialoghi, dove è importante il peso sonoro della parola. Per me le parole, anche da traduttore conta tantissimo, hanno dei colori, una tonalità. Quando insegno, dico sempre: «Se non sentite le voci come gli schizofrenici quando traducete, non potete tradurre, perché bisogna sentire la voce»; io volevo scrivere facendo parlare delle voci. Poi la tecnica del montaggio c’è, tantissimo, però non l’ho presa dal cinema, non ho avuto questa coscienza.
Parliamo delle ambientazioni del romanzo. Lei non nomina mai direttamente i luoghi in cui si svolge la narrazione però sembra che abbia disseminato degli indizi qua e là. Quindi, unendo un po’ i puntini, la casa del notaio potrebbe essere situata in un quartiere residenziale di Roma, mentre la casa al mare in una località balneare limitrofa, ad esempio Terracina. Insomma, se vuole ci può svelare quanto ci siamo avvicinate alle ambientazioni reali.
Non ci sono delle ambientazioni reali, ci sono solo dettagli presi da diverse case; però non c’è Terracina, mi dispiace. In realtà, è ovviamente una città, io abito a Roma, non ci vuole niente a metterci il Cupolone o il Gazometro, la si riconoscerebbe immediatamente. Invece, io volevo lavorare su una città, su una famiglia borghese da una parte o di aristocrazia operaia dall’altra, ma sicuramente cittadina. E una delle cose che non volevo mettere, o meglio che volevo omettere, era la provincia, che invece è fondamentale in Italia. È sicuramente un romanzo del centro, e non delle periferie. Su questo non c’è dubbio. Da questo punto di vista il quartiere residenziale è perfetto. L’ambizione era che ci si potesse vedere anche Milano, Torino o Palermo, sicuramente non Pescara o un’altra qualsiasi città, anche piuttosto grande ma di provincia, dove le dinamiche sono piuttosto diverse, dove personaggi come Nina e Sarabanda secondo me sono un po’ meno plausibili.
Quindi non Terracina, più Sabaudia, magari, o quella zona un po’ più giù, il Circeo.
Il Circeo va benissimo. Certo è una casa al mare, quella è una casa da ricchi. Che poi sia il Circeo, Porto Ercole, o Capalbio, ecco, chi se ne importa. Però certo, l’idea è quella: la casa di un ricco.
Dunque ci sono anche alcune case, magari, che lei ha vissuto direttamente all’interno della Casa delle madri?
Tutte. Ho fatto un collage. Le case sono tutte vere, ma nessuna è fatta così. Infatti anche lì, chi riconosce un pezzo dice: «Sì, però dietro quella stanza non c’era il corridoio, è impossibile». Però sono tutti pezzi veri. Quello è proprio un vero e proprio collage.
Revisione a cura di Manuela Altruda