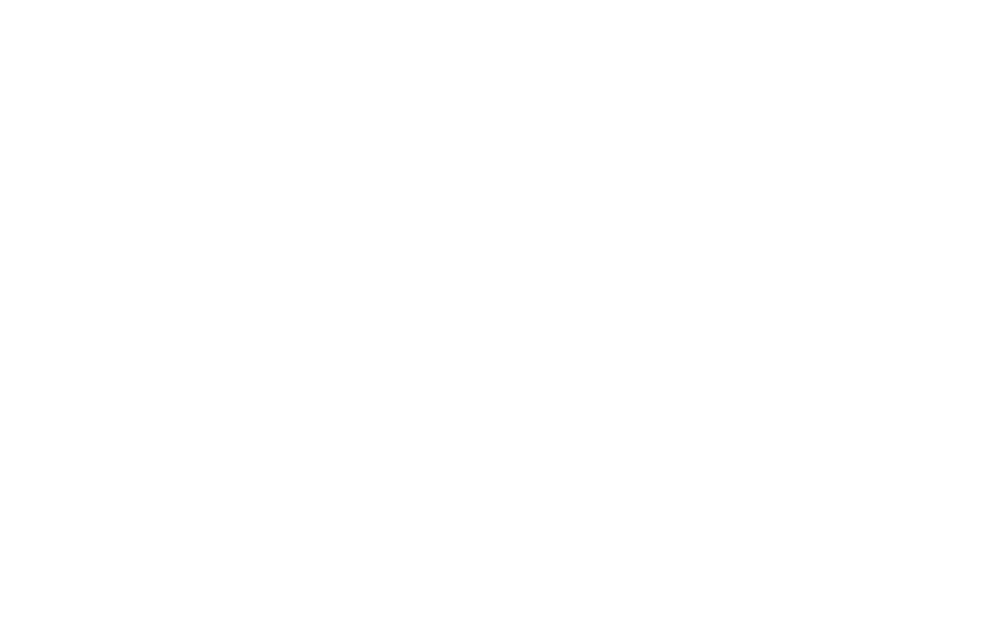A cura di Maria Paola Corsentino, Martina Dettori e Elena Liuzzi (Scuola del libro), Gabriele Brenelli (Liceo Linguistico L. Pettinelli di Roma), Giulia Cirilli (Liceo Scientifico Volterra-Elia di Ancona) e Lucrezia Lunghi (Liceo Linguistico C. Varalli di Milano)
Due vite sono quelle che si intrecciano in questo romanzo, quelle di Rocco Carbone e Pia Pera, scrittori e amici. Ponendosi in prima persona alla «distanza giusta» che è lo stile dell’unicità, Trevi narra le loro esistenze e l’intima amicizia che li ha uniti, mettendo in luce gli aspetti che hanno avvicinato e differenziato le identità e i destini dei due protagonisti, scrittori di talento, forse non sufficientemente conosciuti e apprezzati in vita.
Attraverso i filtri e il naturale alternarsi dei momenti di vita felice ad altri di grave difficoltà, fino alle tragiche e premature scomparse di entrambi, il romanzo ci permette di scoprire recessi finora ignoti della personalità dei due scrittori. Nella cornice del racconto, anche autobiografico, di un saldo legame d’amicizia, Due vite è un inno a quella che era la bruciante passione comune, la letteratura, come unico linguaggio adeguato al racconto di quella esperienza ineffabile che è la vita umana.
In Due vite lei scrive che la presenza di Rocco ha preso rapidamente «la forma di un’antica e cameratesca consuetudine»; il ricordo di Pia invece è giunto più timido, più cauto, come a esortarla a non trarre conclusioni affrettate. Come ha influito questa diversa elaborazione dei ricordi sul suo approccio alla narrazione? E come ha costruito il montaggio degli episodi delle due vite?
Due domande quindi. Posso risalire dalla seconda alla prima.Questo libro è un esempio di editing straordinario e radicale, un argomento che la Scuola del libro immagino affronti quotidianamente nel suo percorso didattico. Lei parla di montaggio, e dobbiamo immaginarci una situazione simile a quella del cinema. Noi scrittori siamo un po’ come i registi, portiamo a casa del girato a fine giornata: l’editing è una attribuzione, esattamente come in regia. Nella storia del cinema non si contano molti registi che sono allo stesso tempo anche montatori. C’è Eisenstein, ma parliamo di cinema delle origini, in cui il regista aveva molte competenze racchiuse in sé.
Perché facciamo questo? Perché a un certo punto non vediamo più quello che abbiamo scritto. Io prediligo le forme brevi proprio perché ho la sensazione che siano più controllabili. Non mi vedo a scrivere un libro delle dimensioni di Guerra e pace, perché per me la dimensione costruttiva e architettonica del testo vale anche più di quello che racconto. Cerco di far uscire la verità dalla forma; quindi ho consegnato quello che avevo fatto a un bravissimo scrittore ed editor (le due cose non sempre coincidono: io, per esempio, sono un pessimo editor), ossia Mario Desiati, che l’ha traghettato fino al porto, forse in maniera per me un po’ traumatica. Non c’erano parole sue, perché l’editor non mette parole sue, però c’era un montaggio differente, tanto che a un certo punto ho pensato che mi avesse inviato il file sbagliato con il libro di un altro. Poi, però, mi ha chiesto di fidarmi, perché il suo era un tentativo di dare più significato a certi aspetti del testo. Gli argomenti, la mia visione della vita, le cose definitive, non sono modificabili da nessun editor. Sulla forma, invece, si può intervenire radicalmente per creare un assetto che sia più narrativamente convincente.
Questo discorso riguarda anche la prima domanda. Uno dei problemi più importanti in questo libro era proprio la differenza di trattamento tra il maschile e il femminile. Due vite non è un romanzo su due amici, ma su come due amici sono ingentiliti da una presenza femminile. Pia era dotata di un incanto che noi non avevamo, ed è per questo che descrivere Rocco per me è stato molto più semplice, perché le amicizie tra maschi, soprattutto da giovani, hanno un carattere competitivo, scherzoso, ironico, che è stato facilissimo da ricreare. L’dea del femminile invece è stata più complessa, mi è costata molte riscritture. Pia mi diceva sempre: «Tu arrivi alle conclusioni facilmente». È stata lei a insegnarmi che la confidenza tra uomo e donna ha dei punti ciechi che comporta una sfida superiore all’empatia. Questa non è tanto una premessa psicologica, ma una questione di scrittura: come rendo credibile qualcosa che io stesso ho difficoltà a descrivere? Se io dico una parola su Pia, ad esempio che era incantevole, come la faccio apparire realmente al lettore? La posta in gioco è quella. Non la mia testimonianza, ma la possibilità di far immaginare quella persona. Chi ha conosciuto Rocco e Pia costituisce chiaramente la minoranza dei miei lettori, e non si tratta dei lettori più gratificanti perché hanno una stampella, la loro conoscenza, che rende la lettura più semplice e piacevole. Io scrivo per le persone che non hanno mai immaginato l’esistenza di questi due esseri umani meravigliosi.
Scrivere su chi non è più accanto a noi di certo non è cosa facile. L’esperienza e la sua scrittura hanno contribuito a farle maturare una nuova visione della vita? Magari ora ha un modo di vedere la quotidianità diverso rispetto a quello precedente ai fatti?
È proprio questo il senso della scrittura: noi non possiamo considerarla solo come un registro o come la conseguenza di qualcosa che avviene nella mente, ma la traccia di un processo di conoscenza già avvenuto. Scriviamo per scoprire quello che già sentiamo. Posso sintetizzarlo in una formula: «Ho un libro in testa». Significa che non ho in testa nulla, ma sento di dover scrivere. La mente di uno scrittore vive in uno stato di perenne movimento e ricerca. Certo con l’esperienza possiamo imparare a non perdere il senso dell’orientamento, ma è difficile conquistare delle forme di comprensione della vita che siano stabili.
Nel processo di scrittura scegliamo i momenti dell’esperienza che hanno calamitato la nostra attenzione. È una cosa abbastanza facile, empirica, sia da giovani che da vecchi, abbiamo la sensazione che una cosa è stata importante per noi, che ci è particolarmente piaciuta o ci ha disgustato e quel sentimento si trasforma in un punto di partenza Uno scrittore si interroga sempre sul perché delle cose, e in questo non si differenzia troppo da un lettore.
In teoria uno scrittore non dovrebbe sapere molto di più di come va a finire un libro del lettore stesso. Questa è una cosa che ho verificato con Due vite, perché mentre lo scrivevo capivo quanto mi mancavano queste due persone. È stato prezioso per me, perché generalmente viviamo in un mondo in cui per fortificarci ammettiamo con difficoltà un dolore ma, nel mio caso, alla fine ho dovuto riconoscere che la mia vita era migliore con loro due. Forse in passato ho fatto degli errori, o magari ho peccato in termini di amicizia, come racconto nel libro, però indubbiamente erano un grande sostegno e un grande conforto per la mia vita. Scrivendo mi sono reso conto che ormai sono più vecchio di loro e che devo andare avanti da solo.
Ed è una sensazione che, al di là del racconto, mi ha accompagnato anche in questo periodo in cui il libro è finito, lo vedo andare in giro, lo vedo avere successo. Non è un sentimento per forza negativo o triste, ma di consapevolezza.
In Due vite vengono costantemente forniti spunti che connotano situazioni e personaggi in modo da guidare l’immaginazione del lettore e anche la sua rappresentazione di essi. Quando racconta di Rocco e Pia cerca sempre di farne emergere i tratti caratteriali, anche con un certo lirismo. Ostinato e rigido Rocco, incantevole e bizzarra Pia. Come ha scelto gli elementi e anche le parole per le loro descrizioni?
Questa è una grande domanda. Sta tutto lì. Io ho una scuoletta di scrittura, e dico sempre che non dovremmo dire scuola di scrittura, ma scuola di riscrittura. La domanda iniziale riguardava l’aspetto tecnico dell’editing e devo confessare che una parte della bellezza del libro è dovuta a Mario Desiati. Lo faccio volentieri perché l’arte è anche collaborazione, vedere le stesse cose. Non mi sento sminuito, anzi, sono stato bravo a scegliere Mario.
Questa invece è la domanda delle domande, perché delle volte basta un aggettivo a fare la differenza. Due cose sono fondamentali per me, anche nel giudizio che ho dei libri. Primo: la scrittura è un prodigioso meccanismo di creazione e di immaginazione nella testa del lettore, e in questo senso è diversa da ogni altra arte; diversa, ma non superiore, perché la musica, la danza, la pittura, la coreografia, qualunque arte vogliate immaginare, sono delle “pappe fatte”. Il libro esiste nel momento in cui c’è un essere umano che lo legge, che lo attiva. È facile immaginare una bellissima statua greca in un museo chiuso per Covid: la statua è quella e rimane tale. È chiaro che si completa nell’essere ammirata, è fatta per quello, ma in misura minore rispetto alla scrittura. Un libro chiuso, perduto, o che è stato mandato al rogo non esiste, perché il libro deve poter essere immaginato dal lettore. La seconda cosa è il miglior consiglio di scrittura che io abbia mai trovato nella letteratura, e lo dice Hemingway nel suo bellissimo Festa mobile: quando rileggendo un libro butti solo quello che non è riuscito bene non hai fatto niente, la bellezza di un libro dipende dall’eliminare cose buone, perché è quel sacrificio che accende la memoria del lettore. Quindi è tutto un lavoro di togliere, perché l’eccesso di informazioni è un grandissimo ingorgo estetico. Per questo la scrittura ha un effetto benefico sull’ego, perché se si vuole raggiungere un obiettivo bisogna sacrificare degli aspetti di sé. La comprensione del mondo non ha di per sé un valore estetico, ma restituire al lettore l’immagine di una bandiera gialla che sventola su un pennone, quello sì. In questo senso il consiglio di Hemingway è giustissimo.
La letteratura è legata in maniera antipatica alla cultura, all’intelligenza, alla capacità dello scrittore di capire il mondo. Lo scrittore viene considerato un mito sociale ed è costantemente tentato di mettere il suo ego davanti all’immaginazione del lettore. Quindi, i miei protagonisti non sarebbero venuti fuori se li avessi giudicati troppo o avessi creato un sistema di descrizione che canalizzava l’attenzione su di me. Io scrivo i miei libri in prima persona, mentre il personaggio si chiama Emanuele Trevi, ma tutto sommato ha una funzione più che altro narrativa.
In questo ruolo, come si diceva nella sinossi, «la distanza giusta» è quella che porta a fare quel passo indietro per far apparire. Io, per esempio, un libro su di me non lo scriverei mai. Ho bisogno sempre di raccontarmi in relazione a un’opera d’arte o a una persona, perché non ho un vissuto così interessante. A mio parere la tecnica è molto connessa all’idea di “sottrarre”, non di “mettere”, anche per questo prediligo le forme brevi, sento cioè che un eccesso di parole sia una debolezza. E non lo direi di un libro di storia. Un libro di storia, se deve raccontare le Crociate, sarà lungo, poveraccio, ci sono state tante crociate, tanti turchi. Perché Guerra e pace è bello? Perché poteva essere cinque volte tanto. Quindi c’è sempre, anche nel libro enorme, l’operazione di sacrificare degli elementi.
Da aspiranti editor la ringraziamo anche per aver trasformato la risposta in una breve e preziosa lectio.
Se quando leggo un libro capisco subito che qualcosa è stato tolto e quindi è immaginabile in maniera più efficace, allora è stato fatto un buon lavoro. Come dicevo prima, però, come non possiamo chiedere al regista di montare i suoi film o al regista teatrale di fare il live design della scena, così non possiamo chiedere allo scrittore di arrivare col compito già fatto. Perché purtroppo la dimensione estetica ha una regola: buona la prima non esiste mai, non può esistere, se non per un caso che confermerebbe la regola. È chiaro che nella prima stesura vengono fuori delle frasi belle, ho 57 anni, scrivo da quando ne ho 20. Qualcuna viene, ma non è quello il lavoro che mi interessa.
Lei pensa che a Rocco e Pia sarebbe piaciuto il suo racconto?
Questa è una domanda terribile. Non sai quanto io, Rocco e Pia abbiamo litigato, esisteva un rapporto molto ironico tra noi. Senza dubbio la persona a cui sono più interessato da questo punto di vista è Pia, perché su Pia sono stato necessariamente più indelicato. Rocco ha scritto dei libri palesemente autobiografici, quindi quando ho raccontato della sua crisi maniacale dopo che lui ne aveva già parlato in un suo libro pubblicato da Mondadori (L’apparizione), tutto sommato la mia indelicatezza è rimasta solo nei particolari.
Vi racconto un fatto che mi ha colpito: un anno dopo la morte di Rocco, lo racconto nel libro, avevo fatto l’editing del suo ultimo romanzo che è uscito postumo, quindi c’era un piccolo abbozzo di quello che poi avrei scritto nella stesura finale. Non ho potuto tacere che Rocco beveva, perché il suo bere era intrinseco nella sua infelicità, nella sua scrittura. Ho descritto il peggiorare costante della situazione, così come ho descritto quel bellissimo nuovo patto con la vita che aveva raggiunto, senza volerne fare un eroe romantico. Poi ho avuto modo di sentire la madre, era molto contenta del lavoro che avevo fatto, ma anche dispiaciuta, chiaramente, e io stesso ho provato una totale empatia. Nel suo ultimo romanzo sono descritte cose terrificanti, però io poi ho messo del mio.
Tornando alla domanda principale, io credo che gli sarebbe piaciuto, perché erano consapevoli che la resa del personaggio letterario ha delle esigenze, come parlare di dettagli indelicati, soprattutto se la persona descritta corrisponde a una persona reale. Esattamente come Flaubert è indelicato con Madame Bovary, anche se Madame Bovary è un pupazzo e fa quello che vuole l’autore. Queste sono persone reali ed è difficile capire bene il limite. Io ho solamente una regola empirica: se l’omissione di un’informazione non mi crea un guasto estetico (che vuol dire? Non che sia scritto bene o male,a chi importa, sono tutti buoni a scrivere bene, ma se la forma di quello che scrivi non produce immaginazione), allora la tolgo perché io ho il culto della privacy. Passo per scrittore indelicato perché tutti i miei libri sono pieni di indelicatezze. Figuriamoci. Ho scritto un libro su Laura Betti, uno su Amelia Rosselli, e ogni volta mi si è posto questo problema. Se, invece, la mia omissione danneggia l’immaginabilità del personaggio, per così dire, io ho due scelte: o rinunciare a scrivere quel libro o essere indelicato. A volte ho rinunciato, a volte sono stato indelicato. Non c’è scampo. Te la puoi cavare ogni tanto togliendo delle cose. Ho notato che in questo periodo si discute tanto della legge contro l’omotransfobia; molte volte nei miei racconti e nei miei romanzi ho celato l’orientamento sessuale dei protagonisti, e ciò non ha creato nessun tipo di guasto nell’informazione estetica. Quindi ogni volta che posso usare delicatezza, la uso. Mi può piacere, come piace a tutti i romani, spettegolare, ma credo che tutto quello che ho detto delle persone di cui scrivo sia esente da pettegolezzo, perché il pettegolezzo non ha alcun valore estetico. Un grande maestro della critica letteraria che era Cesare Garboli diceva che «il pettegolezzo è un’altra dimensione della realtà. Non è né vero né finto», è terribile ma è così. È la fama che hanno le persone, ma questa fama non ha nessun significato narrativo perché è ondivaga.
Rocco e Pia erano due narratori e anche loro hanno scritto indelicatezze. Penso che sul piano artigianale ci saremmo intesi. E poi credo che sarebbero stati concordi nel dire che il brutto della vita è non riuscire a dirsi «ti voglio bene» prima che sia troppo tardi. Questa cosa, grazie a Dio, la racconto nel libro, non è successa. Quindi tutto sommato non c’è differenza tra la vita e la morte. Ci siamo voluti bene, ce lo siamo detto, ci siamo aiutati moltissimo, siamo anche intervenuti nei momenti difficili della vita di ognuno. Gli ho potuto dire in questo libro che gli volevo bene perché lo sapevamo anche da vivi. Non mi immagino di scrivere un libro su una persona che mi è stata sempre indifferente o che ho sempre odiato e solo dopo la morte scopro che ha dei valori.
Torniamo all’editing. Nelle ultime pagine del suo romanzo ci racconta la sua esperienza di editor dell’ultimo libro di Rocco Carbone. Lei è una delle poche persone a conoscere la sua intima essenza, quella di autore visceralmente attaccato alla lingua scritta, quindi come si è approcciato a un lavoro di revisione così impegnativo?
Questo è un aspetto molto importante del «nostro» lavoro. Ho lavorato per Fazi per anni, ho avuto ogni tanto delle consulenze, mi hanno chiesto privatamente degli editing, lavori di cui sono stato onorato. Ma in realtà ho fatto poco lavoro editoriale nella vita, e questo libro può essere interessante per questo. A differenza di Pia, il cui lavoro sul russo considero straordinario perché assomiglia molto alla mia maniera di scrivere, Rocco aveva un’idea della scrittura molto legata alla lingua scritta. Noi avevamo sempre degli scontri e ci divertivamo molto a prenderci in giro. Se lui diceva «il televisore», io gli facevo notare che nessuno più lo chiama in quel modo e che se si entra in un negozio di elettrodomestici chiedi «una televisione». E allora lui ribatteva che «la televisione» è quella che fa male ai giovani. Lui parlava di «automobile», io di Ritmo, Punto ecc. Questo perché ho sempre pensato alla scrittura come rappresentazione del parlato.
Il fatto che eravamo opposti è stato molto vantaggioso, per questo editing molto doloroso.
Voglio anche raccontarvi di una mia superstizione: per me non bisogna fare mai due libri di seguito con lo stesso editore. Il mio agente dice che è la cosa più cretina che abbia mai sentito nella sua carriera, ma io sono convinto che sia divertente. Anche se ci sono delle eccezioni. I miei punti di riferimento sono stati Ponte alle Grazie e Vincenzo Ostuni. Mentre l’editing di Desiati – una persona che scrive in uno stile diversissimo dal mio –, ha un effetto straordinario, con Vincenzo ho altri vantaggi: una grande complicità e la fortuna di interfacciarmi con una persona che la pensa come me sulla letteratura. Però a lui piace quello che scrivo, quindi il lavoro è in qualche modo limitato. Con quello che ci piace diventiamo complici, quindi manchiamo di esercitare una funzione essenziale, che è quella dell’avvocato del diavolo, fondamentale nel lavoro di editing. Ci sono due poli. Per me Vincenzo è irrinunciabile perché mi ha dato tanto e mi ha incoraggiato in momenti particolari della mia vita. Sono stato fortunato perché i miei libri hanno avuto successo, sono stati ristampati, però come capita c’è stato quello che non è andato meno bene perché uscito nel momento sbagliato, e riprendere da lì è psicologicamente difficile. Il motore della letteratura è desiderare che le persone ci vogliano bene. Mario in quelle occasioni non mi sarebbe stato utile. Non penso quindi che uno dei modi di rapportarsi sia superiore all’altro, però non possono coesistere. C’è il polo della complicità e c’è il polo del miglioramento. Con Vincenzo facciamo degli editing bellissimi perché è scrupoloso, mi aiuta a eliminare le contraddizioni. Però a lui devo un altro tipo di aiuto, come il sentirsi dire: «Guarda stai andando nella strada giusta. Se un libro non è andato come volevi non conta».
Ho in mente una trilogia di cui ho già pubblicato Qualcosa di scritto e Sogni e favole, e ho in progetto un terzo libro, e ci lavoro con lui. Il mio istinto mi dice che in questa impresa, adesso che mi sto avvicinando alla sessantina, voglio vedere se riesco a dare tutto me stesso: ho un modello, che è Philip Roth, che ha scritto tutti i suoi capolavori come Pastorale americana tra i sessanta e i settanta. Come lui molti scrittori che amo si sono spremuti fino in fondo.
Per quello che riguarda il me editor senza dubbio l’episodio che racconto sul libro di Rocco è più simile all’editing di Mario Desiati che a quello di Vincenzo Ostuni, riassumibile nella formula «guarda, questa cosa io la capisco, ma avrei un’opinione completamente diversa». Quindi arrivare a un risultato è stato difficilissimo, perché Rocco è morto in un incidente di moto, lasciando un testo straordinariamente incompiuto e lontano da quello che si chiama «portare a regola d’arte». E lì non bastava l’editore, non bastava Mondadori, perché bisognava addirittura retrocedere al livello delle intenzioni. Per quello lo potevo fare solo io.
Tracciando il profilo umano di Rocco, ci consegna una vita riflessa, vissuta in una sorta di rispecchiamento con personaggi letterari (Ciccio Ingravallo, Jay Gatsby, Martin Eden) ma ci invita anche a considerare come deformanti gli specchi letterari. La letteratura, dunque, è cattiva maestra o filtro che ci allontana dalla vita vera?
Spesso mi chiedo cosa mi commuova nella letteratura. Non è del tutto vero che Rocco assomigliava a Ingravallo di Gadda o a Gatsby di Fitzgerald. Era diverso, ma commosso dall’unicità di quei personaggi, dal fatto che non c’era nessuno uguale a loro al mondo. Quindi tutti i personaggi commuovono e possono creare identificazione, perché dopotutto la letteratura ci dice che nessun essere umano è identico a un altro. E la bellezza stessa, che è stata definita innumerevoli volte da innumerevoli filosofi e professori di estetica, tutto sommato si riduce a questo. Sono diverso da ogni altro essere umano e questo mi rende prezioso, mi fa diventare un dio agli occhi degli altri. Certo, c’è il dio crudele, il dio stupido. Per questo ho parlato di specchi illusori, altrimenti sono delle identificazioni psicologiche che non reggono alla prova dei fatti e del tempo. Noi siamo come nessun altro. È questo il punto ed è una condizione che esisteva molto prima che Flaubert scrivesse Madame Bovary, dove Emma Bovary è malata di identificazione. Il bovarismo è questa malattia. Madame Bovary vuole vivere la vita dei suoi personaggi e quindi finisce suicida, perché la vita non è che non sia come un romanzo, ma è un romanzo diverso da quello che leggi. Non se l’è inventato Flaubert. Il povero Don Chisciotte diventa scemo a leggere le avventure dei cavalieri antichi e va in giro col cavallo zoppo e i mulini a vento. Questo tipo di personaggio ricorre in tutta la letteratura, soprattutto tra i grandi. Pensiamo a Jane Austen che ha scritto L’abbazia di Northanger dove la protagonista, Kathleen, è una meravigliosa imbecille che vive in un romanzo horror (gotico a quei tempi): ovunque va vede fantasmi, intrighi, trabocchetti, scale segrete, e questo perché legge sempre romanzi. Gli scrittori prendono in giro questo assurdo effetto di deriva, cioè l’identificazione con il personaggio narrativo. In Rocco ce n’erano due preminenti, esplicitamente dichiarate da lui, perché mi diceva che si sentiva da giovane il personaggio di Gadda, e poi andando avanti nel tempo si è sentito come Gatsby. Ma devo dire che durante la scrittura ho realizzato che Rocco era migliore, molto più unico di entrambi questi due personaggi solamente letterari.
Revisione a cura di Manuela Altruda