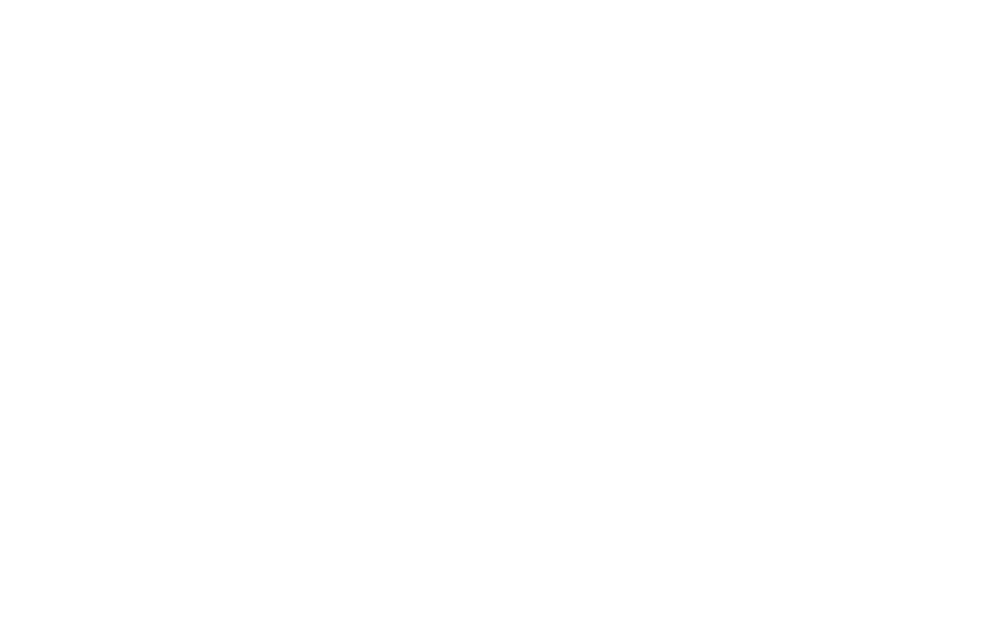In occasione delle Giornate della traduzione letteraria il blog delle edizioni SUR ci racconta le esperienze di alcuni traduttori, protagonisti delle Giornate. Diverse realtà, culture di riferimento e percorsi a confronto, senza escludere qualche consiglio per i traduttori di domani. Ecco un’intervista a Lorenzo Flabbi, critico letterario e editore.
Lorenzo Flabbi è il traduttore, fra gli altri, di Annie Ernaux, vincitrice del Premio Strega europeo 2016 con il romanzo Gli anni. Ringraziamo il traduttore per averci concesso questa intervista e per aver condiviso la sua esperienza. Buona lettura.
Edizioni SUR: Spesso chi desidera avvicinarsi alla traduzione, oltre a una grande passione per la letteratura, ha studiato una o più lingue straniere. Conoscere una lingua a un livello avanzato non è però sinonimo di essere dei buoni traduttori. Da cosa dipende una buona resa del testo, oltre che da una conoscenza approfondita della propria lingua madre? Studio, letture o una dota innata?
Lorenzo Flabbi: Da tanti anni mi interpella un’affermazione di Giovanni Giudici, riferita all’ambito della traduzione poetica ma estendibile al complesso della traduzione letteraria: «anche un espertissimo della lingua straniera, di cui si serve la poesia da tradurre, cade in problemi se non lo sia altrettanto in quella lingua straniera di grado ulteriore o lingua straniera tout court che è la lingua poetica». A significare quanto sia decisivo non tanto conoscere la lingua fonte o quella d’approdo quanto quella vera e propria “terza lingua” che è costituita dal linguaggio poetico, con i suoi codici e toni, le sue grammatiche interne, il suo precipuo ed elaborato armamentario di espressione linguistica. La traduzione di Giudici dell’Onegin di Puskin è in questo senso davvero esemplare: pur conoscendo poco il russo, si cimentò nell’impresa facendosi aiutare da una russista assai competente per tutti gli aspetti di comprensione del testo, e poi reinventò una prosodia che ruotava attorno all’utilizzo del novenario (un novenario molto elastico, variabile, ma con frequenti ricorrenze di accentazione) per riprodurre le tetrapodie giambiche dell’originale, ossia attinse alle sue capacità di scrittura in quella “terza lingua” letteraria che non è né il russo di Puskin, né il suo italiano, bensì – appunto – il peculiare linguaggio della poesia. Così facendo ci ha dato dell’Onegin una versione pur molto contestata ma che, secondo me, è assai convincente. Ovviamente se si snobba, ignora o disprezza il discorso ritmico un approccio del genere può essere considerato fuorviante o addirittura scandaloso.
Sempre al proposito ricordo anche l’incontro fiorentino tra Eugenio Montale e il grande poeta americano Robert Lowell, entrambi intelligenti traduttori dalle rispettive lingue, che una volta faccia a faccia si accorsero di non essere in grado di comunicare fluentemente né in italiano né in inglese e finirono per passare il pomeriggio passeggiando sul lungarno a cantare arie d’opera. Questo per dire che ciò che deve essere dato per scontato non è tanto la conoscenza della lingua del testo originale quanto una sua piena comprensione. Poi, per far veloce, si dice (io stesso l’ho detto più volte) che una buona conoscenza della lingua originale sia indispensabile e che, da un certo punto in poi, debba venir data per scontata, ma in realtà ciò che si intende è che la reale condizione necessaria per una buona traduzione è la giusta comprensione dello specifico testo che si sta traducendo, il quale utilizza la lingua storica in un suo specifico modo con specifici risultati. Se non si individuano questi fattori all’interno del testo difficilmente li si saprà riprodurre in traduzione. Per usare la metafora del testo come gioco, se non si conoscono le regole con cui è stato scritto l’originale la partita della traduzione sarà piena di falli e infrazioni. Per tornare all’esempio di partenza, un perfetto conoscitore del russo che non si curi del portato propriamente poetico di Puskin potrà rivelarsi poco adatto alla tradizione dell’Onegin quanto un capace versificatore che sappia dire al massimo Oci ciornie: credo che per tradurre l’Onegin (e qualsiasi altro testo) siano necessarie entrambe le competenze. Che le si posseggano in via preliminare o ce le si facciano preparandosi ad hoc in prospettiva di una traduzione, in fondo poco importa.
ES: Tradurre autori viventi vs tradurre classici. Quanto è importante il confronto con l’autore? Quando non è possibile contattarlo come cambia l’approccio al testo?
LF: Non ho mai contattato alcun autore per sottoporgli questioni di traduzione, neanche quando con l’autore stesso c’era già un rapporto in corso molto solido. La tentazione di farlo, certo, l’ho avuta molte volte, ma in ogni caso credo che il traduttore debba sempre prendersi la responsabilità del suo testo, e dunque delle sue interpretazioni. A una terza, quarta, quinta rilettura, anche del passaggio più ingarbugliato si può trovare una resa coerente, e spesso ciò che sulle prime era apparso ambiguo si rivela invece univocamente connotato. Poi se l’ambiguità è davvero presente nel testo di partenza, allora sarà compito del traduttore decidere se cercare una strada per mantenerla anche in traduzione o se optare per una sola delle possibili interpretazioni (magari perché si ha a che fare con una paranomasia, un pun, un gioco di parole strettamente ancorato alla lingua fonte), e tradurre di conseguenza. L’autore in un certo senso può soltanto velocizzare il lavoro e dirti subito “guarda che io qui intendevo questa cosa qua”, ovverosia qualcosa che, prima o poi, si sarebbe capito comunque anche da soli.
ES: Hai mai riletto la tua prima traduzione? Cosa si prova a rileggersi dopo tanti anni?
LF: Penso di aver cominciato a tradurre sulla Smemoranda, mi ricordo di averci provato con Chimes of Freedom di Dylan che all’epoca era la mia canzone stracciacuore. Quel diario non l’ho più aperto, ma è verosimile che si trattasse di qualcosa di piuttosto immondo. La mia prima sfida realmente impegnativa è stata qualche anno dopo con The Waste Land di Eliot, sul quale mi stavo laureando. Ne esistevano già moltissime, dalla prima di Mario Praz (in seguito scopiazzato al limite del plagio) a quella di Roberto Sanesi e Alessandro Serpieri e altre, ma per lavorare criticamente su un testo così complesso, fertile e pieno di rimandi mi era parso necessario attraversarlo con una mia rilettura linguistica personale. Non so dire quanto sia una buona traduzione, ma so di per certo che la Waste Land mi si è aperta tra le mani come mai prima, svelandomi segreti che mi erano stati fino ad allora nascosti (che poi sia stato capace di portarli con efficacia nel mio italiano è tutto un altro discorso). Dalla letteratura secondaria sapevo ad esempio che in vari passaggi erano presenti in filigrana i poeti metafisici inglesi del Seicento, ma le implicazioni prosodiche di questa traccia intertestuale mi si sono chiarite soltanto quando ho provato a cimentarmi a mia volta in un’imitazione italiana della versificazione di Donne e Vaughan. È una traduzione privata a cui torno ancora oggi e con la quale mi confronto non tanto per giudicarne la tenuta linguistica quanto per individuare come, da allora, sia cambiata la mia percezione di quel testo tanto potente.
Per quanto riguarda la prosa come molti ho cominciato traducendo letteratura commerciale, anche utilizzando giochi di pseudonimi che mi divertono da matti ancora oggi per motivi profondamente ininteressanti per chiunque non sia io. Spero vivamente di essere oggi un traduttore migliore rispetto a quindici anni fa, e spero di essere qui tra quindici anni a sperare di essere un traduttore migliore di oggi.
ES: Quanto è o non è riconosciuto il mestiere del traduttore? In un mondo ideale, quale prassi dovrebbero adottare gli editori per tutelare e valorizzare la categoria?
LF: Sono due domande molto importanti, legate tra loro ma nient’affatto identiche. Sulla prima questione voglio dare una risposta ottimista, poiché mi pare che da tempo ci sia un interesse crescente attorno alla figura dei traduttori (questa stessa serie di interviste ne è una prova) e alla tematica della traduzione in generale (soprattutto a livello teorico, con specifiche discipline quali i Translation Studies anglosassoni, la traductologie francese e la critica della traduzione italiana). Esiste una letteratura critica assai florida che riflette su questi temi, e ne approfitto per citare il libro che sto leggendo ora – ricchissimo, una gioia – ossia Traduzioni estreme, che Franco Nasi ha pubblicato per Quodlibet l’anno scorso. La sfida ancora ampiamente aperta è quella di esportare questa sensibilità al tradurre fuori della cerchia degli specialisti e dei lavoratori dell’ambito editoriale.
Per quanto riguarda il secondo punto invece che dilungarmi qui voglio rimandare a un documento esterno. Per concretizzare anni e anni di riflessioni, l’ODEI (l’Osservatorio degli Editori Indipendenti) e Strade (il Sindacato dei traduttori editoriali) hanno elaborato un protocollo d’intesa in cui si sono riassunti in cinque punti chiari ed esaustivi le buone pratiche editoriali di cui avvalersi affinché traduttori e editori possano lavorare in un contesto sano. È a quel documento, che come editore sono stato incaricato da Odei di compilare assieme alla traduttrice Elisa Comito di Strade, che rimando per rispondere alla seconda domanda. Questo è uno dei link per leggere il protocollo.
ES: Se non facessi il traduttore, cosa faresti?
LF: Io volevo fare il fisico, ma questo solo dopo aver capito che per fare il calciatore bisogna saper giocare a calcio e che per fare il rivoluzionario nella giungla c’era bisogno di una rivoluzione in corso e io non avevo neanche una giungla a disposizione.
ES: Consigli per un aspirante traduttore (fare un altro mestiere non vale come risposta).
LF: Credo che un buon consiglio dipenda, più che dal contenuto del consiglio stesso o dalla bocca che lo pronuncia, soprattutto dalle orecchie, dalla personalità e dalla situazione di chi lo riceve. Personalmente non sono proprio capace di elaborare buoni consigli di carattere generale che valgano per tutti. Trovo però molto incisivo, e molto utile per me, quello che soleva dare Svetlana Geier, che tradusse i «cinque elefanti» di Dostoevskij in tedesco, quando invitava i suoi studenti a tradurre «con il naso alzato». L’espressione può essere sibillina per chi non abbia ancora tradotto, ma chi ha passato ore giorni e mesi su un testo capisce subito cosa comporti: alzare lo sguardo dal foglio, far sedimentare l’originale, riformulare se è il caso, e scrivere la traduzione con gli occhi levati al cielo, come i fratelli del silenzio eterno di Baudelaire, cercando con lo sguardo una forma in quella suggestiva ipotesi di Übersprache di cui parla Benjamin.
ES: Sei un traduttore ma anche un editore, un editor e un revisore: quali diverse scelte comportano questi diversi ruoli?
LF: Allora, editore e traduttore a volte litigano come Sandra e Raimondo: i soliti bisticci sulle solite cose, ossia le scadenze. Dal canto suo, il revisore va molto d’accordo con il traduttore ma è in soggezione rispetto all’editor, il quale a sua volta se la prende con l’editore perché ha sbagliato traduttore. Insomma, è un condominio un po’ rissoso. A fungere da amministratore, che riappacifica gli animi, ci pensa l’uomo delle pulizie, che essendo una figura privata sa ricomporre i conflitti pubblici ed è abituato a gestire quelli del foro interiore.