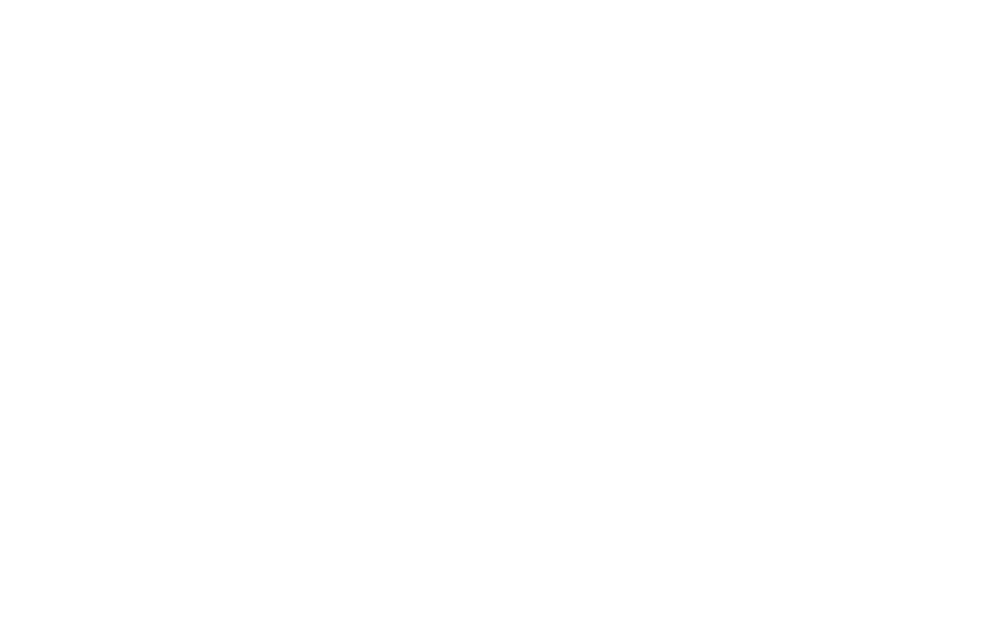In attesa della terza edizione di Effetto Strega – l’appuntamento annuale in cui la Scuola del libro incontra gli scrittori della dozzina del Premio Strega, e che si svolgerà presso la libreria Giufà il prossimo 5 giugno – gli studenti del master «Il lavoro editoriale» (Marianna Pula, Luca Spinelli, Andrea Russo) hanno intervistato Andrea Pomella, Anni luce, add editore.

Il tuo romanzo Anni luce è un’opera di non fiction. In questo periodo in Italia c’è sempre più interesse verso questa forma di letteratura, basti pensare alla dozzina del premio Strega di quest’anno. Il tuo però è anche definito un romanzo di formazione, Nadia Terranova lo ha splendidamente definito “un racconto di amicizia e di crescita che somiglia all’interludio che precede l’età adulta”. Per te che sei sia giornalista che scrittore, quanto è importante oggi, nella letteratura, riuscire a creare un’opera che sappia contaminarsi, attraversando più generi? Sarebbe stato più o meno facile scrivere il libro come fosse un’opera di fiction?
Ho avuto un’inversione di rotta nel 2013, quando ho pubblicato l’ultimo romanzo La misura del danno (Fernandel, ndr), un romanzo completamente di fiction. Da allora ho cominciato ad avvertire, prima che come autore principalmente come lettore, una fase di stanca della fiction sia nella letteratura italiana che nella straniera. Mi sono accorto che facevo sempre più fatica a sottoscrivere il famoso “patto di sospensione dell’incredulità” e quindi, anche ammesso che l’autore fosse veramente bravo, mi sembrava che l’opera non mi lasciasse sostanzialmente nulla o comunque mi lasciasse poco. Al contrario la non fiction aveva questa capacità – anche qualora non fosse un’opera completamente riuscita – di arrivarmi in una maniera dirompente. E così, dieci anni fa ho aperto un blog per fare degli esercizi di scrittura. Tra i miei esercizi più banali c’era quello di descrivere, anche cinque minuti, un giro per un quartiere e descrivere anche qualcosa di poco importante, ad esempio un giro fatto per tre vie in cui non succede assolutamente nulla, descrivendo quel nulla e cercando di tirargli fuori comunque qualcosa. E questo è assolutamente un esercizio di scrittura non fiction. Da quel momento in poi mi sono buttato sul racconto di me. Facevo un gioco, da ragazzino, con i miei compagni alle elementari: davanti a una cartina geografica si sceglieva un toponimo e gli altri dovevano trovarlo sulla cartina; tutti sceglievano il toponimo più breve. Un giorno io ebbi questa intuizione, lessi una cosa grande, tipo Mar Mediterraneo, ma nessuno la trovava. La stessa cosa mi è successa con la non fiction. Il mio interesse non era quello di creare storie ma raccontare qualcosa di molto più profondo relativo comunque all’ambito umano e avevo sotto gli occhi qualcosa di molto grande che non vedevo, che ero io, le mie esperienze di vita, il mio stare nel mondo.
Anni luce lo avevo in testa da parecchio tempo, ma non ho mai trovato la chiave per entrare nella storia, se avessi inventato una storia ambientata negli anni Novanta avrei fatto molta fatica a costruire una trama e i personaggi. La cosa migliore uscita sugli anni Novanta e sulla descrizione di quell’epoca è Trainspotting; se anche fossi stato così bravo da riuscire a scrivere un romanzo sugli anni Novanta probabilmente il gioco non valeva la candela, perché avrei fatto una fatica enorme per arrivare a restituire una verità invece molto parziale rispetto a quella che credo di essere riuscito a restituire raccontando direttamente di me, mettendomi in gioco, e costruendo un percorso ibrido di narrazione. Avevo la mia storia personale, delle riflessioni che avevo sul grunge, la depressione. C’erano tanti argomenti in ballo, dovevo semplicemente sistemarli, trovare una chiave d’accesso e darmi alla pagina completamente. Tra l’altro ho scoperto, dandomi alla non fiction, di riuscire a scrivere con una libertà e facilità estreme producendo anche cinquemila/diecimila battute al giorno. Non ho dovuto fare un lavoro ulteriore di affinamento, perché avevo trovato una mia voce e questo nella vita di un autore è un’epifania. A me è successo tardi, dopo vent’anni di apprendistato e pratica concreta della scrittura, ma quando è successo è successo qualcosa di importante.
Il nostro master alla Scuola del libro si focalizza su tutti i mestieri dell’editoria, particolare rilievo si pone sul lavoro di editing sul testo e del rapporto tra editor e autore. Considerata la peculiarità del tuo romanzo, puoi parlarci del lavoro che c’è stato con la casa editrice Add? In cosa l’editor ha maggiormente influito nella stesura finale di questa opera di non fiction?
Questo è un aspetto interessante perché a me inizialmente avevano chiesto un’altra cosa. Add ha la collana Incendi, “le passioni incendiano le vite” in cui un autore racconta una sua passione. Io ho scritto un pezzo per il venticinquennale dell’uscita di Ten in cui raccontavo anche una parte della storia che poi ho riportato in Anni luce. L’editore mi ha chiesto di realizzare qualcosa di più lungo sui Pearl Jam e sul modo in cui avevano acceso la mia vita. Scritto il libro, nel momento in cui dovevo consegnarlo mi sono reso conto che in realtà c’erano non i Pearl Jam, ma mi ero concentrato molto anche su altri aspetti, soprattutto sul racconto di una amicizia. Non sapevo se per l’editore andasse bene. Ho detto loro: «Ho scritto questo, non so se per voi vada bene lo stesso, a me è venuto fuori così». E loro invece hanno risposto: «Sì, ci piace moltissimo, anzi, forse ci piace di più di quanto potevamo aspettarci». Hanno voluto leggerlo come un romanzo di formazione – anche se non sono totalmente d’accordo – e come tale hanno fatto una sorta di inversione di tendenza rispetto alla collana, hanno inaugurato un filone di narrativa e hanno addirittura aggiunto l’etichetta romanzo sulla copertina. Io il problema del genere non me lo sono posto (questo è un problema che si pongono i critici, i giornalisti culturali e i responsabili commerciali), il rischio per me era che questo libro finisse tra i libri musicali e quindi avesse una visibilità di gran lunga inferiore rispetto a un romanzo. La fase dell’editing è stata molto semplice, non ci sono stati grossi cambiamenti, l’editor Stefano Delprete si è subito sintonizzato con la struttura del libro così come l’avevo ideata io. È stata una scoperta anche per lui, perché si aspettava un libro diverso e ha dovuto fare un editing di un altro tipo rispetto al solito.
Nel tuo libro c’è sempre un riferimento al tempo. A un certo punto del racconto infatti lo metti in relazione ai rapporti umani che cambiano (“prendere a pugni il tempo che era passato, l’angoscia di essere diventati uomini”): forse ci accorgiamo del tempo che scorre solo quando prendiamo consapevolezza di quante e quali relazioni si siano deteriorate con gli anni. La stesura del libro ti ha aiutato a riconnetterti con una parte del tuo passato portandoti a guardare con occhi diversi agli eventi di quel periodo?
Quella del tempo è una delle questioni centrali del libro. In genere quando scrivo sono molto freddo rispetto alla materia che tratto, ma in questo caso è stato difficile. Ho cercato di mantenere un controllo per non restituire un’idea di nostalgia. Non volevo scrivere un libro nostalgico, tutt’altro, io volevo quasi infierire su quegli anni sia in senso generazionale che sulla mia stessa vita privata, cercando di non fare sconti né alla materia che è fuori di me né soprattutto alla materia che è dentro di me. L’aspetto del tempo l’ho considerato molto perché ho sempre avuto questa sorta di maledizione – me la ricordo benissimo, ce l’avevo anche a vent’anni –, avevo la percezione in essere, in divenire, del tempo che scorre, nel senso che quando si è giovani non si pensa che quella sia un’età effimera e che finirà. Io invece ne avevo consapevolezza e questo mi faceva soffrire, tant’è che non mi godevo mai il presente perché ero già con la mente proiettata al futuro, al momento a cui avrei riguardato al passato, facevo in qualche modo un doppio salto carpiato! (ride, ndr), avevo già nostalgia del passato quando ancora lo stavo vivendo. Questa condizione era quasi invalidante, nel senso che non mi ha consentito di godermi il presente sotto molti punti di vista, compreso quello musicale. Coi Pearl Jam ho fatto un’eccezione, lo dico nel libro, sono stati probabilmente l’unico gruppo a me coevo che ho saputo apprezzare fin da subito, perché in genere sono molto scettico rispetto al tempo presente in quanto lo valuto rispetto al passato, già come storicizzato
Questo libro ha avuto un ruolo catartico per te?
No, non è stato catartico. Ho avuto tanto tempo, venticinque anni, per riflettere su quegli anni e a un certo punto più che avere un effetto catartico le cose si sono allineate, in modo tale che sono riuscito in poco tempo a riordinare tutte le idee e a restituirle secondo il flusso che poi è quello che vedete nel libro. Tra l’altro mi è successa una cosa importante, a livello tecnico di stesura. Ho fatto un trasloco, l’anno scorso, durante il quale ho ritrovato il taccuino di viaggio che tenni all’epoca, un taccuino con le pagine ormai distrutte perché era rimasto confinato dentro una scatola per venticinque anni, ingiallito, scritto a mano, in cui appuntavo ogni spostamento, gli orari dei treni, persone incontrate, tutto. Questo ovviamente è stato fondamentale per recuperare il tempo perduto perché senza di questo almeno una parte del viaggio nel libro non sarebbe stata così dettagliata e non avrebbe avuto nemmeno quel suono che hanno le pagine di Jack Kerouac, che a volte sono un continuo rimandare a toponimi che da soli ti danno l’idea del viaggio, quasi monotono, che però restituiscono un’idea dell’incontro con un luogo che il lettore non conosce, anche col semplice suono di una parola.
Oltre che musicali, sono tanti i riferimenti letterari all’interno del libro. Uno di questi è proprio Jack Kerouac. A un certo punto del romanzo tu e Q – il coprotagonista del libro – scoprite la strada, salite su un treno che vi porta verso destinazioni sconosciute e vivete alla giornata, suonando nelle piazze delle città. L’esperienza del viaggio che avete compiuto per l’Europa sembra essere stata così importante che è diventata la parte principale del testo. Qual è stato il senso del vostro viaggio? È stato il desiderio di esplorare e rompere i confini?
Il viaggio è la sublimazione di un po’ tutta l’amicizia fra me e Q. Io avevo questa abitudine ogni anno: quando arrivava la primavera leggevo Sulla strada, aprivo l’atlante sulla pagina degli Stati Uniti d’America e seguivo, man mano che leggevo, la rotta che loro seguivano lungo le strade d’America. E l’ho fatto per vari anni, al punto che ancora oggi, guardando una foto di Kerouac, mi sembra quasi di vedere un amico di gioventù, perché avevo reso i personaggi quasi carnali.
Quando ho conosciuto Q mi è sembrato di incontrare il mio Dean Moriarty, perché era un personaggio molto simile a Dean: un pazzo scatenato, completamente sfuggente rispetto agli atteggiamenti che voleva avere nei confronti delle altre persone, del mondo stesso.
Per cui il viaggio è venuto quasi in maniera naturale. E non volevamo rompere i confini, perché in realtà non c’erano. Questo era il bello degli anni Novanta e dell’Interrail, che purtroppo stiamo perdendo. E questo è un po’ l’aspetto politico del libro, nel senso che noi abbiamo tentato concretamente di fare l’Europa. Ci trovavamo a casa ovunque andassimo: sia in Olanda, sia in Inghilterra, che in Scozia. Ovunque tranne che a casa, a casa nostra, difatti noi le case le distruggevamo anziché averne cura. Per noi l’Europa era un posto vivo, veramente unito, mentre oggi se nomini la parola Europa le persone si allarmano, come fosse un mostro, evocato soprattutto in campagna elettorale.
Douglas Coupland ha definito i ventenni degli anni Novanta come Generazione X. Era una generazione depressa e spaesata ma votata istintivamente alla fiducia nel prossimo, desiderosa nonostante tutto di momenti semplici, quasi ad ambire una quiete domestica. Pensiamo alla musica dei Pixies e degli Smashing Pumpkins, con momenti di ferocia accanto a pause eteree, anche molto tenere. Di contro, i giovani di oggi che crescono con la cultura del sospetto, che hanno possibilità di comunicare molto superiori a prima ma allo stesso tempo si ritrovano più isolati, che riescono facilmente ad appagare i propri bisogni e vivono senza la necessità di mitizzare nessuno se non la propria quotidianità. Che ruolo pensi abbiano avuto musica e letteratura in questo processo e quanta influenza avranno secondo te nella vita dei futuri adolescenti?
Io tendo sempre a non fare confronti rispetto al modo di fruire la musica e il mondo di oggi. Sto attento a non dire che quando ero giovane io era meglio, perché non lo era affatto. Ho scritto questo libro anche per mettere in evidenza quanto fossero anni difficili. È vero, c’era molta più fiducia nel prossimo, perché, perlomeno i ragazzi che frequentavo io, si portavano sulle spalle gli stessi problemi o comunque cose analoghe a quelle che avevo io e scatenavano la loro rabbia e il loro rancore nello stesso modo in cui lo facevo io. Alla fine ci trovavamo in maniera molto naturale.
E un po’ tutta quella generazione lì, anche da un punto di vista musicale, si è ritrovata per gli stessi motivi. Io, scrivendo questo libro, mi sono reso conto che Kurt Cobain, Eddie Vedder, così come Q e Squama, avevano problemi in famiglia, venivano da situazioni familiari difficili, proprio come poteva essere la mia. Non ne parlavamo mai, eppure reagivamo allo stesso modo, facevamo le stesse cose, ascoltavamo la stessa musica. Appunto, come accennato prima, il distruggere le case dal punto di vista psicanalitico è fondamentale e spiega molte cose: anziché andare a tirare i sassi alle camionette della polizia, preferivamo distruggere la casa.
Anche politicamente era tutto diverso: negli anni Novanta in Italia, ad esempio, c’era il movimento della Pantera. Quegli anni si aprono e si chiudono con Seattle e con il movimento di Seattle. Quindi c’era anche una spinta politica, però non era il mondo che mi apparteneva.
La situazione di oggi, rispetto a quella, è diversa. Ho affrontato un discorso con dei ragazzi delle scuole superiori che ho incontrato e che avevano letto il libro. Mi ha colpito moltissimo una ragazza perché le ho chiesto quali sono i mostri che combattono adesso. Lei mi ha risposto che attorno a sé vede solo mostri buoni, come se fossero programmati per tenere basso il livello della rabbia e che dunque il mostro è lei. Questa è risposta che mi ha fatto riflettere tantissimo, soprattutto per capire come percepiscono il mondo attorno a loro. Non so se la letteratura, la musica o qualsiasi altra forma d’arte siano vie di fuga. Io non credo nel potere salvifico della letteratura, nonostante io ci vivo e ci convivo. Penso che la letteratura, così come l’arte in generale, possa farti vivere meglio o peggio un certo periodo della tua vita, però non credo che ti cambi la vita e che ti devii in qualche modo. È un’esperienza talmente grande che non capita a tutti e non mi sento di generalizzarla. Può essere successo a voi una volta, ma ad altre mille persone no. Per cui non attribuisco questo potere alla musica e come tale non saprei dire se può essere oggi una risorsa in questo senso.
C’è anche una diversa fruizione della musica. Si ha a disposizione tanto e tutto. La fruizione è meno viscerale, per cui se io mi compravo Ten me lo dovevo sentire fino alla morte, anche solo per giustificare la spesa. Ora basta poco per avere tanto e disperdi l’attenzione, non ti arriva più con la stessa forza: lo ascolti una volta e passi al prossimo.
Nonostante il tuo sia definito un libro sui Pearl Jam, non ti definisci fan dei Pearl Jam…
Non mi definisco fan dei Pearl Jam perché non sono mai stato fan di niente. Cerco di mantenere sempre una distanza critica rispetto alle cose che mi attraggono e che mi piacciono. Questa distanza mi permette di dire che l’ultimo estratto è una schifezza, a mio modo di vedere. I fan sono riusciti a trovare del buono anche in quello, perché non devono tradire una fede, la accettano passivamente. Per cui io mi sono sempre tenuto a distanza dall’essere fan di qualcuno.
Io ho però cercato di fare una cosa che in genere è molto difficile. Ho cercato di fare un libro con una colonna sonora. Nei film è facile, perché c’è l’acustica e quindi attivi anche un altro organo, un altro sensore oltre a quello della vista. Nella scrittura no, perché ovviamente esiste perché tu leggi i segnetti sulla pagina e basta. Io ho cercato attraverso quei segnetti sulla pagina di trasmettere altro: se la letteratura riesce a trasmettere esperienze umane complicatissime, perché non riesce a restituire la musica? E ho provato a fare questo, ad incastrare le canzoni in modo tale da costruire una vera e propria colonna sonora. Ovviamente se tu conosci le canzoni, questo ha senso, se non le hai mai sentite puoi solo immaginarle e cercare di entrare nel mood. Per esempio, chi conosce bene le canzoni dei Pearl Jam mi ha detto che la parte in cui parlo di Rearviewmirror è proprio la traduzione in parole di quella canzone lì. È stato un esperimento di scrittura.