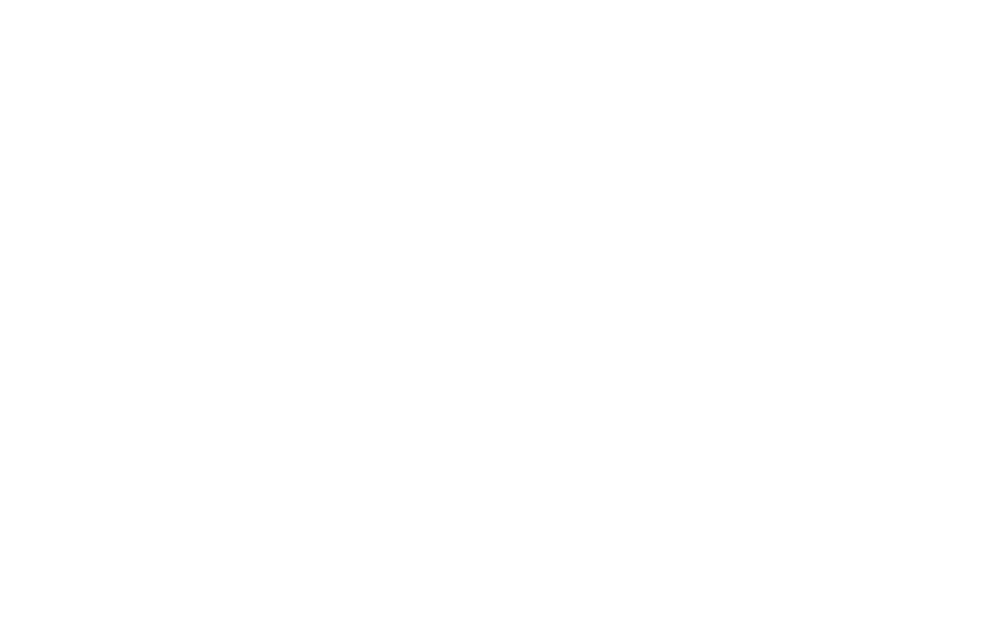In attesa della terza edizione di Effetto Strega – l’appuntamento annuale in cui la Scuola del libro incontra gli scrittori della dozzina del Premio Strega, e che si svolgerà presso la libreria Giufà il prossimo 5 giugno – gli studenti del master «Il lavoro editoriale» (Fabio Forgione, Laura Nunziati, Enza Sirtori) hanno intervistato Yari Selvetella, in semifinale con Le stanze dell’addio.

Yari, in alcune tue interviste precedenti, per esempio quella che hai rilasciato a Le parole e le cose a Radio Radicale, hai detto che il testo de Le stanze dell’addio l’hai scritto subito dopo gli eventi narrati ma prima della pubblicazione sono passati cinque anni, in cui non l’hai più preso in mano. Qual è stato l’evento o la persona che ti ha spinto a fare la scelta di riprendere e di lavorare ancora al libro, e a che stadio era il manoscritto?
Ci sono varie considerazioni da fare: il libro non è stato scritto per essere un libro. È stato scritto perché io volevo rendermi conto della reale consistenza di quello che era accaduto. Mi spiego meglio: a volte di fronte a una situazione traumatica si ha bisogno di dirsi che determinati eventi sono effettivamente accaduti, c’è una sorta di incredulità ed è strano risolverla proprio con un gesto che viene associato invece al mondo della fantasia, o dell’invenzione o dell’alterità, rispetto alla realtà. E invece vedere, leggere, sapere attraverso la scrittura è una presa di coscienza importantissima, ed è stato questo il motivo per cui ho scritto un quaderno, che è stato scritto così, a penna, nei bar, quando – suona un po’ retorico ma è vero – non avevo più lacrime. È stata un’esperienza così intensa che ho scritto questo quaderno, nonostante le molte altre incombenze; perché poi un evento di quel tipo genera tutta una serie di necessità burocratiche, di riorganizzazioni familiari e lavorative molto importanti. Inoltre c’era anche questo problema, che all’inizio neanche mi ponevo: il testo poteva risultare in un certo senso scottante perché coinvolgeva i miei figli, i bambini, e quindi non sapevo se fosse opportuno o no pubblicare una cosa del genere.
Poi c’è un’altra considerazione, e cioè che all’inizio, quando una persona viene a mancare, nei primi mesi, nei primi anni c’è un’aura d’attenzione, di considerazione molto forte su tutta la sua vita; invece poi man mano questa cosa, com’è ovvio, forse anche necessario che sia, tende a scemare. Un anno dopo la morte di Giovanna abbiamo fatto pubblicare il romanzo scritto da lei quando era in ospedale, sempre con quaderno e penna, che si chiama La Frattura ed è stato pubblicato da Elliot nel 2014. Le persone non hanno dimenticato Giovanna: chi l’ha amata, chi ha lavorato con lei, tanti scrittori che hanno pubblicato libri in cui dimostrano un debito di riconoscenza nei suoi confronti come editor. Dunque c’erano già stati tutta una serie di eventi e di ritualità che ci hanno permesso di ricordarla e in quel momento non c’era bisogno di questo mio testo.
Ma a un certo punto tutta la forza di questo ricordo prende la direzione del ritorno alla normalità, dell’assordimento della realtà, e forse era il momento di tirare fuori un ricordo di Giovanna, far circolare di nuovo il suo nome. Era importante anche per me.
C’è stato poi un altro aspetto, cioè quello di una mia volontà di segnalare al mondo ormai normalizzato della mia vita che questa era stata per me un’esperienza fondante; voglio che chiunque mi incontri sappia che io vengo anche da quel dolore, da quell’esperienza e da quell’amore. C’era anche un altro “scandalo” che volevo raccontare, e cioè di come, pur di fronte a un abisso così imprevisto, che si è aperto sotto i nostri passi, ci sia stata poi la possibilità di provare ancora dei sentimenti, di essere parte di questa vita. Questa non è una cosa così ovvia: i libri sul lutto o sugli amori perduti sono sempre, o spesso, celebrativi e parlano di irripetibilità dell’esperienza amorosa. Io invece la vedo in maniera un po’ più aperta e più laica, vedo l’amore come una pratica esistenziale, per cui, come lo si è provato una volta, bisogna poi essere capaci di provarlo ancora, altrimenti è un vicolo cieco; invece a me piace pensarlo come a una strada che porta sempre da qualche parte.
Nel gennaio del 2017 ho cominciato a pensare che forse si poteva pubblicare e la prima tentazione che ho avuto è stata di farlo leggere a delle mie amiche, delle persone che stimo. La prima è stata Caterina Venturini, una scrittrice, amica mia e di Giovanna. Subito dopo ne ho parlato con Chiara Gamberale. Ci siamo visti una mattina al bar, ed era il giorno della nevicata e del terremoto nelle Marche. Parlando le ho detto che avevo questo testo ma non sapevo bene cosa farci. Gliel’ho mandato e, dopo due o tre giorni, mi ha richiamato dicendomi: è un testo bellissimo, secondo me si può fare qualche cosa. Chiara l’ha passato a Giulia Ichino, l’editor di Bompiani che avevo conosciuto in Mondadori quando lavoravo al mio libro La Banda Tevere – la cosa curiosa è che io, in ospedale con Giovanna, scrivevo La Banda Tevere, una commedia a sfondo criminale, e invece poi, dopo l’ospedale, ho scritto dell’ospedale. Ecco, queste sono state le persone chiave. Poi con Giulia Ichino è cominciato questo lavoro editoriale, di desk editing parola per parola, che è stato molto bello e interessante. Il cuore del libro è rimasto praticamente uguale a come l’avevo scritto su quel quaderno; su suggerimento di Giulia ho inserito altri piccoli tasselli, due o tre capitoli che riguardano i momenti successivi. In realtà si tratta di un libro che potrebbe avere anche centottanta capitoli, perché è un libro che continua dentro di me.
Le varie sezioni del libro sono tutte introdotte da una citazione da Moby Dick e il mare, e tutto ciò che è legato ad esso, ritorna spesso nella narrazione. Quindi da un lato ti chiediamo, al di là di Moby Dick, se ci sono state altre opere, altri scrittori che hai avuto come punto di riferimento più o meno consapevole scrivendo il libro e dall’altro ti chiediamo qualcosa di più sul mare, quale funzione, quale simbologia gli attribuisci.
Diciamo che si è verificato l’effetto Fantozzi: avete presente quando la Pina si mette con il fornaio? Fantozzi apre tutti gli sportelli e trova sempre pane, sfilatini, rosette. A un certo punto gli viene il tremendo dubbio. Allo stesso modo io leggevo dei libri – non so, tre, quattro, cinque, sei – finché qualcuno mi ha detto; “Stai preparando un lavoro sul mare?”. Stavo leggendo solo libri che riguardavano il mare e non me n’ero accorto.
Tutta la narrazione è fatta di momenti biografici e quindi realmente avvenuti, alternati con un livello che è invece più narrativo, di fiction, di sogno. Come hai ideato l’equilibrio tra questi aspetti? O forse, data la tua prima risposta, è stato veramente tutto un unico flusso?
Bisogna pensarla così: tu immagina un oggetto che cade e si rompe. È facile immaginarlo come uno specchio, anche come una collana. Si dice anche, tradizionalmente, “si è sgranata la collana”, per indicare le disgrazie. Poi in che cosa consiste ritornare a vivere? In un tenace e paziente lavoro di riallineamento di tutte queste palline e nel trovare un filo che ci passi in mezzo.
Rimettere insieme un po’ i pezzi.
Rimettere insieme tutti i pezzi. Però, prima che questo accada o addirittura mentre sta accadendo, c’è un altro aspetto di questa operazione e cioè un momento della tua vita in cui tu corrispondi a una collana sgranata. È una sorta di contatto anche affascinante con una dimensione che allo stesso tempo è dolorosa e ti annienta, il contatto con la morte. Ti dici “io posso essere anche in questo squilibrio, sto respirando, sto vivendo, anzi addirittura sento tantissime cose”. Il dolore è anche un’apertura percettiva irripetibile; quello che io ho sentito di me stesso, di noi, di tutto quello che avevo vissuto fino a quel momento, di cosa rappresentavano per me i miei figli, di che cosa significava quel corpo morto davanti a me, è stato molto intenso. Spesso tornare alla normalità significa doversi assoggettare alla retorica dell’oblio, come in tutte le esperienze dei reduci. Questa stessa retorica dell’oblio prevede determinati punti chiave che non devono essere toccati, per cui per esempio il grande amore è il grande amore. Dopodiché, però, si mette una lapide sopra a tutto ciò che si è vissuto, un fiore e via. Invece io ho cercato proprio di fare il contrario in questo libro, cioè ho voluto essere in questa dimensione plurale. Anche questo determina e giustifica i cambi tra prima, seconda e terza persona. È una specie di salvavita: dove si scende troppo in basso in questo abisso, fino ai mostri – tornando all’immagine del mare –, dove la pressione è insostenibile, si arriva alla terza persona, perché non posso essere più io veramente a dirlo; dove diventa un sogno c’è l’impossibile, cioè la seconda persona, c’è questo tu che vaga nonostante ci sia un chiaro impianto laico nel libro. È proprio in queste schegge che c’è il mio riflesso, e quindi oltre alla riconquista di una razionalità c’è un’altra parte di me che ha deciso di continuare a leggere queste perline, a interpretare i segni di queste schegge.