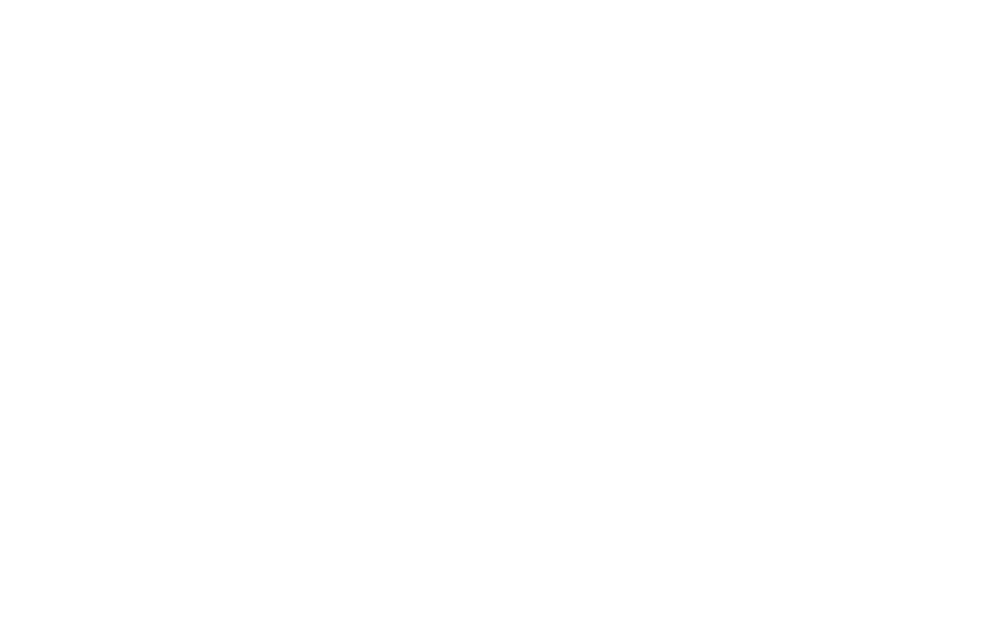La prima edizione di Alias, il nostro master in traduzione letteraria, è alle porte. Perché consiglieresti di frequentare questo corso, e a chi lo consiglieresti?
Lo consiglierei perché è un corso fondato sulla pratica costante, sul confronto continuo in modalità laboratorio; e poi perché con i suoi incontri del mercoledì darà la possibilità di entrare in contatto diretto con maestri e professionisti affermati della nostra editoria. Gli allievi saranno guidati passo dopo passo verso l’elaborazione della loro proposta editoriale, che alla fine varcherà la soglia di una casa editrice. Consiglierei Alias non solo a chi ha il desiderio di diventare traduttore editoriale, ma a tutti quelli che sentono di poter arricchire la loro passione letteraria con un’immersione concreta nell’arte e nel mestiere di tradurre. In fin dei conti quando parliamo di traduzione non parliamo mai soltanto di traduzione ma anche di tutto il resto.


Quando hai scelto di diventare un traduttore? Qual è stato il tuo percorso professionale?
La scelta, a quell’epoca ancora clandestina e per così dire larvale, risale agli anni del liceo, con la curiosità per la lingua speciale della poesia e per le incarnazioni più periferiche e singolari dell’inglese. Le mie prime traduzioni fanno parte di un’officina privata che ha radici comuni con lo scrivere e ha fatto nascere i fermenti iniziali di quel che sarebbe venuto in seguito. Dopo il giornalismo e la laurea in Lettere ho intrecciato l’esperienza di lettore di manoscritti da lingue straniere in alcune case editrici – come Rizzoli e Fazi – con la frequenza di Tradurre la letteratura, il corso di perfezionamento in traduzione letteraria della Fondazione Universitaria San Pellegrino. Da lavori su romanzi scritti in un inglese “scorretto”, imbastardito e mescidato (come Lord of Misrule di Jaimy Gordon) e su grandi rievocazioni narrative basate sulla scoperta del rapporto con l’Altro (Arctic Summer di Damon Galgut, che parla di E. Morgan Forster in India) o su innovatori estremi della letteratura americana (il corposo Call Me Burroughs di Barry Miles) sono passato a occuparmi del primo progetto di traduzione integrale italiana di Finnegans Wake di James Joyce, che sto curando da cinque anni per Mondadori insieme a Enrico Terrinoni.

Qual è stato l’ultimo libro che hai tradotto? Come hai gestito i tempi, quali sono state le difficoltà?
Sto concludendo sempre per Mondadori la traduzione di In Parenthesis di David Jones, un poeta nascosto, forse l’ultimo dei grandi modernisti ancora da scoprire in Italia. Il libro è un prosimetro, un ibrido di prosa e poesia che riattraversa l’esperienza del soldato Jones (del corpo di spedizione britannico) sul fronte franco-tedesco nella Grande Guerra. Il problema posto da un lavoro simile non è tanto legato ai tempi quanto alla complessità di una lingua capace di saltare nello spazio di una riga da un massimo di brutalità descrittiva a un massimo di visività e accensione lirica. Bisogna accordare la propria lingua a quella mentale dell’autore, continuamente sotto pressione e in marcia forzata, e mantenere al contempo una ostinata precisione tecnica nei dettagli. E infine saper cantare con un timbro epico quando la voce dei personaggi di Jones si confonde con quella dei guerrieri dell’Alto Medioevo e resuscita i fantasmi dei minuscoli eroici uomini senza nome, oscura carne da macello della Storia grande.