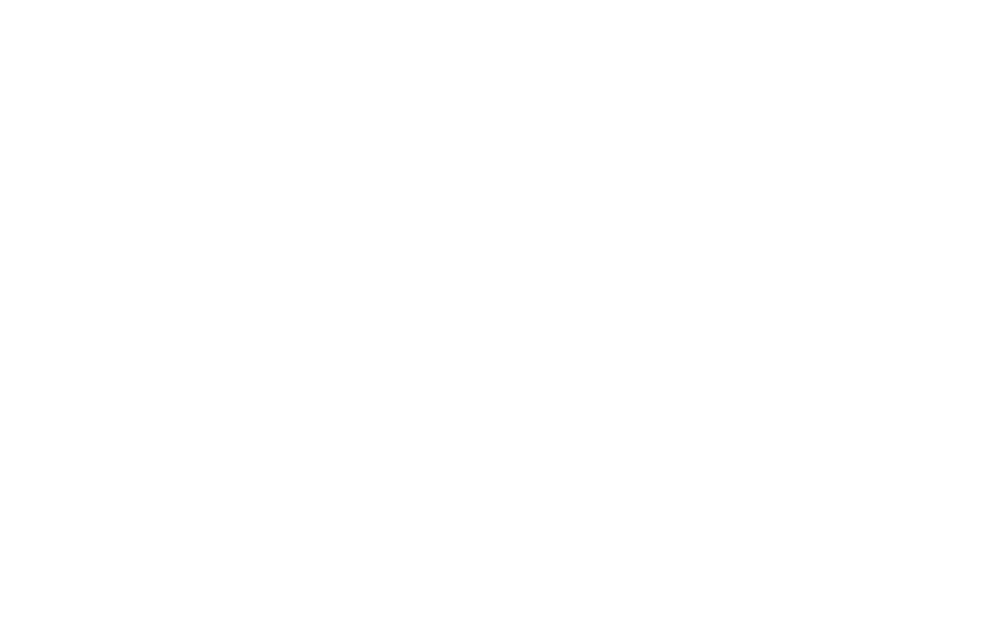Cinque scrittrici contemporanee per capire come la letteratura possa raccontare gli eventi capitali del nostro tempo
Di modi per raccontare la Storia ce ne sono a dozzine, ancor meglio a centinaia, soprattutto quando si tenta di farlo in forma di romanzo. C’è il narratore dei Miserabili, che costringe il lettore a quasi cento pagine di descrizione sulla battaglia di Waterloo osservando la disfatta di Napoleone dall’alto, come un dio che analizzi la scacchiera e le pedine terrestri; c’è chi ipotizza teorie universali, come il Tolstoj di Guerra e pace e i movimenti ondosi degli uomini da est a ovest e viceversa; e, per rimanere nella schiera dei classici, ci sono ancora la maniacalità descrittiva di Balzac, le denunce narrative di Dickens, gli affreschi manzoniani, il cinismo di Céline… eppure, in tutti questi casi, la resa migliore avviene quando, sbarazzandosi di strutture esplicative, la Storia penetra nel racconto affiorando dal quotidiano, ancor meglio se quest’ultimo è quello degli anonimi, dei comuni mortali, dei nomi assenti dai manuali ai quali viene data voce. In quest’arte, le scrittrici donne sembrano avere una marcia in più: c’è affresco più preciso dell’Italia di metà Novecento del binomio Ginzburg-Morante? c’è resa romanzesca migliore sul XVI secolo dell’Opera al nero di Marguerite Yourcenar, col suo bislacco personaggio Zenone che riassume in sé tutta la vivacità culturale del tempo? Qui terminano però gli elenchi; sono troppo porosi, permeabili, e a stenderli verrebbero fuori troppe anomalie, troppe eccezioni a una regola rigida che rigida, per l’appunto, non vuole essere. Eppure una sorta di verità sembra venire a galla.
La verità è che la Storia ha voce di donna. Questo non per un banale grido di denuncia contro il monopolio maschile del panorama letterario, né per sottolineare come la comprensione della guerra, una tematica fra le tante, passi insieme dal discorso di Pericle e da quello di Lisistrata. La contrapposizione fra i sessi di autori e personaggi non ha nulla a che vedere con questo assioma. Qui si intende ancora più esplicitamente che quando si sceglie di raccontare la Storia occorre concederle un ammaliante tono femminile, capace di tutta quella gamma di sfumature e timbri e variazioni insieme melodici e puntuali. Tante più peculiari colorazioni della voce si riesce a chiamare in causa, tanto più la natura degli eventi si farà sentire netta – qualsiasi sia il suo scopo, dall’ammonizione all’elogio di ciò che è stato. E anche la scelta di una singola modalità di canto può gettare nuova e fondamentale luce, soprattutto se inusuale e collosa sugli eventi raccontati.
Sintonizzate col loro diapason sensibile alle corde vocali di quest’entità niente affatto astratta, alcune scrittrici contemporanee hanno saputo cogliere e continuano a mostrarci il canto complesso e multiforme degli eventi storici. La lettura delle loro opere è fondamentale per almeno due motivi: la necessità della cosa narrata da una parte, la modalità in cui il racconto e l’indagine vengono svolti dall’altra. E ad accomunarle c’è inoltre un fondamentale elemento, la presa diretta. Osservatrici attente ma soprattutto coraggiose del loro orizzonte, i loro testi diventano focus sugli eventi storici fondamentali dei nostri tempi ben prima che questi diventino tali. Una rapidità che, quando accompagnata dalla traduzione, permette ai loro libri di circolare in tutto il mondo, col risultato di dotare il lettore di nuovi punti di vista, di zittire le visioni limitate e campanilistiche e di mostrarci le carsiche somiglianze a latitudini e longitudini diverse.
Gli esempi sarebbero numerosissimi, ma qui di seguito troverete un caldo invito alla lettura di Suad Amiry, Svetlana Alexejevic, Herta Müller, Annie Ernaux e Han Kang.

Suad Amiry o dell’ironia. In un incontro coi suoi lettori, l’architetta palestinese Suad Amiry ha detto: “Potrei perdonare a Sharon [primo ministro israeliano] molti dei crimini commessi contro il mio popolo, ma non gli perdonerò mai di avermi costretta a convivere con mia suocera!”. E in questa frase è tutto racchiuso il suo primo e più famoso romanzo, Sharon e mia suocera (Feltrinelli, 2013), dove l’autrice compone il resoconto della sua convivenza forzata con la madre del marito durante il coprifuoco imposto sotto l’occupazione della sua città, Ramallah, da parte delle truppe israeliane. Questo testo esplode sotto gli occhi del lettore proprio per la sua capacità strabiliante di insinuare la risata all’interno degli eventi tragici del conflitto mediorientale. Come quando si parla di Nura, il cagnolino dell’autrice che riesce ad ottenere, visitato da una veterinaria israeliana, un passaporto da usare per accedere alla parte ebrea di Gerusalemme, “documento per il quale milioni di palestinesi sarebbero pronti a tutto!”, e che si affaccia dal finestrino dell’auto, al controllo dei militari, pavoneggiandosi col muso e con una cert’aria di superiorità nei confronti della sua padrona per il ribaltamento dei ruoli. Risate dunque, ma anche copiose lacrime, dentro una delle macchie più scure della contemporaneità. Con questo libro, che non ha alcun vezzo letterario (creato com’è con un collage di mail scritte da Amiry agli amici) ma molto del cronachistico, la lezione diventa chiara: non una visione tragicomica della realtà, se per tragicomico si intende una categoria puramente letteraria, bensì un’osservazione olistica della Storia che, quando si manifesta anche nelle sue concretizzazioni più cruente e sanguinarie, non riesce a zittire le banalità e il quotidiano, spesso fortunatamente zuppi di risate.
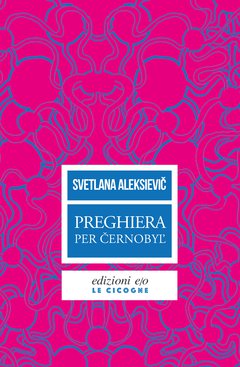
Svetlana Alexsievic o della polifonia. ‘Ascolta’, ‘Racconta questo’, ‘Ricorda quest’altro’, ‘Tu che puoi farti leggere, non dimenticare di riferire che’. Con questa gamma di inviti, calibrata da richieste di anonimato, omertà e brevissimi discorsi reticenti, la scrittrice bielorussa Alexsievic, premio Nobel nel 2015, costruisce Preghiera per Cernobyl’ (Edizioni E/O, 2018), la sua opera più famosa e apprezzata. Della mostruosità che ha segnato uno spartiacque immenso nel nostro rapporto con la tecnologia, non una pagina è spesa per il reattore, non una per la reazione chimica innescata, non un solo paragrafo né una frase sull’esplosione in sé; il libro è piuttosto una serie smisurata di opinioni umane, di racconti personali e ricordi raccolti e trascritti in anni e anni di incontri con gli abitanti delle zone più colpite dal disastro nucleare del 1986. E se serpeggia onnipresente l’orrore dei destini piegati e piagati dall’evento, la multiformità sociale, anagrafica e culturale degli individui intervistati rende il libro un costante slittamento della focalizzazione sull’incidente. Il risultato è una lezione preziosissima, che disegna la Storia nella sua natura di bollitore tremante di destini diversi dove, presa di coscienza fondamentale, il carnefice non è tale perché vittima di ideologie malate e incontrastabili. Marasma, babele, matassa o forse ancor meglio trama di infiniti fili, tutta l’opera della scrittrice bielorussa (incluso La guerra non ha volto di donna che ha regalato alla lontana il titolo a questo articolo) non insegue l’unità, ma concede in inchiostro alla Storia la sua struttura polifonica e costantemente multipla; trovarne all’interno una linearità sembra essere cosa non solo impossibile, ma fortemente errata.

Herta Müller o della secchezza. Se si giocasse a quella fantasia da lettore, che spesso può tramutarsi in forzatura inesatta, di immaginare in ogni minimo particolare i personaggi di un romanzo, coi libri di Herta Müller si potrebbe arrivare a disegnare mentalmente una serie infinita di individui simili alle sculture di Giacometti: oblunghi, solitari ma soprattutto essenziali, di un’essenzialità che è privazione, eliminazione delle caratteristiche psicofisiche, sottrazione di vitalità fino a raggiungere quell’ultimo stadio che separa l’umano da ciò che non lo è. Questo perché l’esperienza che la Nobel rumena di lingua tedesca racconta in tutti i suoi testi è sempre legata all’orrore delle dittature dell’Est Europa, tra le più temibili per il controllo totalizzante sulla vita dei cittadini. Come nel caso di uno dei suoi libri più riusciti, Oggi avrei preferito non incontrarmi (Feltrinelli, 2011), capolavoro dove viene narrata la paura costante di una donna sotto il regime di Ceausescu, convocata “giovedì alle dieci in punto” dai servizi segreti. Di fronte a esperienze che hanno sbucciato, strato su strato, la vita a milioni di uomini e donne, Herta Müller, vittima essa stessa di questo meccanismo orripilante, riporta questa pagina tragica del suo paese natale con una lingua che è la resa perfetta dell’atmosfera vissuta: lapidaria, ridotta all’osso, ripetitiva, ossessiva, con pochi sprazzi di altissima poesia. Anche l’onnipresenza dell’alcol, legato alla violenza maschile e al potere dittatoriale della Romania del tempo, non lascia mai spazio all’ebrezza stilistica; i paragrafi brevissimi sono costellati di punti fermi, come a voler tradurre sulla pagina l’incapacità di collegamenti umani o cerebrali e la paura che tutto mette a tacere sotto i peggiori sistemi di potere del Novecento. Lezione preziosa, dunque, quella di sfibrare il racconto della Storia quando quest’ultima ha sfibrato l’esistenza degli esseri umani.
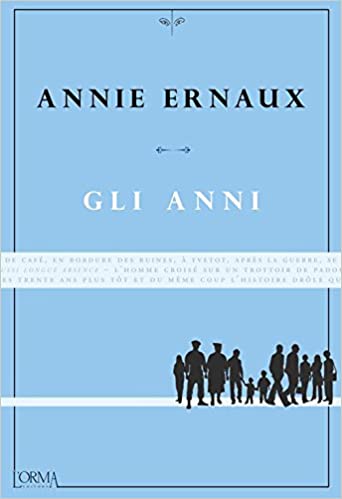
Annie Ernaux o del collettivo. Nelle sue opere, delicate ma potenti urla alla salvaguardia di ogni singolo tassello dell’esperienza umana, la scrittrice francese Annie Ernaux ha saputo coniugare in maniera magistrale l’autobiografia con una trattazione universale e sociale della cosa narrata. Forse è L’evento (L’orma, 2019), crudo resoconto di un aborto clandestino, che meglio testimonia questo duplice risultato, testo le cui pagine uniscono l’orrore vissuto sulla propria pelle alla regolamentazione disumana dell’interruzione della gravidanza nella Francia degli anni Sessanta. Ma con Gli anni (L’orma, 2015), pubblicato nella preziosa traduzione di Lorenzo Flabbi, l’autrice affina ancora di più il binomio sopra citato. Tutta la sua esistenza viene infatti tradotta sulla pagine con l’utilizzo di una prima persona plurale – un noi generazionale, collettivo, comunitario spesso reso con un si impersonale – plasmata per dar voce alle numerosissime esperienze vissute, dalla guerra in Vietnam a Mitterrand, dall’Algeria macchiata dal conflitto postcoloniale alla tragedia dell’11 settembre, incluse le pagine dense ed esemplari sul Sessantotto parigino. Ne risulta quel baule affastellato di ricordi condivisi, foto, jingle pubblicitari o ritornelli di tormentoni che tutti noi costruiremmo se solo ci impegnassimo nello stesso affannoso programma della Ernaux: ricostruire gli anni, i nostri anni. Anche in questo caso, infatti, il romanzo è anzitutto uno schema da far proprio e riutilizzare. Perché chi non si riconosce con la scrittrice né nel decennio di nascita né nella nazionalità potrebbe sentirsi spaesato fra i riferimenti storici e mondani non comprensibili, ma dovrebbe ugualmente percepire quell’appartenenza extra-individuale arroccata intorno a un lessico condiviso, a ritmi incancellabili, a foto storiche comuni e sentimenti collettivi e ricordi plurali che la Storia impone. Il capolavoro della Ernaux è un’ennesima conferma della sua indiscussa centralità nel panorama letterario contemporaneo.

Han Kang o del dislocamento. Gwangju, maggio 1980: coordinate spazio-temporali totalmente vuote di senso in Occidente che rappresentano una delle macchie più nere della storia coreana. Nella parte sud della penisola tagliata in due da un odio incomprensibile lungo il 38° parallelo, quella città e quella data contrassegnano la dura repressione che portò la dittatura militare a soffocare col sangue e altre violenze inaudite una sollevazione popolare capeggiata da operai e studenti. Han Kang, originaria di Gwangju, racconta questa carneficina in Atti umani (Adelphi, 2017), un romanzo schizofrenico caratterizzato da un costante dislocamento. Anzitutto temporale: le prime pagine sono ambientate nel 1980, le ultime nel 2013. Poi di focalizzazione: il racconto passa dalla seconda persona singolare alla prima, con l’immissione del narratore onnisciente in terza persona. Infine dei personaggi: il lettore infatti ricostruisce la trama principale seguendo le vicende di un giovanissimo alla vigilia del massacro, di un prigioniero sottoposto a torture, dell’anima di un cadavere abbandonato in una fossa comune, di una redattrice che subisce la violenza delle forze dell’ordine e il torchio della censura fino all’epilogo finale, dove la stessa autrice spiega le ragioni e le modalità della stesura delle pagine che si stanno leggendo. Il risultato è stupefacente: quella brutalità “impressa nel nostro codice genetico”, conosciuta purtroppo in ogni secolo e a ogni latitudine e longitudine, viene circumnavigata in maniera plurima, si impone come resoconto in presa diretta e incubo incancellabile, facendo riemergere l’incomprensione sia di chi si è ritrovato nelle strade sotto la carica dei soldati sia di chi ripercorre quell’orrore osservandone le foto d’archivio.
Lamberto Santuccio