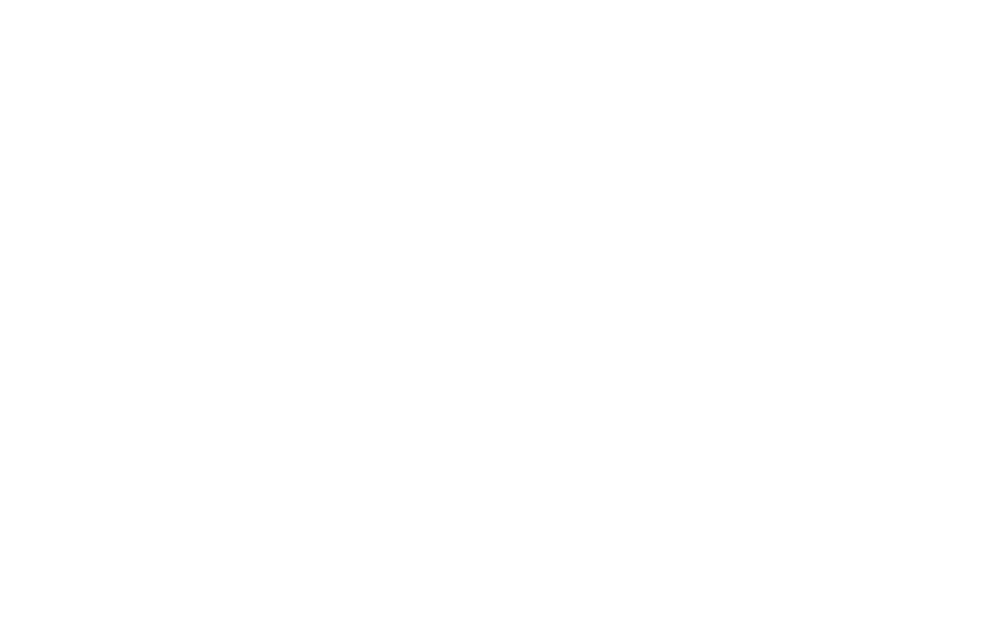A cura di Bianca Martino, Serena Savatonio e Maria Chiara Truttero (Scuola del libro), Aurora Fantone e Giulia Guidarelli (Liceo classico G. Leopardi di San Benedetto del Tronto), Dafne Valeri (Liceo scientifico B. Rossetti di San Benedetto del Tronto), Filippo Zacconi (Liceo classico G. Romagnosi di Parma).
Una tartaruga non deve traslocare, non deve mai cambiare casa: la casa se la costruisce addosso e addosso se la porta, piano piano, ovunque vada. Lo stesso non vale per Io, che deve portare il suo nudo corpo umano di casa in casa, dall’infanzia all’età adulta, condividendo affitti temporanei con i suoi simili – spesso così diversi da lui –, costruendo convivenze e teatri dove le scenografie sono fatte di mobili, ante ed elettrodomestici, e i copioni sono tutti improvvisati sempre sugli stessi logori canovacci. Grazie a una scrittura poetica e al contempo catastale, attraversiamo luoghi fisici come «la casa sopra i tetti» e metaforici come «la casa del persempre». Questi luoghi sono interconnessi tra loro in una prospettiva dentro/fuori continua, che dà una dimensione corale e insieme solitaria. Io cambia quartiere, cambia città, cambia strato sociale, ma il suo unico e vero rifugio restano le pareti di parole che instancabilmente erige sulle schermate bianche del suo portatile, giorno dopo giorno, a passo di tartaruga, costruendo una corazza paradossale fatta di spaziature e caratteri.
Il percorso di ricostruzione degli ambienti e del vissuto di Io è una ricerca catastale che ricorda un vero e proprio scavo archeologico. Ha spiegato in altre occasioni che l’idea è nata da una semplice lista delle case in cui ha vissuto, buttata giù di getto. Si è basato solo sulla sua memoria o ha utilizzato altri supporti? Come fotografie, appunti, video, oggetti conservati o anche ritrovati. Le case descritte sono quindi case reali, concrete, o immaginate dalla memoria e quindi frutto di frammenti e ricordi di una vita passata? Si direbbe case quasi invisibili ma costruite dalla memoria e per questo non concrete, reali in un solo tempo e in un solo spazio.
Mi piace molto il riferimento all’archeologia, perché credo che possa essere un buon punto di partenza per provare a rispondere alla domanda, ammesso che io sappia farlo, perché gli autori non sempre sanno tutto delle cose che hanno scritto. Il libro delle case è, in qualche modo, un testo archeologico. Il grande fascino dell’archeologia − considerata noiosa o una faccenda dell’antichità −, è la capacità di ricostruzione di vite intere a partire da un pezzo di muro o dal frammento di un’anfora. Quando però si prova in maniera concreta a pensare cosa significhi rimettere insieme i pezzi di una vita intera a partire da un pezzo di muro − e a ricostruire cosa succedeva a cena, dove si dormiva, come ci si svegliava la mattina, come si stava insieme − allora l’archeologia diventa subito la base, ossia quello che facciamo tutti i giorni, senza rendercene conto, quando entriamo a casa di qualcuno o quando andiamo in un posto, non necessariamente al chiuso ma anche all’aperto, e proviamo sempre a immaginare cosa c’è e cosa accade lì. Ad esempio, in questo momento sono a Houston e dalla finestra vedo una scuola e immagino. Non so cosa succeda dentro, ma sto facendo dell’archeologia del super-contemporaneo, di ciò che sta lì fuori: posso sentire le voci dei bambini, immaginare che siano quasi tutti senza mascherina perché sono ancora bambini, al contrario delle maestre che la indossano. Allora ci si rende conto che dentro questa prospettiva c’è qualcosa di molto intimo e al tempo stesso qualcosa di epocale. Quello che ho fatto io con il mio libro, in realtà, è stato uno “scavetto”.
Le case sono reali o no? Questa è una bella domanda a cui faccio fatica a rispondere, e di certo non per reticenza. Naturalmente tutto è partito dalle case reali, quelle dove ho vissuto, e dal tentativo di rivedere la casa in cui ho passato i miei primi anni di vita. Un tentativo riuscito e al tempo stesso fallito perché le persone che ci vivevano erano in forte imbarazzo di fronte al mio attaccamento quasi patetico. È stato un vero disastro emotivo. In quella occasione ho cominciato a prendere i primi appunti, e ho continuato annotando tutte le case in cui avevo effettivamente vissuto. Quindi sì, le case sono reali, o almeno molte di loro lo sono, ma la cosa si complica. Nel momento in cui denomino «casa del sottosuolo» una casa in cui ho abitato, emotiva e biografica, questa diventa immediatamente un personaggio, si trasforma in altro. Era la mia casa e quello era il tentativo di raccoglierne alcuni frammenti. È nato tutto così: raccogliere frammenti delle case in cui avevo vissuto e provare a ricostruirli in un puzzle. I nomi sono arrivati dopo, e così «la casa del sottosuolo» o «la casa sopra i tetti» già stavano diventando una sorta di favola. Poi subentra quella specie di miracolo che è la scrittura, che ti porta in territori inesplorati. Scrivendo cominci a indagare, ma non solo la memoria, che è puramente conservativa ed è solo il punto di partenza che mi ha permesso di ricordare collocazioni e forme, a volte anche di tracciare una maldestra piantina. Quando subentra la scrittura, poi, si va oltre il proprio vissuto. A partire da elementi reali della mia vita, sia immobiliare sia biografica, costruisco qualcosa che spiega come le case del romanzo sono vere ma non necessariamente reali. C’è una grande differenza tra ciò che è reale e ciò che è vero: reale è qualcosa che appartiene al vissuto in maniera concreta, che può essere raccontato, ma senza avere la certezza di riuscire a estrarre l’elemento veritiero necessario ad arrivare al cuore del lettore. Quindi, paradossalmente, una casa reale può essere anche non vera, nel senso che lo scrittore è in grado di leggerla solo perché l’ha vissuta, ma gli altri non possono entrarvi. Poi ci sono le case vere, e queste lo sono tutte.
Nel romanzo è evidente che i luoghi e gli oggetti hanno un ruolo da protagonisti, più dei personaggi. Sembra quasi che dare meno importanza alle persone sia funzionale al dare risalto ai luoghi, ma anche una conseguenza della spersonalizzazione che caratterizza l’intera narrazione. In effetti alcuni lettori potrebbero avvertire un forte senso di alienazione. Secondo lei questa sensazione deriva dall’uso diffuso dei pronomi e dei nomi comuni?
Parliamo quindi di distanza. In realtà non so dire se il mio interesse fosse per gli oggetti. Quello che mi attira sono le relazioni, e quindi quanto di una persona c’è in uno spazio o in un oggetto. Quindi questa – la storia tra tante storie di un matrimonio che nasce e finisce –, è la storia di una famiglia disfunzionale, di un abuso domestico, di una specie di regime di paura e allo stesso tempo è il tentativo di chi racconta, di Io, di riuscire a “sopravviversi” e avere una nuova vita, ogni volta. Tutto questo succede in una casa, ed è questo ciò che mi interessa: raccontare cosa succede quando in una casa si soffre, si ride, o si piange. I muri contengono tutto questo, però c’è una distanza reale grazie alla quale i muri da un lato raccolgono quello che gli raccontiamo, dall’altro un po’ se la ridono. Questa distanza per me significava sia allontanarsi da qualcosa di incandescente e doloroso, sia guardarsi da fuori. Non l’ho raccontato in prima persona, ma ho sfruttato Io, perché solo guardandoti dall’esterno è possibile vedersi; ma nel momento stesso in cui ci si osserva, cessiamo di essere noi stessi perché ciò che si vede nello specchio è solo un mero riflesso. A mio avviso è la stessa distanza che c’è tra i muri e le persone: i muri sono osservatori discreti e raccontano con minore partecipazione e maggiore ironia quello che viviamo. Il personaggio che misura la distanza in assoluto è la tartaruga, sia da un punto di vista temporale che spaziale: è una sorta di preistoria che si aggira per casa. Pertanto credo che questa distanza sia connaturata al racconto e che, al di là di quello che desideravo, è venuta fuori scrivendo. Non volevo che fosse lacrimevole, far compatire o compatire nessuno. Volevo che tutti fossero in grado di leggerla come fosse la storia di un altro, e non necessariamente attraverso un processo d’immedesimazione totale. Mi interessava questo sguardo esterno su qualcosa di molto intimo. Fatta eccezione per le due case “politiche”, che sono quelle di Poeta e Prigioniero, ossia di Pasolini e Moro, è un libro che è il rovescio dell’intimità. Affinché si verificasse questo, dovevo regolare la distanza e l’ho fatto semplicemente dando questi nomi impersonali.
Per quanto riguarda il senso di alienazione, posso dire che ogni lettura è legittima, ed è giusto anche abbandonare i libri, sentirsi accolti o meno in una storia. Di certo ci sono delle esperienze che richiedono uno sforzo maggiore che poi, nella maggior parte dei casi, ripaga. Questo non lo dico per attirare il lettore, ma credo che leggere sia qualcosa di molto simile allo scalare una montagna: all’inizio il fiato si rompe e la cima sembra irraggiungibile; lungo il tragitto si incontrano persone diverse da noi, e si è tentati di andare lontano, chiedersi che lingua parlano, che esperienze hanno fatto e se sono totalmente diverse dalle nostre. In qualche caso la prima impressione corrisponde alla verità, ma in tanti altri no. La maggior parte delle mie esperienze importanti sono passate attraverso questo sforzo iniziale. La lettura è una relazione e pertanto comporta una conoscenza iniziale, e inseguito l’impegno necessario a capire se si andrà da qualche parte insieme oppure no. Anche io abbandono tantissimi libri, ma il tentativo di entrare in relazione credo che ripaghi sempre.
Come genere letterario ha scelto di cimentarsi nell’auto-fiction. Cosa l’ha spinta verso questa direzione? Se la sente di spezzare una lancia a favore di questo genere che la critica odierna tende a non apprezzare particolarmente?
I nomi dati ai generi lasciano il tempo che trovano. La storia del romanzo e della sua forma è quella di un genere totalmente inquieto: non esiste una narrazione uguale all’altra, e la bellezza, e al tempo stesso la difficoltà, sta proprio nella continua ricerca da parte del romanziere della sua forma prediletta. Si pensi a opere come Gita al faro, Il gattopardo, o L’ermellino, ognuno è assai diverso dall’altro, ma tutti rientrano nella macrocategoria del romanzo. Gli scrittori che apprezzo di più sono coloro che trovano una propria strada che va al di là del genere. La scrittura è un attraversamento, e come accade in montagna si può proseguire a piedi − magari senza mappe e coscienti del rischio di perdersi −, oppure prendere la galleria che la attraversa. Ci sono autori che preferiscono la galleria e usano generi ed espedienti che già esistono, e poi ci sono altri che scelgono la propria strada, rischiano di fallire scrivendo un romanzo imperfetto, noioso o irrisolto. Io sono tra quelli che cercano di non prendere gallerie.
Andando più nello specifico, a me non interessa la “pura” auto-fiction ma la fiction dell’io. Ho voluto mettere l’io davanti a uno specchio straniante e studiare lo scarto che si creava. Ho dato una possibilità alla scrittura: le mie parole non dovevano solo portare una storia dall’altra parte, come dei gregari, ma ho chiesto loro d’inventare, di farmi vedere e sentire. L’io si può vedere da fuori o lateralmente. Durante i miei corsi di scrittura noto che quando le persone spostano la narrazione alla terza o alla seconda persona si liberano delle loro reticenze e delle loro paure, e riescono a toccare il cuore di ciò che è vero (e non solo reale). Il libro delle case è nato proprio dal tentativo di mettere insieme ciò che era reale e personale e l’invenzione delle parole, sotto la guida delle parole stesse.
Tabucchi diceva che la vita non basta e che se cominci a scrivere è perché vuoi di più, quel surplus di visione e immaginazione. Scrivere significa vivere due volte, anche quella vita che pensavi di aver già vissuto.
La sua opera potrebbe essere inserita nella cosiddetta letteratura della trascrizione, filone sviluppatosi in particolare nella letteratura francese, che si nutre di esperienza diretta e indiretta e la rende a sua volta personale e collettiva. Man mano che si procede nella lettura si ha l’impressione che lei voglia dare testimonianza di un’assenza, di un vuoto, come alcuni scrittori francesi fanno e hanno fatto (Ernaux, Perec, Modiano). Anche lei ha sentito la necessità di collezionare delle tracce per costruire una memoria presente del passato?
Ho tenuto delle lezioni proprio su Annie Ernaux, concentrandomi in particolare su Gli anni, in cui l’autrice, oltre a stilare un catalogo per frammenti, usa la massima distanza dalla narrazione: nonostante si tratti di un memoir, l’autrice usa i pronomi “noi” e “lei”. È un racconto di sé, di un io. A me interessa molto il rapporto tra ciò che è reale e quello che diventa storia. Il punto è l’inventario. Un tempo mi ero fissato a voler scrivere un romanzo sulle fabbriche fallite, anche se non aspiravo a un romanzo sociale. In quel periodo lavoravo insieme a dei curatori fallimentari, e mi resi conto dello stato di cristallizzazione in cui verte un’azienda che fallisce: le persone devono lasciare la propria scrivania esattamente com’era, con la foto dei bambini, la penna, il quaderno sul tavolo e il computer, perché il curatore fallimentare deve dare un prezzo a tutto. Quello che viene fatto è un inventario vero e proprio, che è, però, al tempo stesso un’archeologia di senso di una civiltà finita, e per questo commovente. Le foto dei bambini con le pinne al mare in un edificio sigillato ti toccano il cuore perché è una visione sia triste sia allegra: le due cose stanno sempre insieme. Nella parola inventario c’è la radice latina comune al verbo inventare: quello che ho fatto io è stato esattamente questo, raccogliere e poi inventare. Dall’inventario all’invenzione. Anche Ernaux parte dalle “cose morte” e le trasforma in qualcosa di vivo. Perec ha fatto una cosa simile, peraltro con grande umorismo, in Tentativo di esaurimento di un luogo parigino.
Il libro delle case è un susseguirsi di brevi capitoli che racchiudono i correlativi oggettivi che compongono la storia di una vita: ogni capitolo ci dà un’immagine a sé stante, che poi assumerà ancor più significato insieme a tutte le altre. L’opera avrebbe potuto essere una raccolta di poesie? E se questo è il caso, cosa invece l’ha portata a scegliere la prosa? Lei ha dichiarato in qualche occasione che prima di pubblicare le sue poesie le hanno chiesto di scrivere un romanzo: ha mai pensato a questo libro come a una “vendetta finale” della poesia sulla prosa?
Mi piace molto la definizione di «vendetta finale» della poesia. La poesia sopravvive, la prosa no. La partita dalla prosa è sempre solo vinta nelle classifiche della domenica, nella vendita del momento, ma non ce n’è: vince la poesia, l’ultimo eco che rimane, finirà il mondo è resterà l’eco di un verso non di certo una frase di un romanzo, di quello resterà un titolo ma solo se bello e somiglia a un verso. Per me la poesia è ciò che di più importante c’è al mondo: è musica, fa sentire la lingua organizzandola in una maniera diversa, è un continuo attentato al linguaggio ma con la capacità di toccare e raggiungere il cuore del lettore e del senso. Ho iniziato questo libro senza sapere cosa sarebbe diventato − e per questo non ho voluto contratti editoriali in anticipo, non volevo finirlo mai e prendeva così la forma che preferiva, anche mostruosa. Non volevo che gravasse su di lui l’istinto seduttivo della pubblicazione. Volevo concentrarmi sulla ricerca più che sul punto di arrivo e, soprattutto, che la scrittura si prendesse tutto il tempo necessario. Volevo tornare a una fase di necessità che per me precede l’esordio − quel momento in cui si arriva dal silenzio più lungo verificatosi tra un libro e l’altro. Ho pensato che un libro senza la capacità perentoria di chiamarmi a sé della poesia non mi sarebbe interessato. Questo romanzo non sarebbe potuto nascere senza prima aver scritto le mie raccolte di poesie, Dimora naturale e Promemoria.
Il libro delle case ha della poesia la perentorietà e la musica: un libro in versi camuffato. Non potevo scriverlo in versi perché la sua struttura era un continuo costruirsi, anche nella mole complessiva; ma la frase resta ritmica e ci sono molti endecasillabi mascherati. Non che scriva contando, ma sicuramente sono debitore alla poesia. Mi piace molto l’idea di una «vendetta della poesia», ma come dicevo prima è il romanzo a essere un genere inquieto, che accoglie ora la poesia, ora, se vuole, la fisica quantistica: tutto servirà a tentare di raccontare una storia cercando una forma nuova.
La poesia è il migliore soccorso che possa capitare, non fosse altro perché ti fa stare bene.
Revisione a cura di Manuela Altruda