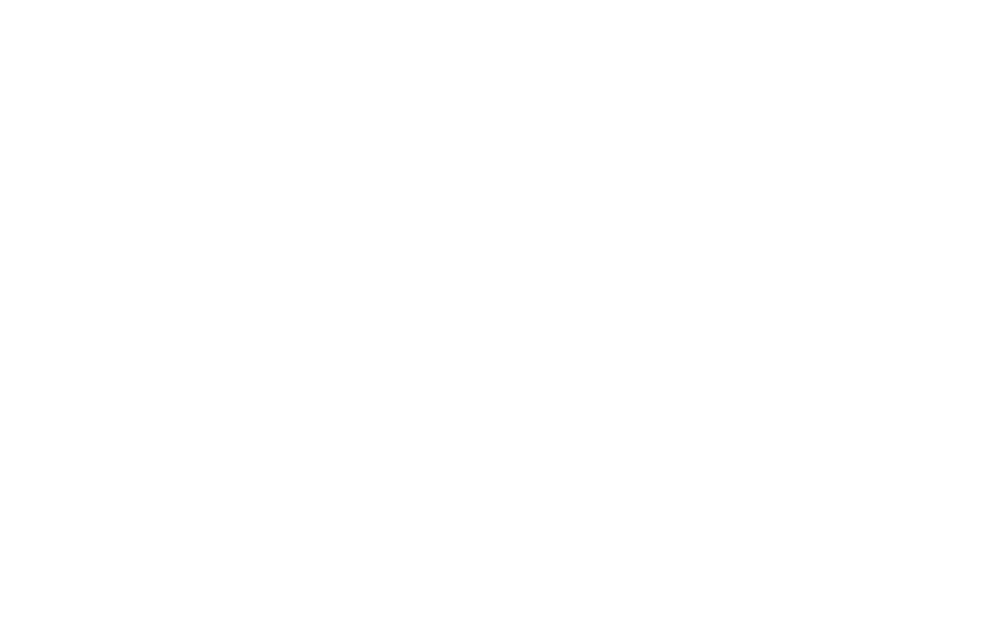di Mariangela Compasso
«- Guarda quel torrente, lo vedi? – disse. – Facciamo finta che l’acqua sia il tempo che scorre. Se qui dove siamo noi è il presente, da quale parte pensi che sia il futuro?»
Quando fu pubblicato Le otto montagne (Einaudi, 2016, pp. 208) decisi di leggerlo subito, attratta dal titolo, un po’ perché in quel periodo mi ero messa in testa di provare impavidamente tutte le piste da sci d’Italia – che bella la megalomania! -, un po’ perché di Cognetti avevo letto solo Una cosa piccola che sta per esplodere (minimum fax, 2007, pp. 156) e mi incuriosiva la sua scrittura romanzesca. Il libro finì, invece, dritto sul comodino. A tenergli compagnia dei rossetti, un paio di monili e molti pensieri.

La candidatura al Premio Strega nel 2017 poteva essere un buon motivo per aprirlo, ma nulla. Nemmeno la vittoria riuscì a farmi varcare la soglia dell’incipit. Nonostante la curiosità, non mi decidevo a leggerlo.
Quando nel 2022 è uscito il film, scritto e diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, tutti ne hanno parlato. Il film, apprezzato da pubblico e critica, con Luca Marinelli e Alessandro Borghi a dare voce ai due personaggi principali, ha vinto il Premio della giuria al 75º Festival di Cannes. Ho desistito dalla visione, rimandando ancora una volta la lettura del libro. Intanto sul mio comodino si impilavano sfacciatamente altri titoli, altre storie, altre copertine.
I quattro David di Donatello vinti nel 2023 (Miglior film, Migliore sceneggiatura non originale, Migliore autore della fotografia, Miglior suono) sono stati l’occasione definitiva. Nel giro di qualche giorno sarei partita per Torino e avrei portato con me un paio di libri, come faccio ogni volta che parto. Perché non Le otto montagne? mi sono detta. In quel momento un’immagine è candidamente apparsa nella mia testa: io che compro questo romanzo proprio a Torino anni prima. L’ho preso come un segno, e allora non ho potuto più rimandare. Era arrivato il suo momento.
Poi è successa quella cosa che succede quando un libro sa il fatto suo: alla prima pagina già ti piace. Sarà per il periodo da cui venivo fuori, o quello in cui stavo per entrare, ma per me questo libro è stato il libro della rinascita e gli voglio bene. Ha atteso paziente sul comodino perché sapeva. Il potere veggente della letteratura.
Dunque, Le otto montagne è un romanzo che si sviluppa su più piani.
Racconta l’amicizia tra Pietro e Bruno, un’amicizia benedetta e custodita dalla montagna. Indaga i turbamenti emotivi della fanciullezza. Esplora il legame unico e segreto tra l’uomo e la natura. E che bravo Cognetti a incanalare nella giusta corsia le sfumature e i dettagli.
Pietro è un ragazzino introverso e solitario, figlio di due veneti. I genitori – infermiera, poi assistente sociale la madre, chimico il padre -, si trasferiscono a Milano per motivi di lavoro, ma senza dimenticare «il Catinaccio, il Sassolungo, le Tofane, la Marmolada». I luoghi della giovinezza, dell’amore, del dolore. Un sabato di ottobre del 1972 si erano sposati ai piedi delle Tre cime di Lavaredo, «con giacche a vento come abiti nuziali e un letto al rifugio Auronzo per la prima notte da marito e moglie».
Il padre «poco incline alla meditazione, tutto caparbietà e spavalderia» ama percorrere i sentieri e raggiungere le vette più alte. La madre preferisce sedersi sui prati, immergere i piedi in un torrente, riconoscere i nomi di erbe e fiori. Entrambi uniti alla montagna da una tenace passione. Decidono, quindi, di andarla a cercare lontano dai palazzi di Milano, prendendo una casa a Grana, un piccolo villaggio ai piedi del Monte Rosa (Graines, nel comune di Brusson, in Val d’Aosta). Qui vive Bruno, un ragazzino selvaggio e spigoloso, montanaro da sempre.
Il lettore pigro definirebbe questo romanzo un “romanzo di formazione”, ma sappiamo che le definizioni alloggiano per poco nella letteratura. Certo, Pietro e Bruno diventano grandi pagina dopo pagina, ma la loro crescita è solo il cappotto che copre il vestito. È il “pretesto” per raccontare altro, direbbe il lettore puntiglioso. Cognetti sviscera l’animo umano senza risparmiare nessuno. E lo fa con una scrittura “pulita”, senza orpelli o smanie da scrittore fighetto. I due protagonisti ci vengono presentati con nome e cognome: Pietro Guasti e Bruno Guglielmina – o meglio, la voce narrante è quella di Pietro ed è lui che presenta tutti. L’autore sceglie di delineare le loro personalità partendo da ciò che appare, fino a immergersi nel loro inconscio. Inizialmente definiti (le definizioni, dicevamo), subiranno una meticolosa indagine psicologica.
Pietro e Bruno sono diversi – banalmente potremmo dire borghese l’uno e provinciale l’altro -, e diverso è il loro rapporto con la montagna. Vivono avventure divertenti e pericolose durante le quali scoprono di somigliarsi, ma restano fedeli a loro stessi, ognuno nella propria solitudine. Il romanzo non cede alle lusinghe della retorica sdolcinata che li vorrebbe romanticamente uguali nonostante i loro differenti background.
Bruno, capelli biondi, collo bruciato dal sole, «quasi sempre sporco di stalla», lavora con lo zio. Alpeggio è la parola che gli sentiamo ripetere più spesso. La montagna è la sua casa. Il mondo là fuori non gli interessa; sa che esiste, ha visto Milano, il mare di Genova, ma la sua vita è tra i pascoli. È tutt’uno con la montagna, ha un rapporto totalizzante con lei, così intenso da parlare la lingua concreta delle cose: «siete voi di città che la chiamate natura. È così astratta nella vostra testa che è astratto pure il nome. Noi qui diciamo bosco, pascolo, torrente, roccia, cose che uno può indicare con il dito. Cose che si possono usare. Se non si possono usare un nome non glielo diamo perché non serve a niente». In questa lingua il larice diventa la brenga, l’abete rosso la pezza, il pino cembro l’arula. Un simpatico nomignolo fa diventare Pietro Berio (sasso). Bruno spoglia la montagna di quel manto mitologico che la veste nell’immaginario comune e la riporta alla dimensione vera, in cui non ci si perde nel superfluo, perché la cifra della montagna è l’essenziale, come fa capire in un simpatico botta e risposta con Pietro: «Come si chiama questo lago? – chiesi. – Ma che ne so, – disse Bruno. – Grenon. Qua si chiama tutto così». L’appartenenza al luogo è tale da impedirgli qualsiasi ambizione o desiderio di andare via. Quando si prospetta l’occasione di trasferirsi in città in seguito ad accordi presi dallo zio, dopo una contenuta gioia iniziale, si arrende al suo destino, e resta lì, quasi con il senso di colpa per aver pensato di lasciare Grana. La montagna per lui è libertà e prigione, ma è soprattutto vocazione. «Non ti devi preoccupare per me. Questa montagna non mi ha mai fatto male» sono le ultime parole dette a Pietro.
Pietro è la voce narrante. È un ragazzino timido, che impara a conoscersi grazie alla montagna. È lui che ci regala uno dei passi più belli del romanzo: «Forse è vero, come sosteneva mia madre, che ognuno di noi ha una quota prediletta in montagna, un paesaggio che gli somiglia e dove si sente bene. La sua era senz’altro il bosco dei 1500 metri, quello di abeti e larici, alla cui ombra crescono i mirtilli, il ginepro e il rododendro, e si nascondono i caprioli. Io ero attratto dalla montagna che viene dopo: prateria alpina, torrenti, torbiere, erba d’altra quota, bestie al pascolo. Ancora più in alto la vegetazione scompare. Lì cominciava il mondo di mio padre. La montagna si trasformava in un luogo più aspro, inospitale e puro: lassù lui diventava felice».
Leggendo queste parole, mi è venuto in mente il post che Antonio Pennacchi scrisse su Facebook dopo la tragedia del Nanga Parbat, in cui persero la vita i due alpinisti Daniele Nardi e Tom Ballard. La sua fu la risposta a chi criticava la scelta di Nardi e Ballard, considerata azzardata e irresponsabile, di scalare quella montagna: «Non c’è essere umano che – da bambino o adolescente – non abbia sognato di fare, da grande, ciò che nessun altro aveva mai fatto: nel lavoro, nello sport, nell’arte, nella scienza o nell’avventura. Poi man mano, crescendo, la maggior parte si adegua agli standard del reale e cerca una vita pressappoco uguale a quella degli altri. Ci sono invece quelli – una minoranza – a cui il fuoco non si spegne con la crescita, a cui il fuoco rimane. A loro non basta una vita normale. Debbono sempre osare e stirarla al massimo: sempre in cerca di guai, sempre in bilico sull’orlo per superare il limite. […] Pensa solo a quanta gente è morta, prima che imparassimo a volare. Quelli che vanno in cerca di guai ci servono come il pane».
Il padre di Pietro, Giovanni Guasti, fa parte della minoranza di cui parla Pennacchi.
È un uomo sfuggente. Sempre con una mappa a portata di mano. Un altro sentiero, un’altra vetta. Per lui salire in cima vuol dire fuggire dalle cose che lo tormentano in basso. Lassù trova la quiete. C’è un dolore che porta con sé, ignorato da Pietro, che ne verrà a conoscenza molti anni dopo. È il personaggio chiave del romanzo. Pietro imparerà a conoscerlo durante i sentieri percorsi insieme. Quell’uomo misterioso si rivelerà nel silenzio, come nel silenzio si rivela la montagna, e nell’assenza riuscirà a raccontare sé stesso. Sarà grazie a un rudere lasciato in regalo dal padre che Pietro e Bruno si riavvicineranno dopo un inevitabile allontanamento. La ricerca della vetta più alta, di “quel dirupo aguzzo che raggiungeranno coloro che nella forza d’andare ripongono tutto” diceva Pessoa, porterà Pietro in Nepal e gli farà scoprire la leggenda delle otto montagne.
C’è un personaggio in questa storia quasi abbozzato, apparentemente secondario, ma determinante per lo sviluppo degli eventi: la madre di Pietro. È lei che agevola l’amicizia tra Pietro e Bruno. Intenerita da quel ragazzino diffidente con il quale il figlio fatica a dialogare, prende a cuore la sua precarietà e decide di aiutarlo con gli studi. Sarà lei ad avere l’idea di portare Bruno con loro a Milano. E sarà lei a tirare fuori i sentimenti egoistici di Pietro, con i quali lui farà amaramente i conti. Anche lei sopporta un dolore, nato dove la montagna si fa ingovernabile e la natura ostile.
È una donna sentimentale, in grado di comprendere e placare l’insofferenza del marito.
Questo romanzo racconta di chi non si conforma, di chi la normalità non se la fa bastare, di chi aspirando al grandioso cambia le sorti di tutti. Cosa sarebbe il mondo senza individui pronti a sfidare il pericolo pur di compiere azioni titaniche?
Le otto montagne è un elogio allo slancio travolgente che fa scalare montagne o attraversare oceani: la passione. Che è coraggio e libertà, ma anche conoscenza e disciplina. Fatica, metodo, tecnica.
Quella stessa passione che porterà Pietro sull’Himalaya. La storia di Pietro, di Bruno, di Giovanni è un regalo, una riconoscenza nei confronti di chi non «si adegua agli standard del reale», perché, riprendendo ancora le parole di Pennacchi, «ogni singolo progresso dell’umanità è dovuto a quei pochi nati e cresciuti con il fuoco dentro e privi del normale senso del limite. Li dovremmo solo ringraziare».