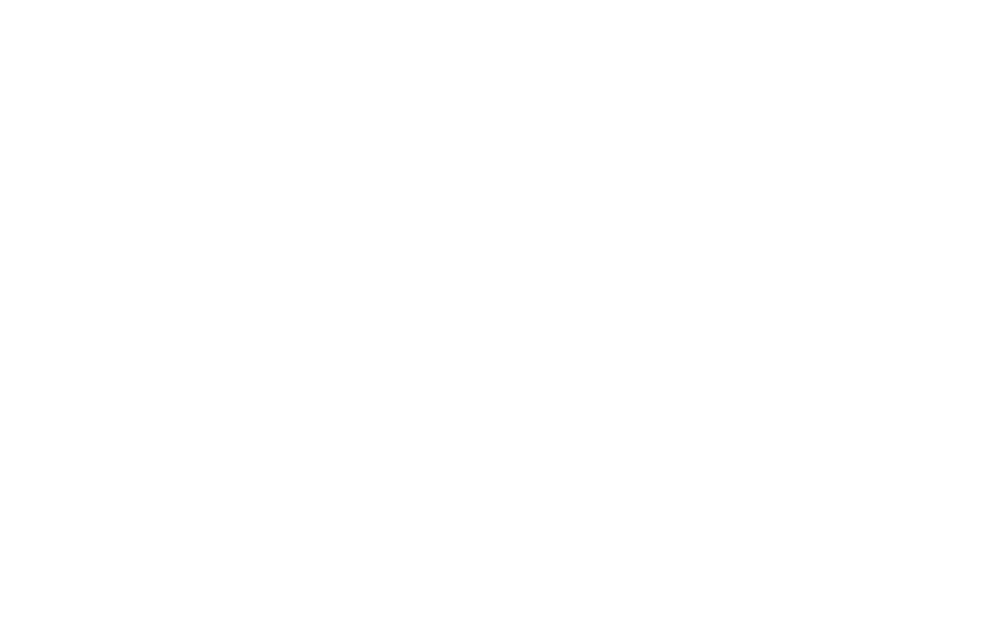A cura di Manuela Altruda e Eleonora Capparella (allieve del master Il lavoro editoriale), Vittoria Gueli (Liceo classico R. Settimo di Caltanissetta) e Giada Ciccone (Liceo statale G. Milli di Teramo).
Anni Duemila. Roma. Anguillara Sabazia. Lago di Bracciano.
Questo il momento storico-culturale in cui cresce la protagonista e voce narrante del romanzo, in un contesto di disagio economico e familiare che le rende difficile trovare il suo posto nel mondo. La ricerca della sua identità avviene tra città e periferia, attraverso un susseguirsi di case popolari, e di quei desideri adolescenziali destinati a rimanere tali: i sogni di una ragazzina passano in secondo piano quando si è nati in una famiglia senza sussidi, senza lavoro, portata avanti dalle sole braccia della madre. Gaia è un nome che suona come una presa in giro per l’unica figlia femmina di Antonia «la rossa», quella donna fiera che non ha mai ceduto ai compromessi cui la società cerca di costringerla, e che la obbliga allo studio sin da bambina, abituandola a quel sacrificio che dovrà di certo ripagarla.
Mentre Gaia arranca la sua rabbia cresce, fino a sfociare in scatti d’ira che mai ci si aspetterebbe da questa ragazzina dai capelli rossi, il viso pieno di lentiggini, ma gli occhi neri come le acque del lago di Bracciano.
Questo romanzo dà voce a una generazione arrabbiata e scoraggiata, che pur non riuscendo a vedere il fondale di quel lago oscuro e impenetrabile, continua comunque a scrutare, così come Gaia continua a cercare le lucine del presepe subacqueo, che, secondo la leggenda, rischiarano il lago di Bracciano nelle sere d’inverno.
Entriamo subito nel vivo del romanzo parlando della protagonista: Gaia è una ragazzina dall’apparente quiete e fittizia serenità, e può essere descritta come, citando Paolo Cognetti, Una cosa piccola che sta per esplodere. Perché in effetti Gaia esplode, e lo fa con sempre maggiore violenza, davanti alla cattiveria e ai soprusi subiti. A questo proposito sembra significativo il titolo che lei ha scelto per il terzo capitolo del romanzo, «È cattiva la gente che non ha provato il dolore». Si tratta di una citazione di Carlo Cassola, in particolare di Mara, la ragazza di Bube. Sembra che Gaia e Mara abbiano molto in comune, perché entrambe costrette a diventare donne e a crescere in fretta. Quanto di Mara e delle personagge del Novecento letterario italiano c’è in questa ragazzina dai capelli rossi?
La rabbia di Gaia scaturisce dalla frustrazione e dalla crescita obbligata: il momento in cui la bambina deve cambiare sguardo sul mondo è quello della scoperta della paralisi di suo padre, conseguenza di un grave incidente sul lavoro. Quando una volta arrivati in ospedale sua madre le affida uno dei gemelli, uno dei fratelli più piccoli, la osserva reagire in maniera lucida anche in una situazione di estrema tragicità.
Oltre alla Mara di Cassola, ci sono altri riferimenti del nostro Novecento letterario, e con esso altre personagge. Le autrici italiane del secolo scorso hanno raccontato molto bene la frustrazione, certo diversa da quella di Gaia perché legata alle convenzioni sociali del tempo. Si pensi a Una donna di Sibilla Aleramo e il terrore per quel matrimonio da cui non riesce a trovare via di uscita, o quella stessa insoddisfazione casalinga raccontata da Natalia Ginzburg in È stato così. Ed è proprio in quest’ultimo romanzo che c’è l’esplosione di cui si parlava. La protagonista inizia affermando: «Ho sparato a mio marito prendendo la rivoltella dallo scrittoio». Ma in Gaia c’è molto anche di Canituccia di Matilde Serao, la ragazzina dai capelli rossi che sembra dover sempre subire.
Eppure per un attimo Gaia si illude di poter avere un destino diverso da quello di Canituccia. In molti, infatti, hanno parlato di questo come un romanzo di formazione, ma a ben vedere siamo di fronte a una storia di deformazione, basata sul racconto non edulcorato della povertà e dell’ingiustizia sociale. L’involuzione della protagonista raggiunge un punto di approdo ben preciso: dopo la laurea in Filosofia, che avrebbe dovuto riscattarla, riceve dalla madre secchio e straccio per andare a pulire le case altrui, quelle dei ricchi. A questo proposito, quando intitola il romanzo L’acqua del lago non è mai dolce, crede che questa constatazione sia veramente l’unica possibilità per descrivere la tragicità dell’esistenza umana? E quanto, in questo senso, quello di Gaia può essere letto come il viaggio di un’antieroina?
Il mio, come tutti i libri, propone una parabola possibile, in questo caso abbastanza estrema. Nei miei romanzi cerco sempre di intraprendere un percorso tematico di evoluzione e di presa di coscienza da parte dei personaggi. È evidente che qui siamo dinanzi a una parabola senza futuro, che inizia dalla difficoltà e nella difficoltà ritorna. Non credo che questa sia l’unica reazione possibile ai vicoli ciechi cui, secondo me, la nostra generazione sta andando incontro sempre più spesso. In particolare penso a chi, anche con una formazione molto qualificata, non riesce a realizzarsi, soprattutto nei settori umanistici. La sensazione è quella di non varcare mai la soglia dell’indipendenza, dell’emancipazione, ma anche della realizzazione dei desideri, che ci porta a partecipare e a restituire alla società un carico di esperienze, di volontà e di sguardo. Il libro è costruito come una storia di deformazione perché Gaia reagisce ma senza mai imparare dagli ostacoli che incontra. È sicuramente il viaggio di un’antieroina, o almeno di una a-eroina: lei non è il cattivo della situazione, ma è depauperata delle forze tipiche dell’eroe, che sono le gesta, le armi, l’elmo, lo scintillio, la conquista, il riconoscimento. Nel suo caso parliamo di tentativi spesso fallimentari, di involuzioni e di capitomboli.
C’è da dire, però, che nonostante Gaia non provenga da un contesto di agiatezza, lei e la sua famiglia non appaiono mai rassegnati o passivi. In tal senso è emblematico l’arco narrativo di Mariano, fratello di Gaia. Prima ha accennato alle sue opere precedenti, e in effetti Mariano ci ha riportato a Lupo, uno dei protagonisti di Un giorno verrà. Siamo in due contesti storici diversi, ma entrambi i personaggi si dimostrano anarchici a tutti gli effetti, cercando la propria identità attraverso la politica e la spinta sociale. Lupo e Mariano lasciano un piccolo paesino, un contesto familiare di disagio e una figura genitoriale ingombrante. La loro vicenda ha una struttura circolare: vanno via per tornare con una propria identità e un approccio diverso alla famiglia. In questo senso è possibile definire la storia di Mariano come una storia di formazione all’interno di una storia di deformazione? E quanto incide nell’involuzione di Gaia la fuga del fratello che la lascia sola a combattere una battaglia che era loro?
Ho ritenuto necessario esplorare ancora il personaggio del militante politico, ed è in questo senso che Mariano è un residuo del romanzo precedente. La questione è: come un giovane ragazzo, o ragazza, si può avvicinare alla politica e sentirla come una presenza vitale? La politica comporta una scelta di campo tra la vita privata, dunque la famiglia, e la partecipazione attiva, soprattutto nella militanza anarchica del momento storico vissuto da Lupo. Mariano è il Lupo dei nostri tempi, e mi ha permesso di indagare un tema fondamentale come il cambiamento dell’attivismo politico nel corso degli anni, e il rapporto tra vita e politica riconsiderato nella nostra società del consumo caratterizzata dall’iper-capitalismo.
Mariano è sicuramente il personaggio positivo del romanzo, quello che riesce a trovare una propria identità nel collettivo. La parabola di cui parlavo prima a proposito dell’identità di Gaia sembra mangiarsi la coda, quella del fratello, invece, proiettata verso l’esterno attraverso la ricerca di un luogo comune e una collettività di idee, è sicuramente costruttiva. La sua fuga poi rappresenta un punto di rottura importante nel romanzo. È questo uno dei momenti in cui la vita di Gaia prende un’altra direzione: si sente abbandonata, in primis nella lotta ad Antonia, donna forte e piena di idee, ma anche capace di schiacciare i figli. Mariano era l’elemento di contrasto in una situazione in cui la sorella non riesce a ribellarsi, né con le parole né con i fatti, a quella famiglia che lei stessa definisce «il suo anestetico».
Una delle considerazioni più diffuse su questo romanzo è che i luoghi sono protagonisti. Piuttosto che sui luoghi, però, vorremmo puntare l’attenzione sugli oggetti, in particolare su quelli che ritornano nel corso della narrazione: il vocabolario, l’orso rosa, la maglietta di Superman. Gli oggetti diventano in qualche modo una nemesi di coloro che li possiedono e, quindi, quanto possono essere un presagio materiale di ciò che sta per accadere?
Gli oggetti sono fondamentali, in certi casi simbolici più dei luoghi, perché questa è una storia sul consumismo. Essi hanno un ruolo significativo nella vita di Gaia come indicatori del suo percorso. Rimangono e tornano. Centrale è il vocabolario, ovvero il primo “libro” davvero suo, non come quelli presi in prestito dalla biblioteca del paese. Il vocabolario, però, è anche l’oggetto che la tradisce, che la convince che conoscendo più parole sia possibile definirsi meglio e trovare una strada diversa. Se ci pensiamo è un oggetto diventato ormai obsoleto, da quando il web ha preso il sopravvento, così come le parole: a volte a Gaia sembra che quasi non esistano più, che non siano più significanti e non abbiano un ruolo nella vita delle persone. Insomma il vocabolario è lei, che sente di non avere un ruolo nel mondo. Poi c’è l’orso rosa, l’animale finto della storia, vinto sparando a una fiera di paese. È un oggetto del tutto inutile, emblema del superfluo, della plastica: non c’è niente di più inutile di un orso rosa che non è neanche il tentativo blando di riproduzione dei colori naturali dell’animale. La maglietta di Superman è invece un regalo della sua amica Carlotta. Gaia la nasconde sperando di occultare con essa anche questa amicizia scomoda e terribile. I superpoteri che lei e le amiche avevano immaginato di avere, però, tornano nel corso della sua vita, quasi come se in fondo al nostro armadio continuassimo a ritrovare qualcosa che abbiamo provato a dimenticare. Ed è per questo che lei rindosserà quella maglietta per compiere uno dei gesti più agghiaccianti all’interno del romanzo.
A proposito dell’orso rosa, sembra un totem della violenza. È il primo oggetto che Gaia vince, e diventa suo sparando. Ovviamente parliamo di una pistola finta, ma nonostante questo quando la impugna sente tornare a galla tutta la rabbia provata fino a quel momento. Nel libro sembra esserci un’ascesa della violenza della protagonista: si parte da una racchettata sul ginocchio di un compagno di classe alle scuole medie, data per vendicarsi di uno screzio subito, fino ad arrivare al quasi omicidio. Come ha lavorato a questo climax in fase di stesura e, successivamente, durante l’editing?
Lo avevo immaginato da subito, già nella prima scaletta. Confesso che io devo per forza lavorare su una struttura prima di scrivere, non vado mai a braccio, perché quando ho provato a farlo in passato mi sono sempre persa. È come entrare nel bosco senza lanterne, a un certo punto sei in una radura e ti chiedi: «ma io da dove sono arrivata?» Per la stesura de L’acqua del lago non è mai dolce avevo forti dubbi sulla possibilità dell’omicidio, e ho dovuto costruire in base a quello il finale del romanzo. Ho optato per una chiusura interpretabile, lasciando da parte quella cesura netta che già avevo adoperato per i singoli capitoli. Devo dire che dal punto di vista dell’editing, con la mia editor Giulia Ichino, non abbiamo toccato la struttura o i contenuti, ma piuttosto lavorato sulla scrittura e su alcuni inserimenti nella parte finale. Giulia mi ha aiutato a introdurre dei momenti di vaga morbidezza, come dei piccoli cuscinetti per tentare di ammorbidire alcuni punti. Temo di non aver ammorbidito troppo alla fine, ma era una operazione necessaria per evitare la perdita totale dell’emozione e un eventuale disseccamento nella parte finale.
Riguardo la scrittura, si può dire che il suo è un registro alto e specialistico, che varia moltissimo a seconda dei temi e dei periodi storici trattati. I suoi due primi romanzi sono narrati in terza persona, così come il suo racconto del 2017 a cui questo romanzo deve il titolo, e in essi è evidente un forte sperimentalismo linguistico che emerge attraverso l’utilizzo di metafore e ripetizioni. Con L’acqua del lago non è mai dolce passa alla prima persona, al presente, e a una «finta auto-fiction» (così come lei l’ha definita). Quanto la lingua si è dovuta piegare a questa operazione e quanto è stato fondamentale, in tal senso, il suo lavoro di editor?
La lingua non si è dovuta piegare ma ho dovuto farlo io nelle decisioni iniziali da prendere rispetto al testo. Il tempo verbale e la persona parlante sono stati per me lo scoglio più alto perché di natura sono portata a scrivere in terza persona e al passato remoto. È la narrazione in cui mi trovo più a mio agio. Spostare questi due piani, fondamentali nella costruzione narrativa, e modificarne l’impianto, è stata la parte più difficile. Per quanto riguarda la scrittura avete evocato i racconti, che per me sono possibilità di sperimentare nuove forme e nuovi temi. Lì cedo alle sensazioni del momento, cerco di adoperare la lingua in modi diversi, utilizzo un linguaggio anche surreale, immagino delle dimensioni più oniriche. Quindi, in questo caso, la lingua più che averla piegata l’ho liberata. Avevo una voce da riempire, e dovevo farlo tentando di creare un’identità per questa ragazza parlante.
Il mio lavoro di editor, poi, mi ha aiutato molto negli anni più che nell’ambito linguistico, in quello della pulizia formale e nel controllo dell’equilibrio tra i registri, in particolare tra il vezzo, quindi l’eccesso di stile, e la scrittura, che è al servizio della trama, dell’ambientazione e dei personaggi. Perché se è vero che lo stile va liberato, è vero anche che deve necessariamente esserci controllo per evitare di cadere in un esercizio di stile, e se si vuole creare un equilibro tra lo stile e la costruzione narrativa, si deve provare a trovare un punto di incontro tra questi due momenti.
Altro cambiamento evidente è il rapporto tra microstoria e macrostoria. Se in La grande A e in Un giorno verrà la macrostoria è protagonista, in questo romanzo resta dietro le quinte, influenzando però comunque la vita e le scelte dei personaggi. Pensiamo ad esempio a Mariano e alla sua partecipazione al G8 di Genova. Come è riuscita a invertire la tendenza rispetto ai romanzi precedenti?
Venendo da due romanzi storici, mi sono interrogata sul rapporto tra i protagonisti e la storia. La protagonista de La grande A, Giada, in maniera inconsapevole è parte di un evento storico molto lungo, la colonizzazione e la decolonizzazione dell’Eritrea. Tutto è vicinissimo a lei ma, seppur conscia di essere un’italiana bianca che fa parte di un’azione violenta in quei paesi, alla fine resta ignara. Un giorno verrà, invece, è un libro in cui la storia piomba addosso ai protagonisti che, nonostante questo, riescono ad avere un ruolo attivo e di risposta agli eventi. Questo è vero soprattutto per Lupo e lo dimostra la sua presenza agli eventi salienti della storia del movimento anarchico, tra cui gli scioperi legati alle leghe contadine e alla ridiscussione dei patti mezzadrili, alla Settimana Rossa, e ai fatti di Villa Rossa. Stesso discorso per suor Clara che, pur rinchiusa nel convento in cui vive, percepisce la grandezza del momento riuscendo a diventare punto di riferimento sia per la comunità interna delle consorelle, sia per quella esterna del borgo marchigiano di Serra de’ Conti.
Mi sono chiesta, quindi, come la mia generazione ha vissuto gli eventi storici, e mi sono resa conto che molti di questi sono stati semplicemente osservati da una certa distanza perché intanto sono cambiati i mezzi di comunicazione. Il poter vedere e rivedere all’infinito un episodio online, o in televisione, gli fa perdere il suo significato di evento che sta accadendo e che ci sta accadendo. Quando avevo quindici anni ciò che accadeva non veniva discusso tra noi ragazzi, e io stessa non sentivo il bisogno di chiedere spiegazioni. Il momento di una presa di coscienza collettiva è completamente mancato. Ecco perché stavolta ho preferito mettere gli eventi sullo sfondo. Mariano è a Genova, come Lupo a Villa Rossa, ed è lì mentre l’evento accade, divenendone così uno degli attori. Gaia invece è a casa, e nonostante percepisca quella manifestazione come un pericolo per il fratello, non arriva mai a domandarsi in cosa sia coinvolto. È proprio questa distanza che volevo provare a raccontare. Gaia è interessata soltanto, come scrive Giulia Echino nella bandella, al «piccolo cabotaggio degli oggetti posseduti o negati», ai piccoli e grandi dolori che riguardano la sua giovinezza.
In un’intervista uscita il 19 febbraio su “7” lei ha parlato insieme a Mattia Insolia della nostra generazione come quella di chi ha dedicato quindici anni alla propria formazione, con enormi sacrifici sia nostri che dei nostri familiari, per poi rendersi conto di non avere nulla in mano. Ci interfacciamo di continuo con una totale assenza di meritocrazia, e questo è evidente soprattutto per chi ha scelto un percorso umanistico, come si accennava poco fa. In questo senso possiamo dire che la vicenda di Gaia restituisce al lettore uno spaccato delle difficoltà incontrate dalla nostra generazione nella ricerca del proprio posto nel mondo, e soprattutto nel mondo lavorativo?
Io spero di sì. Quello che volevo era farlo attraverso un io narrante che si confessa con il lettore, omette o mente, ma comunque si interfaccia senza alcun intermediario. Ed è proprio attraverso questa mancanza di intermediazione che volevo creare un rapporto simbiotico con chi si ritrova tra le mani questo libro, e di conseguenza una vicinanza emotiva che può trasformarsi sia in un tentativo di comprensione, sia in disturbo o fastidio.
Il mio obiettivo era parlare di quel momento in cui dopo aver studiato, seguito un percorso, fatto delle scelte, ci si rende conto che queste non porteranno quasi a niente, e che senza una famiglia che sostiene nessuno ha la possibilità di fare ciò che pensava e sognava di fare. Molto banalmente è così. Non è una lettura, ma ciò che sta succedendo, che ha cambiato il mondo della scuola e del lavoro, che ha incrementato la forza, l’attrattiva e la sensualità dei lavori virtuali perché di più facile accesso anche a chi non ha studiato, e perché presentano delle possibilità di carriera riconducibili alla forza e alla capacità del singolo piuttosto che al dover essere riconosciuti e assunti da altri.
L’articolo con Mattia è stato percepito come il lamento dei trentenni che non hanno voglia di fare nulla e che passano l’intera giornata in panciolle a disquisire delle difficoltà della vita. È giusta la lotta e la ricerca di chi ci ha preceduto, ma qui siamo dinanzi a una bugia. Ci è stato detto, da sempre, che facendo la nostra parte, ovvero la formazione scolastica, avremmo ricevuto in cambio qualcosa. Se questo fine ultimo diventa utopia allora lo stesso percorso viene meno. Io vorrei che il mio libro non fosse designato come un grande lamento, ma come un tentativo letterario di parlare di temi che ci riguardano. Forse attraverso un romanzo è più semplice sentire un sentimento sociale che altrimenti non si riesce a percepire se non ci capita in prima persona.
Assolutamente è così, lo spaccato che viene restituito è tragicamente vero.
Passiamo invece ora a Giulia Caminito inserita nel contesto letterario attuale. Teresa Ciabatti ha definito L’acqua del lago non è mai dolce come il romanzo che avrebbe voluto scrivere lei. E in una successiva intervista rilasciata a Il Libraio ha dichiarato, riferendosi alla generazione di scrittori giovani di cui lei fa parte ˗ insieme a Mattia Insolia, Fuani Marino, Josephine Signorelli ˗, di sentirsi tranquilla come madre perché sa che sua figlia potrà crescere leggendo una letteratura di valore. Che effetto le fa sapere di essere in gara con questa scrittrice che ha una così grande stima di lei?
È una stima che io ricambio. E sono molto grata a Teresa per le occasioni che ha dato a me e al libro in maniera molto sincera e diretta. Lei ha questo sguardo e questa curiosità, che non è da tutti, nei confronti delle persone giovani che scrivono. È un suo modo quasi di adottarli, di far sì che vengano notati, ed è una cosa importante perché non è scontata e non fa così parte del mondo della letteratura. Io, ad esempio, leggo moltissimi autori giovani perché organizzo un festival dedicato alle scuole e agli scrittori e alle scrittrici sotto i trentacinque anni, e devo dire che il panorama è molto florido. Si scrivono cose interessanti e molto diverse tra di loro: si cerca di parlare del contemporaneo ma anche del passato, c’è un tentativo di riscrittura del tradizionale romanzo storico, ci sono più generi che si incontrano, dal distopico all’esoterico, dall’unione con la botanica alla scienza, l’esplorazione dell’auto-fiction e dei contesti di periferie. C’è molta ricchezza, e leggo i miei coetanei per lavoro ma anche per piacere personale. Il Premio Strega non lo vivo come una gara, siamo qui con i nostri libri e non possiamo fare altro che aspettare e vedere cosa succede. Io la vivo così.
Revisione a cura di Manuela Altruda.