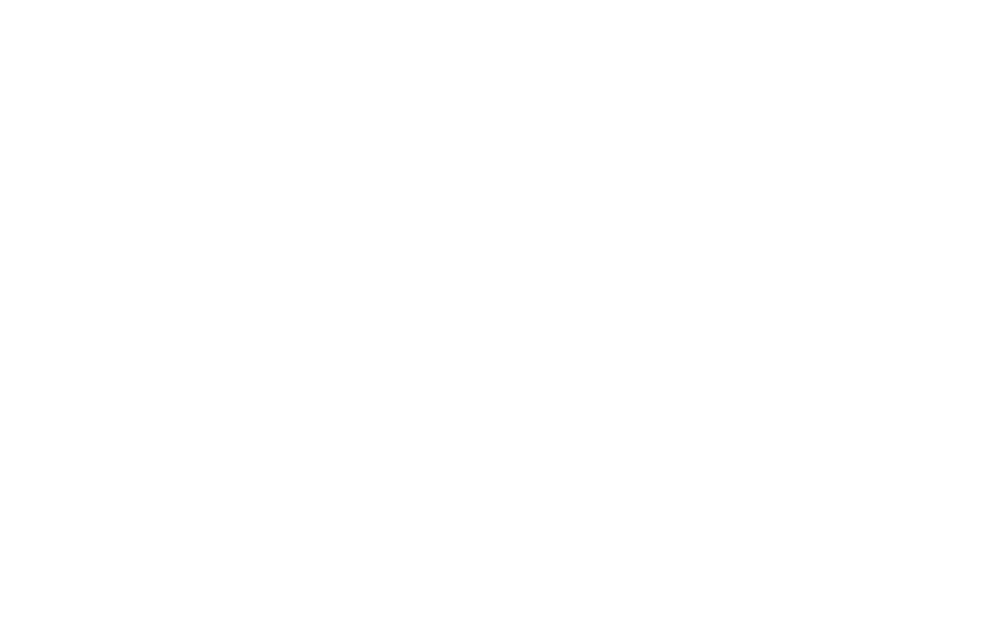A cura di Enrica Alessandro, Marika Lanza e Demetrio Marra (Scuola del libro), Sofia Martino (I.I.S Edoardo Amaldi di Roma) e Alessandro Marrelli (Convitto Nazionale Giordano Bruno di Maddaloni).
Dicembre 2018, intervistata da una tv locale sul suo ultimo libro, una scrittrice di successo, guardandosi riflessa, ritrova un’altra sé e ripensa a quanto sia cambiata, a ciò che l’ha portata lì. Pensa agli anni del liceo, all’inadeguatezza, alla scarsa capacità di comprensione dei suoi compagni e della sua famiglia. L’emarginazione, la voglia di sparire e deflagrare, le debolezze, hanno portato la scrittrice a vivere nella voglia di rivalsa. Quei ricordi di adolescente non sembrano più così lontani quando la sua unica amica del liceo la contatta per riallacciare i rapporti: riavvicinandosi a Federica, inizia a rivedere anche la sorella di lei, Livia, che trent’anni prima era stata l’oggetto del desiderio di tutti i ragazzi della scuola. Bellissima ma con un carattere indocile e spavaldo. Livia smette di essere tutto ciò, dalla notte dell’incidente che, causandole una lesione al cervello, ne imbriglia il tempo. Frequentandola in questa nuova veste di farfalla danneggiata, la protagonista di questo viaggio transgenerazionale si ritroverà a essere al contempo madre e figlia, carnefice e vittima, portandoci nel suo imponente castello di carta in cui finzione, menzogna e bellezza si mescolano: uno sfiancante gioco che ai partecipanti/lettori ricorderà persino la vita.
Il suo libro non è il racconto di una vicenda, ma l’interpretazione continuamente ritrattata della vicenda stessa. Questa forma di racconto si scontra con la paura capitale, l’essere fraintesa, che diventa col tempo certezza: sa che verrà fraintesa. Allora: il fraintendimento diventa il suo modo di guardare alla realtà. Se parla di “auto-fiction di posa”, in un’intervista, è perché si muove all’interno del fraintendimento, esponendolo?
Questo è un elemento che mi sta molto a cuore. La narratrice sottolinea spesso che si tratta di una storia vera. All’inizio c’è un’avvertenza che dice “i fatti e le persone di questo libro sono tutti reali tranne l’età di mia figlia e altro”. Quell’altro in realtà è tutto, la chiave di lettura del romanzo. Il presupposto è che sia impossibile restituire la verità, che resta sempre soggettiva. Questa narratrice inattendibile approfitta del fatto che non c’è una verità assoluta e quindi gioca con il lettore, sfidandolo di continuo. È un’operazione molto ragionata, c’è grande consapevolezza dietro. Mi sono interrogata tanto su quanto la veridicità di una storia sia un bollino di qualità. Pensiamo al racconto televisivo, o cinematografico, è come se stimolassero l’identificazione, grazie a una partecipazione immediata di chi legge, guarda, o ascolta, provocando delle reazioni più accorate. Uno degli stimoli per la mia scrittura è la narrazione televisiva dei fatti di cronaca, e i commenti dei telespettatori che partecipano con foga come fosse una vicenda che riguarda loro, perché, essendo veramente accaduta, ha quella garanzia di realtà che li tira dentro. Allo stesso modo, io vorrei tirare dentro i lettori, ingannandoli attraverso una narrazione che dà loro illusioni di corrispondenza. Più volte lungo la storia sono seminati dettagli che contraddicono la narratrice, è lei stessa a farlo. A me interessa questo tipo di letteratura perché credo che sia un modo di prendersi delle responsabilità, mi interessa meno mettermi al di sopra del narratore, dalla parte della giustizia e del bene, e raccontare il male con distanza. Quello che cerco di realizzare con la scrittura è di farmi carico, con un alter ego, della complessità, com’è tematizzato nel prologo, dove parlo di vittime, carnefici e donne abusate. Non sono storie che riprendo in seguito nel romanzo, perché quello che volevo mettere in rilievo è che non ci sono ruoli fissi: vittima e carnefice non sono sempre distinguibili, purtroppo tante volte si sovrappongono. In questo senso, la letteratura, a differenza della televisione che ha sempre bisogno di raccontare per opposizione, ha il dovere di soffermarsi su questa terra di mezzo dove non tutto è facilmente riconoscibile.
Una frase di Tommaso Landolfi recita: «il pensiero ci tradisce… la voce stessa mi tradisce». Non solo il pensiero tradisce il mondo, ma anche la voce tradisce il pensiero. Sembra che il suo procedimento di scrittura sia questo. Prima c’è un fatto che si finge sia reale, poi anche la dizione e la ricezione di quel fatto.
Sì, poi questo aspetto si intensifica. Si parte da un personaggio che viene dato come reale, un personaggio mediocre, meschino, fastidioso. Immedesimarsi in quell’umanità, per così dire media, è umiliante. Ci sono tutti gli elementi per respingere il lettore e sfavorire l’identificazione. Però quello che voglio fare è portare il lettore dentro la storia, farlo calare in quell’umanità. È un modo per avere un effetto non consolatorio. La letteratura, per me, non deve essere consolatoria.
Nel libro è descritto molto bene il contrasto tra la bellezza apparente delle persone e quella che verrà riconosciuta soltanto dopo, non solo dagli altri, ma anche da sé stessi. In una società basata sui social è possibile, secondo lei, eliminare quel senso di inadeguatezza che spesso limita la manifestazione della nostra personalità?
La mia è una scoperta tardiva. I giovani hanno tutto il diritto di avere paura, di provare vergogna, perché questo ha un grande valore di scavo interiore. La bellezza è come la verità, è in continua mutazione, inafferrabile. La percezione che abbiamo di noi stessi genera conflitto, e ciò non dipende dalla bellezza oggettiva, ma dal tempo e dalla crescita. L’adolescenza è il primo momento in cui si entra in conflitto con sé stessi perché, come è spiegato nel libro, è necessario abituarsi a un corpo che non è più quello di una bambina o un bambino. E così anno dopo anno, perché ogni età ha il suo cambiamento. Io cerco di dare sempre voce a personaggi che vivono il corpo come un ingombro da cui non riescono a liberarsi. È grazie a tutta la vergogna e al senso di inadeguatezza che ho provato da bambina e da adolescente che sono diventata scrittrice. Quindi non vorrei una società di ragazzi che si piacciono tantissimo e ho paura, al di là dei messaggi positivi che riguardano l’amore verso sé stessi, che possa venir fuori una generazione di invasati, mentre invece queste inquietudini danno profondità all’essere umano. Detto ciò, l’adolescenza è il periodo più brutto che ci sia. Voi giovani avete diritto a soffrire, però sappiate che è comune, è trasversale a tutte le epoche e non riguarda la bellezza, è indipendente dal corpo. Infatti nel libro la protagonista scopre che tutti hanno sofferto, anche i più belli e i più privilegiati. C’è una frase di Aldo Busi in Seminario sulla gioventù, che dice: «Cosa resta di tutto il dolore che abbiamo creduto di soffrire da giovani?» In quel «creduto» c’è tutto. Di nuovo torniamo al percepito, ma quello conta, non è importante quanto sia reale. Nella storia, le protagoniste Federica e Livia sono molto preoccupate dello spazio da loro occupato. Trent’anni dopo si capisce che non erano così enormi come credevano. Ma non conta, ciò che conta è il loro percepito, il loro vissuto.
In un’intervista, rilasciata alla Fondazione Circolo dei Lettori, parla di 47 riscritture. Ci racconti del processo di editing e del rapporto che ha avuto con gli editor con cui ha lavorato.
Per me la scrittura è tantissima dedizione, tantissimo esercizio. Comincio a scrivere al mattino presto e continuo fino a sera, intorno alle diciotto. Butto via molto, salvo una pagina al giorno, se va bene, ma di solito nemmeno quella. Quando ho consegnato il manoscritto di Sembrava bellezza,ero alla quarantasettesima riscrittura. Il rapporto con gli editor per me è fondamentale, primo perché dopo così tante riscritture, che sono poi stratificazioni della storia, arrivo per gradi all’essenza, ai significati. Impiego molto tempo per padroneggiare tutta la materia. Alla fine, quando consegno, ho perso, forse, molta lucidità.
L’editor è fondamentale perché è lo sguardo esterno che ti rimanda la comprensione, il senso del lavoro fatto. Io ho lavorato con Marina Rossi e Albero Rollo, e insieme abbiamo accordato tutto il romanzo. Forse il momento più importante per uno scrittore è la messa a fuoco di tutti gli elementi che compongono la storia perché, in genere, c’è molta dispersione, si ha la tentazione di fare digressioni a vuoto. E il compito dell’editor è esattamente questo, riportarci al senso della storia, al fuoco, che quasi mai è chiaro fin dall’inizio.
Per scrivere questo libro sono partita dal personaggio di Livia, un personaggio fermo nel tempo, come altri di cui mi piace raccontare. L’archetipo è quello di Miss Havisham di Grandi speranze che rimane ferma immobile a trent’anni prima, al giorno che precede il suo matrimonio, quando viene lasciata sull’altare.
Se riguardo tutti i miei libri passati, c’è sempre questa distanza: nessun personaggio vive in perfetta sincronia con il tempo reale, è sempre in ritardo. Ne La più amata la protagonista era ferma all’infanzia, qui invece è almeno quindici anni indietro rispetto al suo tempo.
Livia è un simbolo di questo rifiuto del trascorrere del tempo, anche se nel suo caso non si tratta di difesa psicologica intenzionale. Livia è danneggiata e rimane ferma ai suoi diciassette anni. Un altro archetipo del personaggio si trova in Il padrone di Goffredo Parise: il protagonista, la cui vita privata è sotto il controllo del suo datore di lavoro, viene spinto a sposarsi con Zilietta, una donna con difficoltà cognitive, che dopo il matrimonio rimane incinta. Lui si augura che il bambino somigli alla madre, che abbia la sua stessa inconsapevolezza e che, addirittura, abbia la coscienza del barattolo che in quel momento la madre tiene tra le mani, perché solo così nessuno potrà fargli del male. Per me questa è stata un’illuminazione, ha arricchito il personaggio di Livia che avevo in testa. Volevo qualcuno rimasto fermo laggiù, al momento dell’incidente, che non avesse il carico della memoria. Livia è l’unica di tutti i personaggi, di queste donne, di queste ragazze, a mantenere la giovinezza e la bellezza, perché è l’unica a cui ogni mattina vanno ricordati i lutti, il dolore vissuto, il tempo passato, la vita trascorsa, gli ultimi trent’anni. Così Livia è l’unica che può permettersi di volteggiare col palloncino e di muoversi e parlare come una sedicenne bellissima, leggera e spensierata.
C’è anche un fatto di cronaca che mi ha influenzato nella costruzione di questo personaggio. Una donna australiana viene operata all’anca, i medici si accorgono che non avverte il dolore, la esaminano e scoprono che ha un’alterazione del DNA che la rende insensibile al dolore fisico. Quando le chiedono come sta, che vita ha vissuto, lei risponde di aver trascorso una vita molto spensierata e smemorata. La sua esperienza mi ha fatto ulteriormente riflettere sul legame che esiste tra memoria e dolore.
Da Sembrava bellezza emerge che in qualche modo le interviste che la protagonista conduce, per esempio, con le ragazze di Palazzo Francisi a Todi e con il Centro di medicina del sonno di Bellaria, si leghino profondamente alla sua ricerca narrativa. La collaborazione con Il Corriere della Sera rientra nel suo progetto di scrittura?
Sì. I reportage (che nel romanzo nessuno accetta, ma nella realtà sono stati pubblicati sul Corriere della Sera) erano, ritornando al discorso del fuoco, racconti sul corpo e sul desiderio di sparire; quindi, per esempio, le ragazzine anoressiche rappresentano, a un grado diverso, il desiderio di tutte le ragazze di questa storia. Viene detto nel libro che è come se fosse un’unica ragazza trasversale, che va dagli anni Ottanta a oggi, e oggi l’ultima ragazza che si incontra nella storia è la figlia della protagonista, Anita, che ha ventitré anni. Tutte queste ragazze manifestano il desiderio di sparire. Un simbolo di questo desiderio è la figura di Emanuela Orlandi. Anche Livia, come si scoprirà trent’anni dopo, era mossa dal desiderio di non esserci più. Le storie del reportage sono vere, ma lo sono anche quelle rielaborate e manipolate, sia da loro, che da me che le raccolgo; quelle ragazzine stavano dicendo la stessa cosa dei personaggi del libro, che volevano sparire, non volevano crescere, e ho trovato molto interessante che tutto questo avvenisse in un momento preciso, ossia la pubertà, quel momento in cui fisicamente stanno diventando donne. Quasi tutte le bambine sviluppano il rifiuto di crescere e di diventare qualcuno di diverso. Io credo che sia profondamente legato al femminile e allo spazio: quanto spazio occupa una donna? Che ruolo ha una donna nella società? Volevo quindi dare voce a tutte le ragazze che desiderano fermarsi, non avere uno spazio né un ruolo. Poi, il lavoro del Corriere della Sera, le interviste, i reportage sono come tappe, capitoli che mi portano al libro successivo, anche senza rendermene conto.
La protagonista è, come l’ha definita, una donna anaffettiva e inquieta, ma allo stesso tempo prigioniera e colpevole. È facile immedesimarci in questa figura ambivalente che si mette a nudo, anche se le sue confessioni suscitano quasi un bisogno di difesa quando toccano corde profonde. Cosa comporta esporsi in questo modo attraverso la scrittura? E come si mantiene quella distanza tra la voce narrante e la sua persona?
Questo è un problema che è nato con La più amata, dove ho sulla pagina una sorta di alter ego, come fosse un’idealizzazione malefica di me, ma ancora più accentuata.
Io sono stata una ragazzina che ha vissuto poco. Non sono mai stata protagonista di qualcosa, nemmeno nelle storie d’amore. Rimanere in disparte a fare da testimone delle vite altrui mi ha fatto sviluppare la capacità d’osservazione del narratore e, nonostante questo, ancora oggi spesso non riesco a reggere il conflitto, così cerco di evitarlo. Perciò nella vita, soprattutto dall’adolescenza in poi, ho accumulato tante parole non dette, reazioni non avute e gesti non compiuti che avvenivano nella mia immaginazione. Nel libro rivendico questa cosa, come anche nella vita. Secondo me, l’immaginazione vale da esperienza. Allora tutto quello che non ho fatto, che non ho avuto la forza, il carattere, il coraggio, la sfrontatezza di dire e di fare è diventato un personaggio. Ovviamente si crea un cortocircuito, addirittura ne La più amata la protagonista si chiama come me e spesso venivo insultata sui social. Ma era giusto così, perché l’esperimento lo prevedeva. In questo ultimo romanzo succede di meno, però si innesca la stessa dinamica. È ovvio che è pericoloso, perché rischi di essere creduta e fraintesa; però, se dopo La più amata ero spaventata da questo fraintendimento, ragionandoci tanto, ho deciso di riprendere questa voce sguaiata, perché penso che abbia la forza di scuotere, anche di infastidire. Penso che la letteratura, o meglio quella che interessa a me, debba infastidire e andare a stanare le persone. Noi siamo fatti di bene e di male, di ombre e di luce, quindi se, per esempio, la televisione non può farlo e ha bisogno di raccontare necessariamente per categorie, la letteratura può rivelare la complessità presente in ogni essere umano, il carnefice e la vittima nella stessa persona. Ormai ho un’età per cui l’essere fraintesa non ha conseguenze così disastrose. La mia è una vita talmente noiosa, che non mi scombussola più di tanto, non c’è il rischio che mi confonda e agisca come quel personaggio, anzi sfogo tutti i lati neri liberandoli nella scrittura.
Prima parlavamo di televisione. Guido Piovene nella prefazione a un libro di Henry Miller (Arte e Oltraggio, 1960) ha scritto che «esistono due tipi di moralismi, uno nel senso della libertà, uno nel senso della censura». Sembra che quello che lei ha detto si possa leggere attraverso questa opposizione. Il problema della comunicazione pubblica è che deve avere un moralismo nel senso della censura, nel senso dell’univocità di significati, mentre la letteratura è libera.
Io prima di essere una scrittrice sono una grandissima lettrice. Leggo molti classici, ma soprattutto leggo i contemporanei, soprattutto quelli della generazione più giovane. Ci tengo molto, e ne sono molto affascinata. La nostra identità è fatta dallo sguardo delle madri, dagli ammonimenti delle nonne, dalla frase dello sconosciuto, da una scena di un film, da una pagina di un libro. Mescoliamo tutto, per fortuna. Non capiamo nemmeno più quale sia l’origine, non ce n’è una sola, siamo un miscuglio, anche di materiali di scarto. Allora io credo che lo scrittore, il regista, l’intellettuale, debba guardare la televisione, perché la televisione aiuta a capire a che punto è l’immaginario collettivo e il linguaggio. L’errore che alcuni intellettuali fanno è quello di non guardarla, perché non vogliono affrontare la realtà.
Facciamo un discorso sulla lingua. Io cerco di restituirne la complessità, variando la persona, da prima a seconda, a terza, utilizzo le parentesi, cerco di eliminare le congiunzioni. Mi interessa non creare gerarchie, perché nel momento in cui si crea una gerarchia, cioè il nesso di causa ed effetto, o una logica precostituita, il linguaggio diventa politico, televisivo. È Salvini che dice: non dobbiamo accogliere i migranti perché rubano il lavoro agli italiani. E questo ha una sua logica. Ha un nesso di causa ed effetto che rispecchia una sua realtà, una sua gerarchia. Chi guarda e ascolta deve scomporre, se invece è pigro assimila questa logica già precostituita. E così anche la televisione. Molti scrittori non sanno che la loro lingua, quella letteraria, è diventata di dominio pubblico. Per me la letteratura non deve fare un passo indietro. Quello che vorrei fare è liberarmi della gerarchia che diffonde la televisione. Vorrei permettere al lettore di dare una sua interpretazione, senza che sia stata io a stabilire un ordine e senza pormi su un gradino più alto. E a proposito del fraintendimento continuo, credo che la letteratura debba, possa, fare anche questo, distanziandosi molto dal linguaggio politico e dal linguaggio televisivo, che invece stabilisce dei nessi, delle connessioni e te li restituisce, precostituiti.
Nel suo romanzo gli oggetti assumono un ruolo particolare. Ne compaiono vari: la foto, il tappeto azzurro, lo zaino a koala, il lettino solare, la camicia da notte rosa, sono tutti oggetti che, al pari dei personaggi, richiamano alla memoria eventi, emozioni e traumi. Che ruolo hanno gli oggetti nel suo romanzo? Ci sono degli autori a cui guarda con ammirazione che utilizzano gli oggetti in un modo che la affascina?
Questo è il correlativo oggettivo. Suscitare delle emozioni non attraverso il racconto delle emozioni stesse, ma attraverso l’oggetto. Mi viene in mente il modello di Bel-Ami. Nella sua scalata sociale gli oggetti segnalano un livello diverso. Possono essere i vestiti, le case, o addirittura le donne, fino ad arrivare al quadro che comprano i coniugi Walter, Cristo che cammina sulle acque, l’oggetto per eccellenza che segna l’apice della scalata sociale. Lo comprano, lo tolgono da una mostra e lo portano a casa. Così tutta l’aristocrazia di Parigi che loro hanno sempre guardato con desiderio è costretta ad andare a casa loro per guardare il quadro. Maupassant racconta benissimo la progressione di questa scalata sociale. Io uso spesso il correlativo oggettivo. Lo zaino a koala della narratrice è il simbolo dell’inadeguatezza, il lettino solare di Livia è l’oggetto di distinzione, di privilegio. Gli oggetti, raccontano tante emozioni, definiscono il carattere di un personaggio. Altre volte mi rendo conto di descrivere poco i paesaggi, se ci sono, fanno da sfondo. Per me gli oggetti più della descrizione fisica dicono molto, l’oggetto desiderato può raccontare per esempio, un’ambizione o una frustrazione. Per me è uno strumento fondamentale. È già di per sé un racconto.
Revisione a cura di Manuela Altruda